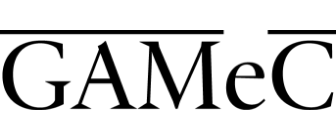ILARIA GADENZ
Vorrei cominciare dalle basi. Cosa si intende per antropologia ambientale? Che storia ha?
EMANUELA BORGNINO
L’antropologia ambientale è una disciplina relativamente giovane, anche se le sue radici affondano nei primi racconti etnografici dei grandi padri fondatori dell’antropologia, come Bronislaw Malinowski e altri, che già sottolineavano l’importanza del rapporto tra i gruppi umani e l’ambiente.
La natura è sempre stata parte del discorso antropologico, ma solo dagli anni Cinquanta e Sessanta si è iniziato a indagare in modo sistematico il rapporto tra cultura e ambiente. La disciplina si è sviluppata quasi contemporaneamente sulle due sponde dell’Atlantico: da un lato negli Stati Uniti, dall’altro in Europa, soprattutto in Francia con Claude Lévi-Strauss e poi con il suo allievo Philippe Descola, che hanno posto nuove domande sul concetto stesso di natura. Oggi l’antropologia ambientale si è ulteriormente ramificata: ci sono studi dedicati agli oceani, alle montagne, alle zone desertiche o silvestri. I campi di ricerca si moltiplicano, così come le domande che la disciplina si pone.
ILARIA GADENZ
Lei sostiene spesso la necessità di riconsiderare le rocce come natura. Ma, come Lei stessa scrive, in molte lingue, come l’hawaiano che conosce bene, la parola natura non esiste. Cosa è dunque natura per Lei e alla luce di questa fondamentale discordanza intorno al termine, perché insistere sulla rivendicazione ad includervi le rocce?
EMANUELA BORGNINO
Sì, è vero. Non solo in hawaiano, ma in molte lingue del Pacifico come il samoano o il tongano, non esiste una parola che corrisponda a natura. Anche in giapponese, il termine shizen è di introduzione relativamente recente. Lo stesso vale per le lingue native del Giappone: gli Ainu, a nord, e i Ryukyu, a sud, nell’isola di Okinawa, non hanno un termine per designare il concetto di natura. Questo però non significa che queste società non abbiano sviluppato un rapporto profondo e articolato con l’ambiente. Semplicemente non hanno sentito il bisogno di separare l’essere umano dal mondo circostante, come invece è accaduto nelle culture del cosiddetto Nord globalizzato (che un tempo chiamavamo Occidente). Da questa separazione nasce il bisogno di nominare ciò che sta fuori dall’uomo come natura e di collocare l’essere umano altrove. Come antropologa mi interessa capire non tanto l’assenza del termine in determinate culture, ma come queste società costruiscano un’epistemologia diversa, ovvero un modo differente di fare esperienza del mondo.
Il fatto che il termine natura esiste solo in alcune culture segnala una distanza tra umani e ambiente. Si tratta di una prospettiva antropocentrica, che tende a collocare l’uomo al centro e gli altri esseri — piante, animali, ma anche pietre, fenomeni atmosferici — ai margini. Noi antropologi ambientali non abbiamo ancora trovato un termine condiviso ma siamo d’accordo che non esistano solo soggetti umani e che esista invece una pluralità di soggetti – di agenti che compongono un ambiente – di cui gli umani sono parte. Scienziati, biologi marini o etologi preferiscono infatti parlare di sistema ecologico per un determinato luogo.
Perché dunque includere anche le pietre in questa pluralità? Perché non tutte le culture condividono le stesse categorie e così come non esiste ovunque la distinzione tra natura e cultura, non esiste sempre quella tra vivente e non vivente, o tra animato e inanimato. Il mio invito è di provare a uscire da queste dualità: meglio accettare un po’ di instabilità concettuale che restare imprigionati nei binomi. Anche la categoria del vivente non è così netta come crediamo. Se pensiamo alla nostra stessa cultura scientifica, parliamo della vita delle stelle, della vita media del celsio, di particelle che decadono. Qualcuno dirà che sono metafore sociali che ci aiutano a capire cosa studiamo ma forse anche noi riconosciamo una forma di vitalità in ciò che chiamiamo non-vivente.
Nelle lingue del Pacifico questa parola (non-vivente) non esiste, perché tutto è in qualche modo attraversato dall’energia vitale, che altro non è che l’inizio biologico delle cose. Tutto ha avuto una genesi sul pianeta, pensiamo ad esempio ai vulcani oceanici nati dalle profondità marine in un tempo geologico non umano.
Le pietre, anche se non tutte, in molte società sono considerate vive: si riconosce loro una capacità di sentire e di connettersi al mondo circostante, di avviare una forma di socializzazione. Molte delle società che studio non ritengono che le pietre pensino – d’altronde attribuire la capacità di pensiero alle pietre sarebbe ancora un modo antropocentrico di attribuire loro qualità umane. Ma si può dire che sentono, come sentono gli esseri umani. Ed è questa comune capacità di sentire che li mette sullo stesso piano, in una forma di comunicazione condivisa.
ILARIA GADENZ
In Cara Montagna provo ad allargare l’invito di Aldo Leopold a pensare come una montagna all’ascolto. Questo scarto, verso il pensare come la montagna – così come è emerso da altre conversazioni – implica un diverso rapporto con il tempo, un tempo espanso, profondo. Un tempo che può disorientare, perché ci mette di fronte a scale temporali difficili da comprendere, come quelle del cambiamento climatico. Ma è anche un invito a pensare in termini di sostenibilità, come scrive Ailton Krenak quando parla del principio delle “sette generazioni”, ovvero della necessità di pensare sempre in termini temporali molto più ampi rispetto alla propria vita. Lei ha parlato in passato della capacità delle pietre di vivere tempi sociali diversi. È un’immagine che mi ha colpita molto, può spiegare meglio che cosa intende?
EMANUELA BORGNINO
Provo a rispondere partendo da un po’ più lontano. Credo oggi sia sempre più difficile tracciare confini rigidi tra i diversi campi del sapere: scienza, filosofia, arte, studi ambientali, scienze sociali. Anche per i geologi e biologi è complesso mantenere una distinzione netta tra la materialità forte del mondo delle rocce, dei minerali, delle montagne – ovvero una brutale fissità – e la materialità “morbida” della biologia, più fluida e circolare. Questa difficoltà a separare ciò che, in fondo, si attrae, fa sì che le pietre entrino nelle narrazioni di molte culture – dal Sud America all’Oceania, dall’Africa all’Europa – in movimento. Nelle fiabe e nei miti, le pietre viaggiano, nel Pacifico si muovono sulle canoe, si trasformano, precipitano dal cielo. E quando trovano il loro posto nel paesaggio, si fermano per il tempo di alcune generazioni, fanno sentire la loro presenza nel mondo e fanno agire gli esseri umani. È in quel momento che nascono le storie. In questo senso parlo di socializzazione delle pietre, mi riferisco alla relazione tra pietre ed esseri umani e alla capacità di agire delle pietre stesse.
Le pietre ci aiutano a capire, grazie al loro peso, materiale e immateriale, che la sostenibilità è una relazione. È prendere, restituire, dare, ricevere, nutrire, essere nutriti. Alle Hawaii, dove lavoro da molti anni, instaurare una relazione con un elemento ecologico — una pietra, una pianta, un animale — significa prendersene cura, ma anche lasciarsi trasformare da quella relazione. Oggi parliamo spesso di indipendenza economica dalle energie fossili ma in natura tutto è interdipendente. Se vogliamo davvero parlare di ecologia, dobbiamo partire da questo: la sostenibilità nasce dall’interdipendenza. E l’interdipendenza può essere anche con le pietre. La convivenza con le pietre ci ricorda proprio questo: la possibilità di coesistere su scale temporali diverse. Le pietre vivono tempi sociali propri, più lunghi, ma non per questo estranei ai nostri. Anche se non sono modellate dall’uomo, ma dal vento, dall’acqua, dagli agenti atmosferici, esse partecipano al nostro stesso mondo. Condividere lo spazio e il tempo con le pietre significa riconoscere che anche loro fanno parte di una società più ampia, in cui umani e non umani coabitano e co-evolvono.
ILARIA GADENZ
Come si socializza questa capacità di farsi carico, di prendersi cura, e quindi anche di comprendere, di capire le pietre? Come si impara, nelle società da lei studiate, ad ascoltarle e capirle?
EMANUELA BORGNINO
Anche se ogni società ha le proprie modalità (nel Pacifico cambia da isola a isola), possiamo riconoscere alcune similitudini. Molte società ad esempio annoverano le pietre tra il vivente e le considerano come accumulatori di forza vitale. Una forza vitale che rimane connessa e che attraversa tutto il vivente. Le pietre comunicano attraverso questa forza vitale. Al contrario nelle nostre società tendiamo a considerarle oggetti, più che soggetti, e quindi non riconosciamo loro un’agentività. Ma nel momento in cui diciamo che le pietre sono e riconosciamo loro una soggettività, il tempo minerale e il tempo umano si intrecciano, entrano in relazione. Le pietre diventano allora elementi ricettivi delle trame umane, partecipano al mondo e fanno agire gli esseri umani – ad esempio attraverso i pellegrinaggi, non solo quelli religiosi come la Mecca, ma anche quelli verso particolari pietre considerate sacre o significative. In Giappone, ad esempio, esistono pietre famose che si vanno a visitare. Nel Pacifico ho assistito a cerimonie in cui alcune pietre vengono trasportate da un’isola all’altra per incontrare altre pietre, perché considerate parte della stessa famiglia: hanno delle cose da dirsi, da pietra a pietra. Nel 2019, durante una mostra sull’Oceania a Londra, molti visitatori provenienti dal Pacifico lasciavano alle pietre esposte dei messaggi — parole di incoraggiamento, di speranza, di nostalgia — come se le pietre chiuse nelle teche del museo fossero imprigionate, lontane dalla propria casa. Nel canto hawaiano della creazione, il Kumulipo, i polipi dei coralli nascono dall’oscurità primordiale come una delle prime forme di vita. Il corallo è dunque considerato l’antenato della vita hawaiana, sia biologicamente che spiritualmente. Allo stesso modo, in altre culture sono le pietre stesse a essere considerate antenati degli esseri umani: esiste una genealogia condivisa, un’appartenenza alla grande famiglia del vivente.
Questa connessione permette di sentirsi a vicenda, di vivere in relazione con le pietre. Ogni cultura la sviluppa secondo i propri codici, ma in tutte si tratta di una capacità di percepire e partecipare al mondo, non solo le pietre, ma il mondo che ci circonda, le acque, i venti, le nuvole — tutto è dotato di sensibilità e risponde alle azioni umane. È una conoscenza sensoriale, che nasce dal corpo e dall’esperienza diretta, dal vivere la relazione.
ILARIA GADENZ
Considerare le pietre come soggetti senzienti — e forse anche desideranti, dotati di passioni — a che tipo di implicazioni pratiche e politiche porta? Nella sua ricerca, quali effetti concreti osserva o immagina?
EMANUELA BORGNINO
Ci sono diversi autori che hanno riflettuto su questo tema. Penso ad esempio a Bruno Latour, che propone di allargare la democrazia all’oltre-che-umano, immaginando una politica capace di riconoscere un’agentività anche al non-umano.
Sul piano pratico, in diversi contesti vediamo l’incontro tra l’ontologia giuridica nativa e quella introdotta dalle potenze coloniali. Da questo dialogo nascono concetti come i diritti della natura, che mirano a riconoscere personalità giuridica a elementi naturali: un fiume, una montagna, un lago, una foresta. Per un’antropologa ambientale questo è un campo di ricerca straordinario, perché significa interrogarsi su quanto possiamo estendere il concetto di “persona”. Se una montagna o un fiume hanno personalità giuridica, allora possono essere citati in giudizio o citare altri. Ma come può farlo concretamente una montagna? Chi ha il diritto di parlare per lei? Chi può dire “so che cosa sente o cosa vuole questa montagna”?
Il concetto di diritti della natura è quindi molto interessante e c’è una letteratura ormai ampia — soprattutto in ambito australiano, sudamericano e indiano — che esplora le sue implicazioni. Naturalmente non mancano le difficoltà: si tratta di mettere in dialogo sistemi giuridici diversi, uno fondato su una visione individuale del diritto (come nel diritto romano), e uno che pensa invece il diritto in termini collettivi ed ecologici, come diritto di un ecosistema composto da molte voci.
ILARIA GADENZ
Mi sembra che, sia nel caso del riconoscimento giuridico della natura, sia nella Sua ricerca antropologica, emerga una resistenza culturale profonda: è difficile pensare che qualcosa di altro da noi possa avere voce o rappresentanza. Parlando dello statuto giuridico di una montagna, mi chiedo come si autorappresenta una montagna. Forse pensando in termini ecosistemici si può parlare di una rappresentanza diffusa?
EMANUELA BORGNINO
Esatto, si tratta proprio di una rappresentanza diffusa. Ogni cultura interpreta in modo diverso ciò che la montagna “vuole” o “desidera”. C’è però anche il rischio che questi diritti vengano strumentalizzati, come risposta tardiva a processi coloniali.
Spesso, la voce della montagna viene veicolata attraverso l’arte. Penso, ad esempio, al Mauna Kea, una delle montagne più sacre delle Hawaii, oggi al centro di un conflitto tra lo Stato e la popolazione nativa. In questo caso, poesie, canzoni, documentari, opere visive diventano modi per dare voce alla montagna. L’arte, la giurisprudenza e l’antropologia offrono quindi diverse modalità per far emergere queste voci. E non è mai una sola voce: anche all’interno di una stessa comunità esistono molte prospettive che veicolano il dialogo con la montagna o con le pietre.
Credo che questi dialoghi ci permettano di ripensare, da un punto di vista antropologico, il rapporto tra esseri umani e natura non più in termini dicotomici, ma in chiave di collaborazione, di alleanza, di partnership. Così diventa più facile accettare che il non-umano possa agire: cioè che che le pietre, ad esempio, non siano soltanto oggetti inerti, ma presenze che influenzano gli eventi. È una teoria che alcuni chiamano esternalista, in cui la capacità di agire alle pietre è riconosciuta attraverso la pratica sociale, come le visite ai musei o gli incontri tra pietre di cui parlavo prima. Le pietre, in questo senso, hanno storie da raccontare, desideri da vivere e anche un peso storico che agisce nelle relazioni con gli esseri umani. Riconoscere loro un’intenzionalità significa annoverarle tra i viventi e accettare che le formazioni rocciose possano entrare in relazione con noi, generando comportamenti, risposte e azioni osservabili.
ILARIA GADENZ
Che cosa ci attrae come esseri umani verso le pietre?
EMANUELA BORGNINO
Non credo di poterlo spiegare in termini universali. Il mio lavoro è raccogliere le storie culturali, i modi in cui ciascuna società risponde a questa domanda e restituirli nel loro pieno rispetto. Quello che emerge è che esistono molti modi diversi di relazionarsi con l’ambiente e questa diversità può garantire la sopravvivenza della nostra specie. Solo grazie alla diversità possiamo compiere scelte molteplici e trovare risposte differenti.
Il tempo minerale rappresenta una forma di esistenza a lungo termine, un modo di essere al mondo che si estende oltre la scala della vita umana. Nella maggior parte delle culture che frequento, le pietre — pur essendo al di là del tempo umano — partecipano alla riproduzione della vita e della cultura. È vero che ancorano le memorie del passato con la loro fermezza, ma allo stesso tempo si muovono con la storia e con i saperi locali, appartenendo sia al passato che al presente.
Questo è possibile perché si riconosce alle pietre di essere fatte della stessa materia di cui sono fatti gli esseri umani — e in fondo tutto il mondo vivente. Quando in molte culture che io frequento si dice “questa pietra è un mio parente” o “sono genealogicamente legata a questa pietra”, si afferma proprio questo: condividiamo la stessa sostanza. È una consapevolezza che potremmo chiamare ecologica e che i popoli nativi condividono da tempo immemore. Il linguaggio scientifico ci dice che le montagne, i fiumi, gli esseri umani sono tutti composti dalle stesse particelle subatomiche organizzate in modi specifici in un certo periodo in un luogo determinato. L’unica differenza è che le culture che io frequento mi parlano di legami genealogici e non di legami subatomici. Secondo me è questo che permette di riconoscersi parte della materia vivente e quindi di essere coautori delle storie passate, contemporanee e future in qualche modo, perché le pietre accompagneranno le varie società, sia dal punto di vista delle storie che vengono raccontate, dei luoghi, dei toponimi, sia dal punto di vista della costruzione materiale di parte della società.
Quello che Philippe Descola chiamava l’ecologia delle relazioni è un discorso ecologico che invita alla connessione con l’ambiente, con tutti i suoi elementi — con le montagne, i venti, le acque. È un’elaborazione culturale in cui l’ambiente non può essere dominato, perché l’essere umano ne fa parte e condivide la responsabilità di esserlo. Da qui l’assenza, in molte di queste culture, del termine natura: se fai parte di qualcosa, è difficile che tu debba nominarlo dall’esterno.
È una scelta di appartenenza che garantisce accesso a un sapere particolarmente ecologico — e oggi particolarmente preziosa, perché anche il Nord globalizzato sta iniziando a riconoscere che l’ambiente risponde alle sollecitazioni umane. Le esplosioni atomiche, l’industrializzazione, lo sfruttamento intensivo hanno avuto un impatto profondo sull’ecosistema planetario. Diventa allora urgente imparare ad ascoltare, documentare e comprendere la capacità dei non-umani di rispondere, come queste culture hanno sempre fatto.
Gli esseri umani modificano l’ambiente — un’isola, una valle, una montagna — ma è altrettanto vero che l’ambiente modifica noi. È una relazione reciproca, spesso inaspettata, che coinvolge elementi come il vento, le pietre, le montagne. Sono loro, in fondo, ad aver plasmato le culture dei luoghi in cui vivono.
ILARIA GADENZ
Questo riconoscimento genealogico richiede una prossimità fisica, una vicinanza concreta? Mi chiedo, ad esempio, come vengano considerati i corpi celesti o le rocce che gravitano nello spazio?
EMANUELA BORGNINO
È una domanda a cui non so rispondere. Se penso però alla navigazione nel Pacifico, i corpi celesti vengono considerati come alleati, partner, maestri. La navigazione oceanica, infatti, si basa su quella che viene chiamata bussola celeste: un sapere che nasce dall’osservazione diretta delle stelle, delle costellazioni, delle correnti, delle nuvole e di tutti gli elementi del mondo marino e atmosferico. Non posso generalizzare sul rapporto che le diverse culture che frequento, hanno con gli astri ma posso dire che — come per ogni altro elemento dell’ambiente — ciò che si cerca è una relazione. La collaborazione viene dopo. Ma prima c’è la costruzione di una relazione, che viene poi espressa nei racconti, nei miti e nelle pratiche sociali e che infine si traduce in azioni concrete, come la navigazione.
ILARIA GADENZ
Questa relazione con gli astri e i corpi celesti apre un capitolo interessantissimo anche per chi, come me, si occupa di suono e radio. Penso, ad esempio, alla capacità delle meteore di generare frequenze radio quando entrano in contatto con l’atmosfera terrestre, a segnare l’inizio di una relazione…
EMANUELA BORGNINO
Sì, certo. Il Mauna Kea, di cui parlavo prima, è un caso emblematico. È un enorme vulcano spento, la montagna più alta del Pacifico e per questo un luogo privilegiato per l’osservazione astronomica: oggi ospita già tredici telescopi e c’è il progetto di costruirne un altro, con una lente di trenta metri, il più grande del mondo. La popolazione nativa non è affatto contraria alla scienza o alla curiosità verso il cosmo, ma possiede già le proprie risposte. Per loro la vita nasce dalle profondità marine e la montagna è sacra perché rappresenta il punto più alto dell’arcipelago, ma anche una fonte vitale di acqua dolce — un bene prezioso in un mondo di acqua salata.
Non si tratta quindi di due ontologie che si scontrano, ma di due modi diversi di pensare e di immaginare il rapporto con l’ambiente. Gli hawaiani non rifiutano l’interesse per il cosmo — anzi, senza le stelle e le costellazioni non avrebbero mai potuto navigare e popolare l’intero oceano. La loro è però una forma di collaborazione che non ha bisogno di essere ricercata, perché è già data, vissuta e narrata.