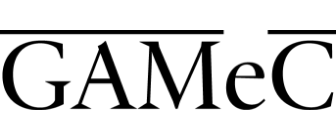Immaginiamo una parete piatta posta a una certa distanza: la sua posizione determina il ritardo con cui arriva l’eco, la sua superficie influisce sull’intensità dei suoni riflessi, mentre i materiali di cui è composta ne modulano il contenuto in frequenza. In questo modo la parete diventa udibile. Ma ogni ambiente è ben più complesso di una singola parete: l’apparato di ascolto umano – qualunque esso sia – è già naturalmente predisposto a cogliere molteplici sfaccettature grazie a un gioco di riflessi, risonanze e regolazioni continue con lo spazio circostante.
Le nostre orecchie, la nostra pelle, le nostre ossa, la struttura dei nostri corpi, il modo in cui ci muoviamo o non ci muoviamo sono progettati, infatti, per il mondo esterno dove la complessità di forme, materiali, voci, suoni e superfici offre una ricchezza di stimoli ben più intensa rispetto a quella degli spazi chiusi. All’esterno i nostri sensi si affinano e, nell’esercizio senza fine offerto dalle differenze e dalle stratificazioni, siamo sempre fisicamente parte attiva degli ecosistemi che abitiamo. Eppure, il più delle volte, ci limitiamo a pensare all’ascolto soltanto come sinonimo di cura, attenzione o empatia – evidentemente non più sufficienti per ristabilire assetti di equità e giustizia – ci soffermiamo sulla singola parete e ci limitiamo alle orecchie.