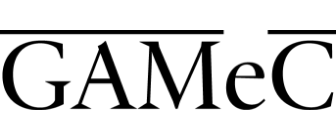VALENTINA GERVASONI
Per la creazione di Rien ne pourra nous séparer, hai avuto l’opportunità di esplorare il patrimonio naturale e culturale di Bergamo, a partire dall’Orto Botanico Lorenzo Rota in Città Alta. Tra le specie radicate nel paesaggio urbano di Bergamo, hai riconosciuto l’acanto, una pianta erbacea perenne che cresce spontaneamente anche a Tunisi, la tua città natale. Potresti dirci di più su come è nato questo progetto? C’è stato un episodio specifico, un’immagine o un incontro che ha acceso l’idea e ti ha spinto a iniziare questa ricerca?
YESMINE BEN KHELIL
Durante un progetto precedente, quando mi stavo concentrando sulle piante che crescono spontaneamente, mi sono imbattuta in una citazione che mi ha colpito. Raccontava la favola dell’invenzione del capitello corinzio da parte di Callimaco:
L’artista vagava per la campagna, forse pensando alle sue numerose opere; si fermò, commosso, davanti alla tomba di un bambino — una semplice pietra sulla quale la compassione di una madre aveva deposto un cesto pieno di frutta. Ma, affinché gli uccelli del cielo non venissero a divorare l’offerta riservata al caro estinto, una tegola era stata posta sull’apertura del cesto. Tuttavia, un acanto, germogliato lì, era cresciuto, e i suoi steli flessibili, bloccati nella loro ascesa dalla ruvida terracotta, si erano incurvati in spirali. (A. Jacquemart, Les merveilles de la céramique, cit. in L. Aragon, Henri Matisse, Roman).
Il fatto che la presenza dell’acanto sui capitelli fosse puramente casuale e che la sua creazione fosse legata a una storia di lutto e sepoltura era qualcosa che già mi interessava profondamente. Così, quando l’ho trovato a Bergamo, ho pensato che fosse una felice coincidenza e l’occasione giusta per esplorare il tema ulteriormente. L’idea di una favola che ne genera un’altra, ma anche di creare legami tra i miei nuovi lavori e quelli precedenti, è qualcosa che faccio spesso, anche se non lo rendo sempre esplicito.
VALENTINA GERVASONI
L’acanto è una pianta che porta con sé una ricca tradizione mitologica e popolare che converge in Rien ne pourra nous séparer. Le storie ad essa collegate si intrecciano con una serie di ulteriori traiettorie eterogenee: dal mito classico alla botanica, dalle storie mediterranee alle canzoni popolari di Sayed Darwish. Puoi dirci di più su questi riferimenti? In particolare, come la musica di Darwish ha iniziato a dialogare con gli altri elementi e come questi mondi apparentemente distanti hanno trovato un punto d’incontro e di conversazione nell’immaginario che hai costruito.
YESMINE BEN KHELIL
È stato attraverso un documentario sull’architetto egiziano Hassan Fathy, Il ne suffit pas que Dieu soit avec les pauvres (Non basta che Dio sia con i poveri, 1978) di Borhan Alaouié e Lotfi Thabet, che ho incontrato le parole di una canzone di Darwish:
I fiori del giardino sono sbocciati. Da essi scaturiscono profumi diversi. Eppure le piante sono nate dallo stesso suolo. E i semi piantati sono stati innaffiati con la stessa acqua. Mi chiedo, mi chiedo: com’è possibile che, da due rami nati dalla stessa pianta, uno strisci e si seppellisca, mentre l’altro sgorghi e fiorisca?
Attraverso questa analogia, la canzone di Darwish ha stabilito per me, in quel momento, un legame tra l’acanto e il pensiero di Hassan Fathy, per il quale l’architettura era inestricabilmente legata alla terra e al corpo in movimento che la abita. Per chiarire il mio pensiero: secondo Fathy, il cemento e la cosiddetta architettura moderna, importata dall’Occidente, avrebbero creato una struttura mentale che non avrebbe mai permesso agli abitanti delle periferie di affrancarsi dal centro, rafforzando così il persistere delle disuguaglianze. La sua visione, rivoluzionaria per l’epoca, si inserisce in questa idea secondo cui trarre ispirazione dalle piante e da altre specie viventi — nel loro modo di abitare la terra — sia un percorso possibile.
Ho pensato che, a causa della sua presenza sia sulla sponda meridionale che su quella settentrionale del Mediterraneo, l’acanto — al di là delle narrazioni che porta con sé — potesse anche evocare le disuguaglianze che caratterizzano l’area mediterranea, e ancor più l’ambiguità dell’attuale sistema capitalista che, pur creando separazioni, fa di tutto per garantire che l’autonomia sognata da Fathy non possa mai essere realizzata. Da qui l’ironia del titolo (“niente potrà separarci”), che si riferisce anche al fatto che i flussi migratori delle piante, così come quelli degli esseri umani, sono, in realtà, incontrollabili.
VALENTINA GERVASONI
Nel tuo lavoro ti sei occupata molto del corpo — da un lato, un corpo in trasformazione, e dall’altro, il corpo come spazio di conflitto, che cerca di sfuggire al controllo patriarcale e antropocentrico. Il concetto di metamorfosi è stato centrale nel pensiero occidentale. La metamorfosi è spesso descritta come un processo di perdita e diminuzione; l’essere umano, considerato l’apice insuperabile di un ordine gerarchico predeterminato, si dissolve in forme animali, vegetali, minerali o persino celesti, senza possibilità di ritorno. Tuttavia, questa visione si basa su una lunga tradizione in cui il corpo femminile è spesso centrale nelle narrazioni di violazione e appropriazione, dove la donna è frequentemente un oggetto passivo, iscritto in una logica di consumo visivo, soggetta alla volontà di divinità maschili e trasformata per punizione, salvezza o desiderio altrui.
Rien ne pourra nous séparer fa riferimento al mito di Acantha, una ninfa che non ricambiava l’interesse amoroso del dio del sole Apollo. Quando fu aggredita sessualmente dal dio, la ninfa reagì graffiandogli il volto. Per vendetta, Apollo la trasformò in una pianta spinosa ma amante del sole che porta il suo nome. In che modo la metamorfosi di Acantha rappresenta non solo una perdita forzata e passiva della sua forma precedente, ma anche una forma attiva di riaffermazione del proprio corpo nel mondo? L’acanto, come simbolo speculativo, può servire come strumento per ribaltare le gerarchie costituite — dall’antropocentrismo al patriarcato?
YESMINE BEN KHELIL
Sì, volevo che la trasformazione forzata fosse percepita quasi come una liberazione, o addirittura come un piacere nel vedere il proprio corpo trasformato. In molte storie, come ad esempio nei film di supereroi, la metamorfosi appare prima come qualcosa di spaventoso, ma poi diventa esaltante. Questa oscillazione tra la paura dell’ignoto e il piacere del cambiamento è una dinamica che esploro spesso nel mio lavoro, perché apre la possibilità di percepire la trasformazione non come una perdita, ma come un’intensificazione. Allo stesso tempo, volevo evitare di riprodurre il cliché che associa sistematicamente il corpo femminile alla natura, ed è per questo che ho introdotto un dettaglio artificiale: le finte unghie rosse, che rimangono visibili sulla pianta dopo la metamorfosi. In questo modo, l’acanto non diventa una pianta “normale”, ma un corpo ibrido, allo stesso tempo naturale e artificiale, che riafferma la propria esistenza e apre uno spazio di resistenza contro le logiche di gerarchia e dominazione.
VALENTINA GERVASONI
Esistono precisi paralleli iconografici che descrivono questo autentico processo di ibridazione, che sovverte l’ordine predeterminato tra ciò che è umano e ciò che è altro dall’umano: le unghie laccate di rosso che tracciano le profonde incisioni che caratterizzano le foglie, arrivando fino alla venatura principale e trasformandosi nei bordi spinosi delle foglie, ma anche la vibrante vitalità dei riccioli dei capelli che si dispiega nelle fronde lobate. Quali materiali o tecniche ti sono sembrati più adatti per trasmettere questa ambivalenza? L’uso della tela trasparente e l’allestimento espositivo creano continuità tra interno ed esterno. In che misura questo dialogo spaziale diventa parte integrante del discorso sul corpo in trasformazione?
YESMINE BEN KHELIL
La scelta dei materiali è stata fatta principalmente in relazione al sito: poiché il padiglione dell’Orto Botanico ha pareti di vetro ed è ampiamente aperto verso l’esterno, era importante che la luce diventasse parte integrante dell’opera e che il supporto fosse abbastanza flessibile da reagire alle correnti d’aria. Volevo che ci fosse porosità tra interno ed esterno, che il disegno si fondesse con il paesaggio e diventasse parte del giardino. Per trasmettere l’ambivalenza della storia, era necessario che l’insieme apparisse fragile, quasi vulnerabile, ma che riuscisse comunque a immergere lo spettatore.
VALENTINA GERVASONI
Cosa ha significato per te lavorare nello spazio dell’Orto Botanico di Bergamo e, più in generale, nel contesto bergamasco, in relazione al tuo background?
YESMINE BEN KHELIL
Ciò che mi ha colpito di più di Bergamo è l’onnipresenza della natura — ma una natura che sembra molto controllata. Esporre in un orto botanico mi ha spinto a riflettere su questa visione del non umano come elemento caotico che deve essere controllato, ordinato e preservato. Questo modo di vedere la natura si è diffuso; dove vivo io, la mancanza di mezzi per controllare e preservare la natura crea uno stato di conflitto permanente, in cui essa è spesso percepita come una minaccia o un ostacolo. Paradossalmente, in questo contesto in cui la natura si afferma clandestinamente contro le fragili infrastrutture umane, diventa più facile percepire che gli esseri umani sono solo un elemento tra gli altri nell’ecosistema. A Bergamo, il paesaggio è così ben progettato che inganna, ed è solo guardando verso le montagne che possiamo andare oltre questa illusione. Ho cercato di tradurre questa dualità nel mio lavoro.
VALENTINA GERVASONI
Raccontare storie che intrecciano l’umano e il non umano, che fanno dialogare finzione, memoria e realtà, può diventare un modo per tramandare le tracce di vite cancellate dalla violenza dell’Antropocene. In quest’ottica, la narrazione (sia visiva che letteraria) non è solo un esercizio di immaginazione, ma anche una forma di resistenza — un modo per creare legami inediti, ricostruire connessioni durature e abbracciare la polifonia di voci e prospettive dell’esistenza multispecie. Nella speculative fiction, la narrazione multispecie ci permette spesso di riconoscere i segni della crisi (penso, ad esempio, all’aumento delle temperature o alla scarsità di risorse vitali nei romanzi di Octavia Butler e Ursula K. Le Guin) o di com-prendere a fondo le crisi stesse. Nell’introduzione a Testimone_Modesta@FemaleMan®_meets_Oncotopo. Femminismo e tecnoscienza, intitolata “Donna Haraway: Se il mondo è un dialetto chiamato metafora”, Liana Borghi scrive:
Le metafore favoriscono la fusione di concetti e mondi che appaiono distanti, permettendo di stabilire legami tra dimensioni diverse e creando connessioni audaci tra tempo e spazio. Le metafore sono strumenti che permettono ai significati di scivolare e spostarsi, catturando soggetti che non rientrerebbero nel sistema egemonico di riferimento culturale.
Nel tuo lavoro, intrecciando mito, memoria e geopolitica, sei riuscita a trasformare la tua pratica artistica in una pratica “ecologica” — un modo per sfuggire alle logiche dell’Antropocene e per immaginare, e quindi costruire, futuri alternativi in cui le radici e le fronde dell’acanto diventano simboli di connessione su più livelli. Quale potenziale vedi nella finzione come linguaggio politico speciale?
YESMINE BEN KHELIL
Penso che la finzione ci permetta di trasmettere ciò che sfugge alla semplice rappresentazione, facendoci percepire tutta la complessità della realtà, che è spesso elusiva e tende a svanire quando cerchiamo di mostrarla direttamente. Per me, lo storytelling è una parte essenziale della realtà, nel senso che siamo tutti situati all’interno di una narrazione. È anche un modo di accostarsi al mondo attraverso la lente della nostra esperienza e l’attenzione che gli dedichiamo. Quindi mi sembra naturale che le favole che appaiono nel mio lavoro diano a volte origine ad altre. Le storie si nutrono a vicenda; si spostano, si evolvono e si reinventano a seconda dei luoghi, dei contesti o dei materiali che incontro. In questo modo, il filo che collega i miei progetti — che spesso non rendo esplicito — non crea un insieme unificato, bensì un tessuto di relazioni e corrispondenze. La finzione diventa così un potente strumento per rivelare zone d’incertezza.
Per il progetto New Flesh, ad esempio, che ha preso come punto di partenza il Museo Oceanografico di Cartagine, il passaggio alla finzione mi ha permesso di rendere percettibile una verità che non avrei potuto esprimere altrimenti — un legame autentico con il luogo, misto a un profondo senso di disagio. Questo disagio non era radicato solo nel fatto che l’istituzione perpetua l’eredità coloniale di una visione del mondo antropocentrica, ma anche in qualcosa di più latente, quasi stantio, nel cuore stesso dell’apparato statale incarnato da questa istituzione agonizzante.
VALENTINA GERVASONI
C’è una dimensione geopolitica che attraversa il tuo lavoro, specialmente quando l’acanto diventa metafora di movimenti, radicamenti e conflitti. In che modo questa dimensione ha guidato la tua ricerca?
YESMINE BEN KHELIL
Non saprei dire esattamente come, nel senso che accade in modo piuttosto spontaneo. Parto sempre dal contesto in cui mi trovo. Ad esempio, il fatto di spostarmi da Tunisi a Bergamo per lo sviluppo e la produzione di quest’opera implica necessariamente la messa in discussione di questo spostamento, tanto più che per me è stato semplice, mentre per altri può essere molto complesso, a volte fatale. Diciamo che parto dal principio che, come artista, io stessa sono inestricabilmente legata a queste questioni.
VALENTINA GERVASONI
Cosa significa per te provare un vero senso di appartenenza a un luogo?
YESMINE BEN KHELIL
Per me, il senso di appartenenza si costruisce attraverso tutte le esperienze che ci connettono a un luogo: i ricordi, i legami affettivi e il modo in cui lo spazio esterno ci modella internamente, fino a diventare parte di noi.
Foto: Nicola Gnesi Studio