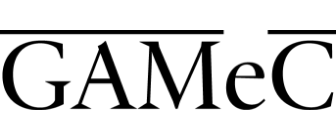Cara Montagna non è un semplice atto di restituzione. È un modo di pensare e parlare con la montagna, di stabilire una corrispondenza in cui il linguaggio si intreccia ai suoni e ai silenzi del paesaggio. Non più soltanto una lettera inviata in attesa di risposta, ma un flusso continuo di risonanze — di un temporale, del crepitio del ghiaccio che cede, del frangersi lento dell’acqua sul bordo di un lago. È un ascolto che ci ricorda che il “paesaggio” è corpo vivente, in costante interazione con il nostro.
Negli ultimi anni, l’ascolto dei ghiacciai è diventato una delle pratiche più evocative e ambigue della nostra relazione con il paesaggio. Microfoni calati nelle cavità del ghiaccio registrano fratture, colature, scioglimenti: una materia viva che si trasforma, ma anche il documento sonoro di una scomparsa. Come osserva Lia Mazzari, artista e ricercatrice che da tempo esplora le possibilità di un ascolto ambientale espanso, “la storia del suono ambientale è la storia della cattura”: un gesto di appropriazione che ha spesso tradotto la natura in archivio, riducendo la sua complessità a “tesoro sonoro” da conservare. Oggi, grazie alle tecnologie di live audio streaming è possibile ascoltare con e non limitarsi solamente ad ascoltare da fuori.
Cara Montagna è un podcast curato da Ilaria Gadenz, ideato con Valentina Gervasoni.
ILARIA GADENZ
Vorrei iniziare dal tuo progetto più recente. Sei appena tornata dalle Alpi dove hai installato una stazione di live audio streaming sulla cima di un ghiacciaio. Vuoi raccontarmi?
LIA MAZZARI
Sono appena tornata dalle Dolomiti, dove ho installato due stream audio live che ascoltano continuamente il ghiacciaio End der Welt Ferner, ai piedi dell’Ortles, all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, vicino al confine svizzero.
Da ora in poi, ora che finalmente, con l’aiuto di altri, sono riuscita a installarli, abbiamo intenzione di mantenere attivo lo stream audio live il più a lungo possibile, per i prossimi mesi, speriamo anni. Probabilmente è il paesaggio sonoro più drammatico che abbia mai sentito, anche perché non avevo mai ascoltato davvero un ambiente glaciale prima d’ora. Lavoro con il suono e ovviamente tutti abbiamo accesso a field recording di ghiacciai o dei territori polari, ma è la mia prima esperienza in questo tipo di ambiente e fondamentalmente anche il suo mio primo ascolto continuo.
ILARIA GADENZ
Hai detto “il più a lungo possibile“. Dipende dall’obsolescenza della tecnologia o quando deciderai di interrompere lo streaming?
LIA MAZZARI
È una domanda davvero interessante. Penso che in questo caso particolare non saremo io o noi a decidere di interrompere lo streaming, ma piuttosto la montagna. Non ho mai lavorato in un ambiente così instabile, il che in primis porta a chiedersi: perché mai lo fai?
La stagione estiva è appena iniziata e i ghiacciai stanno iniziando a muoversi molto. La neve è scomparsa e il ghiaccio si sta sciogliendo, e le morene, che sono i sedimenti sciolti che giacciono pesantemente sulla cima del ghiacciaio, continuano a muoversi. Non me ne sono resa conto fino a quando non mi sono trovata lì, ma il terreno si muove in misura tale che l’intero paesaggio cambia di giorno in giorno.
Per questo dico, stiamo cercando di mantenere la stazione di live streaming lì il più a lungo possibile, perché potrebbe essere completamente inghiottita dalla montagna stessa, il che sarebbe un vero peccato, ma è una possibilità. E poi c’è anche il fattore meteo, le condizioni meteorologiche estreme. Presumo che in inverno farà davvero freddo, andrà oltre i – 25 gradi e nevicherà molto, quindi potrebbe semplicemente essere sepolta dalla neve.
ILARIA GADENZ
Quindi, andiamo al sodo: perché lo fai?
LIA MAZZARI
A essere sincera, in questo caso non è stata una mia decisione. Quest’anno è l’Anno Internazionale della Conservazione dei Ghiacciai ed è stata la comunità che vive ai piedi dell’Ortles a chiedermelo: osservano la Vedretta Fine del Mondo da decenni, hanno pensato di volerlo ascoltare attraverso una stazione di live audio streaming e mi hanno contattato.
Da quando ho iniziato a fare questa ricerca sullo streaming audio in diretta, ho anche imparato che alcuni luoghi sono semplicemente off limits e che ci sono determinati luoghi da cui ho iniziato a non voler trasmettere. Ma in questo caso, grazie al loro invito, ho pensato che potesse essere davvero interessante farlo, soprattutto perché è anche il luogo da cui provengo. Sono originaria dell’Alto Adige e ho vissuto più della metà della mia vita lontano da lì.
ILARIA GADENZ
Mi interessa molto quello che hai detto circa la decisione di non trasmettere da determinati luoghi. Mi spieghi cosa si intende per live audio streaming?
LIA MAZZARI
Uso il termine “ascolto in tempo reale” o anche, come ho fatto in precedenza, “ascolto con streaming audio dal vivo” per descrivere questo atto di ascoltare diversi tipi di ambienti tramite la trasmissione audio dal vivo. A differenza di altri modi di interagire con i suoni dei nostri ambienti, come ad esempio le pratiche di field recording, nello streaming o nella trasmissione audio dal vivo ascoltiamo sempre a distanza tramite una trasmissione audio digitale in tempo reale.
Immaginate, ad esempio, come attraverso lo streaming sia improvvisamente possibile ascoltare il coro dell’alba a Giacarta, un temporale sull’Ortles, i suoni ripresi da un microfono subacqueo nel canale Amstel ad Amsterdam, o il ronzio industriale di un data center alla periferia di Dublino. E tutto questo, in tempo reale.
È così che spesso gli ascoltatori provano una sensazione di imprevedibilità o un senso di urgenza e di non sapere cosa succederà dopo, causato dal crollo della distanza spaziale e temporale.
E ciò fa sì che chi ascolta si senta radicato, concentrato su o attento a questo momento instabile del presente che si sta svolgendo sonoramente da un’altra parte.
È una pratica che può smovere qualcosa in noi ma allo stesso tempo ci tiene coi piedi per terra.
Più tempo passo con questi stream e più mi sembra che l’ascolto diventi quasi una forma di testimonianza, ecologica o materiale, di cose che altrimenti rimarrebbero inascoltate o semplicemente invisibili, forse persino messe a tacere.
ILARIA GADENZ
Quali sono i precedenti artistici o scientifici di questa pratica? Com’è nato il live audio streaming?
LIA MAZZARI
È fondamentale ricordare che lo streaming audio live si basa su metodi condivisi in modo aperto e informale, e su pratiche DIY.
A svilupparli e modificarli costantemente è una comunità globale in crescita, molto affiatata, che riunisce artisti, ricercatori, citizen scientist, giornalisti, attivisti ed educatori.
Proprio per questo, non credo si possa ascrivere questo strumento a una categoria specifica di persone: è aperto a chiunque voglia utilizzarlo.
Personalmente, mi interessa non solo capire come funzionino queste particolari pratiche live, ma anche come queste possano sfidare e sovvertire concetti e visioni obsolete del nostro ambiente. Ma se vogliamo approfondirne la storia, i primi mezzi di trasmissione come il telegrafo, il telefono e la radio sono sempre stati fonte di fascino e sperimentazione per gli artisti che lavorano con il suono.
Artisti come Alvin Lucier, John Cage, Max Neuhaus e Pauline Oliveros hanno sicuramente fatto uso di questi materiali. Ma bisogna citare in particolare un’incredibile artista del suono, compositrice e artista chiamata Marianne Amacher. Penso sia davvero la madrina dello streaming audio dal vivo o della trasmissione audio dal vivo, che lei chiamava remote listening. Già negli anni ’60 aveva creato installazioni sonore su larga scala che utilizzavano proprio queste tecnologie.
Dal 1967 al 1981, quindi per oltre un decennio, portò avanti questo straordinario progetto chiamato City Links, installando microfoni aperti in diverse città degli Stati Uniti, in luoghi come porti, autostrade e zone industriali che stavano subendo importanti trasformazioni urbane. E il modo in cui lo realizzò fu convincendo la compagnia telefonica ad aprire delle linee dedicate: a un capo c’era un microfono, e dall’altro il suo studio di New York dove veniva inviato il segnale sonoro. In questo modo è stata in grado di ascoltare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, i microfoni aperti e di assistere ai cambiamenti dei paesaggi sonori. Ha poi utilizzato questi flussi audio in trasmissioni radiofoniche, ma anche in performance dal vivo. Credo che li abbia anche presentati in installazioni sonore.
ILARIA GADENZ
Torno a quello che hai detto sull’etica fai-da-te e sui metodi apertamente condivisi alla base dello streaming audio dal vivo. Mi sembra che il pensiero ecologico e la consapevolezza di cui hai parlato vadano di pari passo con una rivendicazione politica di Internet, come bene comune. Cosa ne pensi?
LIA MAZZARI
Sì, sono totalmente d’accordo con te. Forse all’inizio non ne ero consapevole o non ci pensavo molto, ma l’ho sicuramente percepito quando ho partecipato al primo evento di live audio streaming. Il fascino stava proprio nella sua dimensione comunitaria, nel fatto che fosse apertamente condiviso, che chiunque potesse farlo. E in tutti questi anni, lavorandoci e cercando di impararne di più, ho incontrato tantissime persone incredibili che ascoltano online, in continuazione, paesaggi sonori da tutto il mondo. Ma è anche vero quello che dicevi: è un modo per riconquistare internet come spazio di libertà, uno spazio che vogliamo plasmare noi, e non subire.
Nei prossimi anni voglio imparare proprio questo, come utilizzare i live audio streaming per discutere di realtà ambientali, politiche e materiali. Altre persone stanno già facendo moltissimo, utilizzando queste pratiche come forme di ascolto critico. Pensa ai progetti di citizen science, in cui usiamo i flussi audio live per ascoltare le popolazioni animali in modo comunitario e aperto, accessibile a tutti. Non per catturare semplicemente un sacco di dati, giusto? Perché dobbiamo ricordare che nulla viene registrato; tutto potrebbe esserlo, ma questo dipende da chi ascolta.
ILARIA GADENZ
Hai anticipato una delle mie domande su quanto sia sostenibile registrare. Sto pensando all’enorme quantità di dati che tali pratiche producono. Questo contrasta con l’idea di ascolto a cui spesso fai riferimento… quali forme di conoscenza pensi che stiano emergendo dall’ascolto live degli ambienti invece che dalla loro cattura attraverso il field recording?
LIA MAZZARI
Questo mi interessa molto, in parte perché ho un background musicale nell’improvvisazione. L’attrattiva del live audio streaming sta nella sua immediatezza, nel fatto che, di fatto, nulla venga registrato. Nella mia ricerca, o quando lavoro a progetti specifici, cerco di registrarne qualche frammento ma non è che qui accanto a me abbia una pila enorme di hard disk…E mi piace proprio per questo motivo, in parte perché a volte guardo con occhio critico alle pratiche di field recording.
Quanti hard disk possiamo accumulare o quanti data center dovremo costruire in futuro per contenere tutte queste informazioni e per chi sono? Questa è in parte la cosa che trovo così affascinante, ed è così che ho iniziato a pensarlo al termine ascoltare con.
Il termine è ormai così radicato in me, ma ho iniziato a rifletterci per rendere evidente che sono innanzitutto impegnata in una pratica di ascolto critico, per evidenziare proprio questo cambiamento di soggettività che emerge quando ascoltiamo un flusso audio dal vivo. Vorrei citare Mark Peter Wright da Listening After Nature, quando afferma che l’ascolto con diventa un processo che abbatte le dicotomie tra vicino e lontano e mette in primo piano questioni di potere, responsabilità e cura.
Quindi volevo solo rendere evidente che questo tipo di ascolto è un processo continuo. È sempre in evoluzione, in divenire e non posso controllarlo perché non so cosa stia succedendo dall’altra parte.
ILARIA GADENZ
Recentemente ho riflettuto su questa citazione di Salomé Voegelin: “L’ascolto ha una capacità esplorativa che non cerca di conoscere il mondo, ma approccia l’apprendimento come una pratica, come uno sforzo fisico e continuo per comprendere momentaneamente e sempre di nuovo come vivere tra le cose. Il suo scopo non è quello di conoscere in modo definitivo, ma l’impegnarsi—attraverso il dubbio—in un sapere temporaneo e sensoriale.” [1] Penso che sia davvero in sintonia con quello che stavi dicendo.
LIA MAZZARI
E sai una cosa… Mi sono resa conto che anch’io la stavo usando per alludere a questo aspetto di sorveglianza: ascoltare può anche significare che siamo sempre con esso, che lo ascoltiamo sempre, quindi dobbiamo anche riflettere criticamente su questo. Sai che apriamo con un flusso questa relazione spazio-temporale con un ambiente ed è aperta tutto il tempo, quindi anche l’osservazione può significare questo, in un certo senso, immagino.
ILARIA GADENZ
La sorveglianza acustica è al centro della mia ricerca dell’ultimo anno. Uno dei motivi per cui mi dedico allo studio delle forme collettive di ascolto è che in esse intravedo un potenziale di inafferrabilità, una resistenza contro l’ascolto algoritmico e pervasivo a cui siamo tutti esposti e, di cui, in qualche modo, siamo complici. Per questo ti ringrazio per aver sollevato l’argomento. Ho un’ultima domanda. Puoi descrivere il suono del ghiacciaio che stai ascoltando in questo periodo? Come lo descriveresti?
LIA MAZZARI
È buffo sai… Mi sono preparata per mesi e mesi.
Quando ci sono andata a marzo 2025, ho incontrato alcuni glaciologi. Ho incontrato Felix Keller, dalla Svizzera e Georg Kaser, che è uno scienziato davvero incredibile… e ogni volta che chiedevo ai glaciologi: “Cosa sentirò? Sentirò qualcosa? Potrebbe essere che ci sia solo il vento?
Loro ridevano, sorridevano: “Oh, non ti preoccupare. Sarà incredibile”. E tutti dicevano la stessa cosa, che appena il sole si alza e il primo raggio colpisce il terreno, il ghiaccio o le morene, tutto comincia a dispiegarsi intorno a te e si sentono piccoli gorgoglii, bip, bloop e crepitii, perché la luce del sole risveglia tutto, no?
Quindi, è un paesaggio sonoro molto drammatico. E non credo di aver ancora trovato le parole giuste per descriverlo. È solo emotivamente piuttosto intenso.
L’intervista è stata registrata il 31 luglio 2025
[1] Voegelin, Salomé. La possibilità politica del suono: frammenti di ascolto. New York: Bloomsbury Academic, 2019.