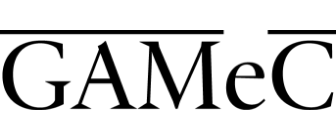MICHAEL JAKOB
Per iniziare la nostra conversazione, mi è venuta subito in mente l’idea che tu “entri” simbolicamente nella montagna, che penetri al suo interno. Di solito, le persone non entrano nelle montagne, ma rimangono fuori.
Penetrando nella montagna, compi un gesto che ha a che fare con la storia stessa delle montagne, poiché prima di iniziare a guardarle, l’uomo le usava. Molto tempo prima di iniziare a contemplarle, a dipingerle e a mostrare interesse per esse, gli esseri umani le usavano e le modificavano, ad esempio estraendo ogni tipo di materiale dal loro interno.
JULIUS VON BISMARCK
Credo che il gesto di scavare un buco in una montagna abbia diverse sfaccettature di significato. Non sono ancora sicuro di quale sia la più interessante, perché ci sono tanti livelli nell’atto di entrare in una montagna: ciò che provoca dentro di te, e quanto differisca profondamente dal modo abituale in cui siamo abituati a guardarla.
È interessante ricordare che, storicamente, l’uomo non scalava le montagne. L’idea di raggiungere una vetta è relativamente recente. Nelle regioni himalayane, ad esempio, le comunità locali non salivano sull’Everest o su altre cime. La pratica di scalarle, oggi spesso svolta dagli sherpa, era originariamente un’invenzione europea, legata a un desiderio specifico di conquista e di “guardare dall’alto”. È, in sostanza, la differenza tra guardare la montagna e scalarla.
Fare un buco nella montagna, tuttavia, è qualcosa di completamente diverso. Estrarre ciò che si trova al suo interno — o addirittura rimuovere la montagna stessa, come accade in certe operazioni minerarie su larga scala, come nelle miniere di rame — porta questa relazione a un altro livello. In alcuni casi, intere vette vengono smantellate, trasformate in vuoti, e il materiale rimosso va a formare nuove montagne artificiali altrove.
Queste azioni rivelano diverse dimensioni del nostro rapporto con ciò che chiamiamo montagna, un rapporto che è cambiato radicalmente, soprattutto dopo l’industrializzazione. Ma anche prima, in epoca preindustriale, l’uomo era già entrato nella terra: penetrando grotte, scavando tunnel, estraendo minerali. Quindi questo impulso di penetrare una montagna piuttosto che limitarsi a osservarla ha radici antiche.
MICHAEL JAKOB
Assolutamente. Se ho capito bene, nel tuo lavoro c’è sempre l’idea che le montagne siano un concetto, una costruzione culturale. Le montagne non sono solo realtà geografiche e geologiche: sono state di fatto “costruite” da diverse generazioni, strato dopo strato.
Come giustamente dici, qualcosa probabilmente è accaduto in Europa tre o quattro secoli fa: è da allora che abbiamo iniziato a guardare le montagne.
JULIUS VON BISMARCK
Sì, sono diventate qualcosa di completamente diverso. Le montagne sono profondamente visive.
Le parti della montagna che non possiamo raggiungere, che spesso sono la maggioranza, per noi non hanno alcuna utilità pratica. Non le abitiamo, non le usiamo; esistono per lo più come immagini, come sfondo visivo. Se sei cieco, quello sfondo scompare e con esso il significato della montagna. Quindi, le montagne hanno una dimensione visiva che poche altre cose possiedono.
L’oceano, ad esempio, è anch’esso visivo, ma con esso interagiamo: lo attraversiamo, lo usiamo. Le montagne, al contrario, restano spesso presenze visive, immagini che per noi contano solo attraverso la vista.
MICHAEL JAKOB
La dimensione visiva delle montagne può assumere molteplici forme. Mi fa pensare a Chateaubriand, lo scrittore francese dell’inizio del XIX secolo che, intorno al 1800 volle “andare a vedere” le montagne, perché a quel tempo era diventata una vera e propria moda. Tutti intraprendevano viaggi pittoreschi e sublimi per ammirare i paesaggi alpini.
Chateaubriand fece il suo viaggio a Chamonix, ma una volta arrivato scoprì che la vista delle montagne era piuttosto noiosa e ingannevole. Spesso, quando ti trovi di fronte ad esse, non vedi quasi nulla di interessante. Perché abbiano un senso, serve un punto di vista molto speciale. Se ti trovi alla giusta distanza (e questa distanza è culturalmente determinata), riesci davvero a vedere la montagna. Ma se sei troppo vicino, non riesci a cogliere quasi nulla. Percepisci dei dettagli, ma non vedi la montagna. Il semplice fatto di vedere la montagna, oltre ad essere una costruzione storica, dipende dalla prospettiva, dal punto di vista e da molti altri fattori.
JULIUS VON BISMARCK
È un problema di visione, non un problema reale. Quando parliamo di immagini contrapposte a ciò che non è visivo, questa distinzione diventa essenziale.
Non so bene quando sia emersa l’idea che la dimensione visiva, o l’immagine, siano diventate più importanti — forse quando abbiamo acquisito la capacità di produrle in serie. Ed è proprio questo il tema che affronta il mio lavoro nella miniera: ciò che è cambiato nel mondo e nel nostro rapporto con il mondo da quando le immagini possono essere riprodotte su larga scala.
Certo, l’uomo ha sempre saputo creare immagini — pensiamo alle pitture rupestri — ma quelle non hanno avuto un impatto universale. La vera trasformazione è avvenuta quando le immagini sono diventate riproducibili, quando hanno iniziato a circolare ampiamente, plasmando la nostra percezione collettiva.
MICHAEL JAKOB
Quindi la tua è un’idea benjaminiana, giusto?
JULIUS VON BISMARCK
In un certo senso sì, anche se non riguarda tanto l’opera d’arte in sé, quanto piuttosto l’immagine in quanto tale. Mi interessa capire come la nostra visione del mondo sia cambiata con l’invenzione della stampa, con l’incisione e, in questo caso, anche con la pittura.
Quando le persone andavano in chiesa, ad esempio, potevano vedere un dipinto di un paesaggio all’interno di un contesto religioso, magari raffigurante un luogo che non avevano mai visto o di cui non avevano mai sentito parlare. È proprio questo che mi affascina: l’idea che gli esseri umani abbiano potuto costruirsi un’immaginazione visiva di un paesaggio di cui non hanno mai fatto esperienza. Credo che lì sia nato un senso della visione globalizzato, un fenomeno che si è sviluppato in Europa e che ha profondamente influenzato il nostro modo di vedere il mondo.
Questo cambiamento ha anche una forte dimensione coloniale. Fu proprio attraverso le incisioni e le stampe paesaggistiche che gli europei formarono la loro comprensione visiva del cosiddetto mondo coloniale. Altri territori, quelli sfruttati dal potere coloniale, venivano percepiti solo attraverso queste immagini stampate in bianco e nero.
È anche per questo che ho scelto l’ambientazione delle grotte e del paesaggio minerario. Quest’opera fa parte di una serie che chiamo Landscape Paintings, anche se, in questo caso, “dipinto” non è il termine più esatto. Sarebbe più corretto parlare di incisione di paesaggio, disegno di paesaggio o stampa di paesaggio.
MICHAEL JAKOB
Mi piace questa tua idea. Lavorando nel campo della teoria del paesaggio, mi è venuta in mente questa riflessione: sappiamo che, in generale, prima del XVII secolo nemmeno i viaggiatori si preoccupavano davvero di guardare le montagne. Non c’era alcun senso estetico nel farlo.
Le montagne erano considerate brutte, una sorta di punizione divina. Tutto questo iniziò a cambiare solo verso il 1680, con Thomas Burnett, autore di Sacred History of the Earth, e John Dennis, autore di Letter from Turin, e con altri protagonisti di quel tempo. Sotto l’influenza di questi pionieri, le montagne iniziarono a essere percepite come un fenomeno estetico.
Questo grande cambiamento, che ancora oggi ci influenza, era legato all’estetica del sublime. Tutto questo avvenne negli stessi anni in cui Claude Lorrain, sicuramente il pittore paesaggista più influente di tutti i tempi, definì i modelli del paesaggio sublime e pittoresco, influenzando così anche l’invenzione del giardino pittoresco. Lorrain non solo possedeva il suo Liber veritatis, un catalogo in miniatura di tutti i suoi dipinti, ma utilizzava attivamente il moderno mezzo dell’incisione per farsi conoscere da un pubblico più vasto. Ai tempi di Lorrain poche persone potevano vedere i suoi originali, ma grazie alle incisioni a basso costo le sue immagini iniziarono a circolare ampiamente, diventando un modello da conoscere e imitare. In Italia, ad esempio, c’erano città specializzate nella produzione di incisioni economiche vendute nei mercati, un fenomeno che contribuì a diffondere ulteriormente una conoscenza (indiretta) dei paesaggi più “in voga”.
Concordo pienamente con te sul fatto che in origine nemmeno gli artisti avessero una conoscenza diretta delle montagne. Le conoscevano piuttosto attraverso illustrazioni e rappresentazioni, poiché producevano tutte le loro opere nei loro atelier.
JULIUS VON BISMARCK
Esatto. E penso che questa sia davvero un’idea chiave in ciò che cerco di fare con il mio lavoro.
Sto cercando di esplorare il momento in cui l’umanità ha imboccato la strada sbagliata, perché credo che oggi ci troviamo, nella migliore delle ipotesi, su una strada secondaria accidentata, cercando di ritrovare la via verso qualcosa che possa funzionare per noi in futuro. Abbiamo perso il senso di armonia con il mondo che abitiamo, un’armonia di cui abbiamo bisogno per sopravvivere.
“Disarmonia” è una parola fin troppo riduttiva per descriverlo. Una specie che distrugge il pianeta che la sostiene non può sopravvivere. Ed è proprio la strada su cui ci troviamo ora. Non voglio addentrarmi troppo in questo argomento, poiché si tratta di una discussione molto più ampia, ma credo tu capisca cosa intendo. Mi interessa capire dove esattamente abbiamo sbagliato.
Non mi riferisco solo alla rivoluzione industriale, anche se rappresenta un punto di svolta evidente, di natura molto tecnica. Si può risalire ancora più indietro nel tempo: alla scoperta del fuoco, all’uso dei combustibili fossili. Ma credo ci sia stata anche una svolta filosofica, un cambiamento nel modo in cui abbiamo immaginato la natura e il nostro rapporto con il pianeta.
Quel cambiamento ci ha permesso di compiere tutte le altre azioni, più tecniche, che hanno portato alla distruzione, all’estinzione delle specie e al degrado degli ecosistemi. Con il mio lavoro cerco di tracciare visivamente questo momento, di identificare dove è avvenuta quella svolta sbagliata. È stato con l’emergere del cristianesimo come religione istituzionale? Ha avuto a che fare con l’ascesa dei mass media?
Forse è iniziato con ciò che chiamiamo “l’invenzione della natura” stessa, un concetto probabilmente errato fin dall’inizio, che ci ha permesso di giustificare lo sfruttamento e la distruzione di ciò che avrebbe dovuto restare fuori dal nostro controllo. Cerco continuamente di cogliere quel punto preciso, il momento in cui la deviazione ha avuto inizio.
Potrebbe coincidere con il momento in cui l’uomo ha iniziato a produrre in serie immagini di paesaggi. Non ne sono certo, è una domanda aperta, ma è per questo che ne sono attratto.
E se guardiamo a ciò che accade oggi, è affascinante vedere come un nuovo mezzo di comunicazione, i social media, stia ridefinendo ancora una volta il nostro rapporto con il paesaggio. Negli ultimi vent’anni, è stata probabilmente l’invenzione più trasformativa.
Recentemente, nelle Dolomiti, c’è stato un momento che lo ha reso davvero evidente: le montagne sono state letteralmente prese d’assalto dagli influencer. Se ne è parlato su tutti i notiziari italiani: centinaia di persone in fila nello stesso punto per scattare lo stesso selfie con lo stesso sfondo, seguendo lo stesso modello.
MICHAEL JAKOB
Sì, ho visto quelle immagini.
JULIUS VON BISMARCK
Ed è successo pochissimo tempo fa, il che rende questa nostra conversazione ancora più interessante: tutto è accaduto dopo che avevo già realizzato il dipinto nella miniera. Mostra chiaramente come un nuovo medium possa avere un impatto enorme su un paesaggio montano, semplicemente sovraccaricandolo di presenze umane, tutte concentrate nello stesso luogo per ottenere la stessa immagine. Trovo questa idea affascinante.
MICHAEL JAKOB
Ci sarebbe molto da dire e penso che questo sia solo l’inizio della nostra conversazione. Il primo paradosso che vorrei sottolineare è questo: oggi, in generale, la Natura versa in condizioni terribili. Noi moderni abbiamo distrutto attivamente quasi tutto ciò che potevamo distruggere e allo stesso tempo viviamo in un’epoca caratterizzata da una “religione della natura”.
Tutti vogliono essere “gentili” con la natura. Da un lato, se pensiamo a Bruno Latour e al suo libro Gaia, noi umani siamo folli: non ci prendiamo davvero cura della natura e continuiamo a distruggerla, eppure agiamo come se ci importasse profondamente di lei. Da dove viene questa tradizione di trascurare e violare la Natura? C’è naturalmente la tradizione anti-ecologica del cristianesimo, l’idea che dobbiamo sottomettere e controllare la Natura, e che “ferirla” non abbia poi grande importanza. A questo, io aggiungerei un’altra spiegazione. Credo che qualcosa di decisivo sia accaduto nel XV secolo. Prima di tutto, penso alla famosa “performance” di Brunelleschi messa in scena a Firenze, quando dimostrò il principio della prospettiva centrale. In quella situazione c’è un singolo osservatore fermo nel punto P, con la “realtà” davanti a sé — una relazione vis-à-vis che immobilizza chi guarda. Questo soggetto è completamente immobile e ha il controllo di ciò che osserva. I militari e i cartografi, naturalmente, si interessarono moltissimo a questo nuovo “modo di vedere” razionale e matematico, reso comprensibile e popolare proprio grazie all’esperimento di Brunelleschi.
C’è un’analogia interessante tra la prospettiva centrale o a punto unico e un’altra invenzione dello stesso periodo, ovvero la pagina singola del libro stampato di Gutenberg. Se confrontiamo l’aspetto grafico di queste pagine con le forme precedenti di presentazione dei testi, cioè i manoscritti, notiamo una grande differenza: i manoscritti erano anarchici, con lo scriba o il copista che avevano molte scelte a disposizione. Con l’invenzione della pagina stampata (moderna), Gutenberg impose una struttura, un limite. Le due nuove tecnologie, la rappresentazione prospettica e la rappresentazione verbale sulla pagina del libro, usavano entrambe, per così dire, una struttura razionale fissa. Una ha dato vita a una macchina per guardare, l’altra a una macchina per leggere. La griglia della prospettiva e i dipinti d’avanguardia del tardo XV secolo, così come le pagine dei libri con le loro colonne standardizzate, hanno prodotto sia un campo che una forma di attenzione, un atteggiamento psicologico legato all’idea di controllo: controllare il mondo guardandolo “nel modo corretto” o leggendo un testo “nel modo giusto”. Naturalmente bisogna stare molto attenti a non cadere nella tentazione di ricondurre queste innovazioni a una datazione temporale rigida. Sappiamo che alcuni filosofi amano indicare una data precisa per i grandi cambiamenti che hanno influenzato l’umanità. Mi viene in mente Stephen Toulmin che propone il 1610; altri intellettuali opteranno piuttosto per il 1492. Altri storici ancora ci ricordano l’importanza del 1543, anno del De revolutionibus di Copernico, del De humani corporis fabrica di Vesalio e della prima edizione a stampa del De rerum natura di Lucrezio. Tuttavia, concordo pienamente con te: qualcosa di rilevante è avvenuto in epoca moderna e ci ha portato dove siamo oggi.
JULIUS VON BISMARCK
È molto interessante. Quella che chiami “religione della natura” è esattamente ciò a cui ho pensato, anche se lo esprimo in modo diverso. Tu lavori con le parole, io con le immagini. Io cerco forme visive per rappresentare questa idea.
Quando ho “frustato” l’oceano o le Alpi, era una performance, certo, ma anche un’immagine. Per me è stato un atto fisico ed emotivo — doloroso, quasi rituale — ma alla fine è diventato un’immagine che gli altri potevano vedere. Pone una domanda: perché qualcuno dovrebbe frustare la natura? L’opera induce a riflettere su questo nostro strano rapporto, quasi religioso, con la natura. Forse questo atteggiamento è la radice dei nostri problemi; ma forse, in un certo senso, potrebbe anche essere parte della soluzione.
Non ne sono sicuro. Forse abbiamo bisogno di una sorta di religione che ci impedisca di distruggerci a vicenda — non necessariamente una religione organizzata, ma qualcosa dentro di noi che ha bisogno di credere, qualcosa che orienti le nostre azioni. La mia ricerca visiva è un modo per indagare questo aspetto.
Quando ho filmato catastrofi naturali come uragani o tempeste, ho rallentato le immagini per far sì che lo spettatore percepisse la tempesta in modo diverso. C’è un dio o una dea che infuria al suo interno? È questo che percepiamo? Quando un incendio divora una foresta, è forse una forza divina che agisce o semplicemente una distruzione che interpretiamo come punizione? Molte persone proiettano questi eventi sull’umanità, vedendoli come conseguenze morali: “Hai agito in modo sbagliato e ora la natura si vendica”. Anche questa è un’interpretazione profondamente religiosa.
MICHAEL JAKOB
Il tuo esempio è persino mitologico, più che religioso: il fulmine ci riporta a Zeus, o a Giove, non è così?
JULIUS VON BISMARCK
Esattamente. È una sorta di idea pre-monoteistica. Ho sempre pensato che l’umanità si muova in cicli: dalle religioni naturali al politeismo, poi al monoteismo; e ora, forse, stiamo tornando a una nuova forma di religione della natura. È questo che cerco di esplorare con il mio lavoro. Ad esempio, il mio primo Landscape Painting, creato insieme a Maya, è stato realizzato nella giungla.
MICHAEL JAKOB
Sì, l’ho visto. Hai dipinto la vegetazione di bianco, vero?
JULIUS VON BISMARCK
Esatto. Quel progetto indagava come persone diverse costruiscono l’idea di “natura” e come tali costruzioni variano a seconda della propria posizione, che si tratti di una visione del mondo monoteistica o politeistica.
MICHAEL JAKOB
Trovo molto interessante il modo in cui lo formuli. Potremmo persino parlare di una forma di Neue Mythologie, una Nuova Mitologia, come la chiamava Friedrich Hölderlin.
JULIUS VON BISMARCK
Sì, e oggi sono i ricchi che vanno nella giungla per bere ayahuasca in ritiri di lusso, alla ricerca di un “nuovo dio”. C’è un intero movimento di persone che cercano qualcosa oltre il razionalismo, oltre la scienza, nach der Aufklärung, al di là dell’Illuminismo, verso qualcosa che viene dopo.
MICHAEL JAKOB
Per fortuna ci sono artisti che, invece di rifugiarsi in ritiri di lusso, hanno cercato di scoprire e integrare nelle loro opere il passato arcaico e mitologico. Penso ai lavori di Robert Smithson nello Yucatan o a quelli di Anna Mendieta.
JULIUS VON BISMARCK
Per me è essenziale non solo leggere di queste cose, ma anche viverle direttamente. Ho trascorso molto tempo in Colombia con le comunità indigene mentre facevo ricerche sul fulmine. Prima di creare opere in cui provocavo fulmini lanciando razzi nei temporali, volevo capire cosa significasse davvero il fulmine.
È uno dei pochi fenomeni naturali che ancora non siamo in grado di controllare. Ci appare casuale, eppure per i popoli che ho incontrato — i Wiwa nel nord della Colombia — esso ha un significato profondo. Alcuni di loro avevano perso persone care colpite dal fulmine, e volevo capire: lo considerano una punizione divina, una sfortuna, o semplicemente un fatto naturale? Cosa significa per loro? E in che cosa questa visione differisce da quella occidentale, cristiana, europea?
La mia teoria è che quando la natura uccide qualcuno a noi caro — quando una tempesta, un’alluvione o un fulmine portano via una vita — è in quel momento che affiorano i nostri veri sentimenti verso di essa. In quei momenti, i nostri sentimenti non sono più astratti: sono profondamente reali, poiché non possiamo controllare ciò che affiora a livello subconscio. La risposta e i sentimenti che emergono sono molto diversi se chiedi “cosa pensi della natura?” in un dato momento o in concomitanza con una catastrofe: questi sono i momenti che mi interessano di più.
MICHAEL JAKOB
Quando siamo in pericolo, certo, l’estetica vacilla. Mi viene in mente L’avventura di Michelangelo Antonioni, il suo ultimo film in bianco e nero prima di Il deserto Rosso. Un gruppo di amici si trova su un’isola in Sicilia, persone civilizzate e moderne abituate all’agio e allo svago, turisti in cerca di panorami belli o sublimi. Poi arriva una terribile tempesta e tutto cambia: le stesse persone che cercavano ingenuamente bellissimi scenari ora pensano solo a sopravvivere. L’estetica scompare e l’unica cosa che conta è l’esistenza individuale.
JULIUS VON BISMARCK
È esattamente quel momento che mi affascina. Nella nostra mentalità moderna, diamo per scontato di essere noi gli attori e che la natura si limiti a reagire. Anche quando c’è una violenta tempesta, pensiamo ancora che sia una reazione della natura alle azioni umane.
Ma quando sei nel mezzo di una tempesta, quella prospettiva svanisce. Non sei più tu ad agire: reagisci. È la natura che agisce.
L’ho provato nelle montagne del Ticino: quando arriva il tuono, non puoi fare altro che reagire. O una volta, nel Mediterraneo, sono stato sorpreso da una tempesta su una piccola barca a noleggio. Le onde erano più alte della barca stessa. Mi sembrava quasi di pregare il dio del mare, implorandolo di non morire con l’onda successiva. La paura mi ha reso istintivamente religioso. Quando pensi di poter morire, inizi a pregare, anche se credevi che non l’avresti mai fatto.
Sono stati momenti decisivi per me, e sono entrati a far parte della mia ricerca in divenire. Sono stato persino colpito da un fulmine una volta; e anche quello, in un certo senso, è stato una rivelazione.