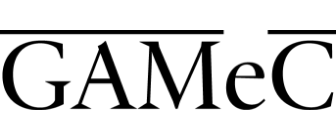Il terzo appuntamento del ciclo Incontri ha visto protagonisti la curatrice Greta Martina e l’antropologo Adriano Favole.
Il confronto, di cui pubblichiamo un estratto, si è concentrato sulle tematiche trattate dal progetto Fossi io teco; e perderci nel verde, vincitore della XII edizione del Premio Lorenzo Bonaldi.






SARA FUMAGALLI
Adriano Favole è professore ordinario di antropologia culturale all’Università di Torino. È un antropologo che ha condotto molti anni di ricerca a Futuna in Nuova Caledonia e in altre isole dell’Europa d’Oltremare. A partire dagli anni Novanta ha pubblicato numerosi testi importanti—ci limitiamo a citare i più recenti: Vie di fuga (Utet, 2018), di cui parlavamo proprio poco fa, Il mondo che avrete (Utet, 2020), scritto insieme a Marco Aime e Francesco Remotti, e naturalmente La via selvatica (Laterza, 2024), il libro che presentiamo qui stasera, in dialogo con Greta Martina.
Greta Martina è la vincitrice della dodicesima edizione del Premio Lorenzo Bonaldi per l’Arte, un premio dedicato ai giovani curatori e alle giovani curatrici under 30, che si stanno avvicinando a questa professione. Quest’anno abbiamo chiesto ai curatori e alle curatrici coinvolti di pensare a un doppio progetto espositivo: uno da realizzare specificamente per Serina, all’interno di un ex monastero e in dialogo diretto con la comunità locale—che abbiamo cercato di coinvolgere attivamente, anche durante l’inaugurazione—e l’altro, come da tradizione, nello Spazio Zero, la nostra project room all’interno del museo. Questa sera Greta Martina ci parlerà della mostra Fossi io teco; e perderci nel verde, da lei curata, a partire da un testo che ne ha in parte ispirato il concept, La via selvatica di Adriano Favole. Lascio ora la parola ai nostri ospiti, che ringrazio entrambi per essere qui stasera.
GRETA MARTINA
Fossi io teco e perderci nel verde è un verso di Giovanni Pascoli tratto dalla poesia Romagna. Questo verso esprime già un desiderio di relazione: c’è un “io”, un “tu” e uno spazio che li accoglie entrambi – il verde – una presenza terza che, pur non essendo umana, è paritaria, fondamentale. Si delinea così una relazione a tre, in cui tutte le entità coinvolte hanno lo stesso valore e si incontrano in questa dimensione che sovrasta e include.
L’invito a “perdersi nel verde” non va inteso come una fuga o un rifugio dalla realtà, ma piuttosto come un invito ad accordarsi con i ritmi e le esigenze di questo verde, inteso come spazio vivente, pulsante. In questo senso, risuona profondamente con ciò che Adriano Favole definisce come “incolto”, e dunque come “selvatico”. Per me, l’idea di “incolto” è indissolubilmente legata al verde: qualcosa che germoglia, che avvolge, che cresce rigoglioso – il verde dei prati, dei boschi, della vegetazione che ci circonda. Ed è da qui che partirei per approfondire insieme il significato di questo “incolto”.
ADRIANO FAVOLE
È davvero un grande privilegio vedere come alcune riflessioni, idee e persino racconti presenti in questo libro prendano vita nell’esposizione ideata da Greta Martina, nei lavori degli artisti, e più in generale in ciò che ci diremo stasera.
Il libro ruota in effetti attorno a una parola – l’incolto. Alcuni miei libri nascono così: da un concetto che provo a esplorare in direzioni diverse, pur mantenendo il fuoco su ciò che è al centro del mio lavoro da antropologo, e su ciò che attorno a quella parola mi è stato comunicato. In questo caso il termine “incolto”, che nel titolo si trasforma in “selvatico”, anche se non sono esattamente sinonimi ma termini che si sovrappongono. L’idea dell’incolto, come hai ben sottolineato, si riassume nella parola “teco”, una parola bellissima perché implica una relazione. Mi fa pensare anche a un altro termine, più comune nel mio dialetto – il cuneese, o piemontese – che è “nouiauti” (“noialtri”): un’espressione che usiamo al posto di “noi”, e che contiene in sé una relazione, un’apertura all’altro. Una parola che meriterebbe una sua storia tanto è densa di senso.
La via selvatica, dunque, non suggerisce – come forse potrebbe sembrare – l’abbandono di tutto ciò che è umano o simbolico, per rifugiarsi in una natura incontaminata. Al contrario, parte dall’idea che non esista una cultura priva di natura, né una natura incontaminata dalla cultura. Quello che siamo è, essenzialmente, una relazione.
Il concetto di incolto mi è arrivato da due esperienze molto diverse che, a un certo punto, si sono intrecciate. La prima è più personale: provengo da un mondo contadino. Ho vissuto fino ai cinque anni in una grande casa colonica dove mio nonno era mezzadro, e da lì una lunga genealogia di contadini. Anche dopo il trasloco verso una casa più moderna, ho continuato a vivere vicino ai campi, alle mucche, anche se non era più la stessa cascina – la Casa Bianca, oggi un po’ in rovina. In quella prima parte della mia vita ho imparato che l’educazione era un’educazione alle relazioni: le stagioni, i cicli delle semine e dei raccolti, tutto risuonava di legami.
Ricordo, per esempio, quando mio nonno mi insegnò a pescare: non era un semplice gesto tecnico, ma l’apprendimento di una rete di relazioni. Capire quando i pesci hanno fame – le trote a fine febbraio, i barbi e i cavedani tra maggio e giugno, le carpe ad agosto – significava ascoltare i tempi della natura. I pesci non mangiano tutto, anzi, sono esigenti: vogliono larve diverse a seconda della stagione, della corrente, della zona del fiume. Così ho imparato che il sapere era relazione, e che anche l’incolto – quel che non è coltivato – era motivo di meraviglia. Una meraviglia spesso eccessiva, forse, per un mondo che già stava scomparendo: l’incolto era il regno delle lepri, dei fagiani, delle api, di una biodiversità che si manifestava secondo i ritmi dell’anno.
Poi, per anni, ho come dimenticato tutto questo, immerso in un mondo profondamente umano e simbolico. Ho studiato filosofia, poi antropologia culturale, e mi sono dedicato a esplorare sistemi di parentela, rituali, politiche culturali. Tutto profondamente umano.
Di recente, però, sono tornato a vivere in una casa che si affaccia su un bosco. È il bosco da cui parte il libro: non un bosco da fiaba, ma quello nato sul sedime di una vecchia ferrovia – la Torino-Savona. È un bosco di ritorno, dove ora passano volpi, tassi, e vivono decine di specie di uccelli. Questa vicinanza mi ha riportato alla meraviglia delle relazioni e alla forza dell’incolto.
L’altra esperienza, più legata alla ricerca, arriva dall’Oceania. Le società che ho frequentato lì non utilizzano la nozione di “natura” come qualcosa di separato dall’umano. In molte lingue locali, infatti, non esiste un termine che indichi “ciò che non è umano o artificiale”. Piuttosto, esistono parole che rimandano a una relazione tra esseri umani e altri viventi, o alla capacità rigenerativa di ciò che noi chiamiamo “natura”.
Già cinquant’anni fa alcuni autori avevano osservato che, in Nuova Caledonia – primo arcipelago che si incontra viaggiando dall’Australia verso il Pacifico – è molto pertinente il concetto di incolto. Lì la foresta non è semplicemente non-umana: è piuttosto ciò che non è ancora umano o non lo è più. È il luogo degli spiriti, delle anime dei defunti. Ed è anche il luogo dove l’umano ritorna, con il corpo, con i suoi resti. L’incolto è un confine, un limite, una soglia porosa tra umano e non umano.
Così ho iniziato a riflettere su come noi esseri umani ritagliamo zone di cultura – il coltivato – all’interno di un incolto che ci circonda e, inevitabilmente, riprende il sopravvento. La via selvatica è dunque un’esplorazione di questa relazione, non un ritorno a un verde incontaminato, ma l’ascolto di ciò che continuamente ci sfugge e ci attraversa.
GRETA MARTINA
Successivamente nel tuo libro emerge anche una riflessione sulla separazione — una separazione che, almeno nella nostra concezione liberale, ma in realtà con radici ben più antiche, contrappone natura e cultura, o civiltà. Una visione dicotomica che però non rappresenta l’unica via possibile.
Già nel linguaggio stesso della mostra si manifesta una prima forma di separazione: l’atto dell’esporre implica un’esibizione, una decontestualizzazione dell’oggetto, che viene così trasformato in entità autonoma, in simbolo. Questa trasformazione può essere problematica e merita certamente un approfondimento ulteriore.
Tuttavia, all’interno della mostra è possibile individuare un esempio significativo di una possibile via mediana tra cultura e natura — un tentativo di affievolire quella distanza che si riflette anche nel linguaggio curatoriale e nell’organizzazione stessa del progetto espositivo. Da un lato, c’è l’esposizione all’interno dello spazio museale, che invita lo spettatore a entrare nell’istituzione; dall’altro, c’è un movimento verso l’esterno, una tensione centrifuga che accomuna la mostra al programma più ampio di Pensare come una montagna. Quest’ultimo, infatti, non si articola esclusivamente nello spazio istituzionale del museo, ma cerca di abitare e attivare altri luoghi.
Un primo esempio di questo movimento è stato l’opening della mostra, che non si è svolto in museo, ma a Serina, all’interno di un monastero: un primo spostamento verso l’esterno. Questo gesto è poi rientrato nello spazio espositivo attraverso la performance Rudimenti di Enrico Malatesta, tenutasi a marzo, che ha animato una sala concepita per accogliere non solo il lavoro in sé — l’oggetto — ma anche la presenza umana e la sua dinamica.
Vorrei però soffermarmi su un altro episodio, che trovo particolarmente emblematico di questa ricerca di una via di mezzo tra natura e cultura: Superpaesaggio, una performance o meglio un avvenimento performativo, svoltosi il 16 marzo presso la Rocca di Bergamo. Un luogo che può essere interpretato come un “terzo paesaggio”, secondo la definizione di Gilles Clément, a cui si fa riferimento anche nel libro: uno spazio che aveva una funzione originaria e che oggi ne assume un’altra, completamente diversa.
In quell’occasione, ci siamo recati tutti alla Rocca e, seguendo le indicazioni degli artisti — Attila Faravelli, Nicola Ratti ed Enrico Malatesta — abbiamo intrapreso una camminata sonora condivisa. Gli artisti avevano portato con sé alcuni strumenti, come biglie di ferro, calamite, walkman, ma la performance si è costruita anche attraverso l’interazione con gli elementi del luogo: rami trovati a terra, grate metalliche, superfici naturali. L’esperienza ha privilegiato l’ascolto rispetto alla vista — un senso che si presta maggiormente alla condivisione, alla relazione, mentre la vista tende a gerarchizzare, a isolare.
Questa centralità dell’ascolto non si è esaurita nella performance, ma ritorna anche all’interno della mostra, dove il suono è protagonista di numerosi lavori. Ed è un aspetto che attraversa anche la poetica di Giovanni Pascoli. Lo stesso Pascoli si definiva “poeta musico”, e il suo “fanciullino”, emblema della sua visione poetica, è appunto un poeta musico: capace di sentire e percepire quei suoni che, in teoria, tutti potremmo ancora ascoltare. La difficoltà nel coglierli non risiede tanto nella nostra età o nella loro fragilità, quanto piuttosto nel frastuono che ci circonda.
L’idea, allora, è quella di risintonizzare le nostre orecchie — e più in generale i nostri atteggiamenti — verso l’incolto, verso ciò che non è addomesticato, verso un’alterità non ridotta. Cercare, insomma, un percorso che possa condurre a una commistione, o quantomeno a un contatto vivo tra natura e cultura.
ADRIANO FAVOLE
Sì, più che ripercorrere tutta la storia di questa opposizione – che è lunga e al centro di un dibattito enorme, anche nell’antropologia dell’ambiente contemporanea – direi che vale la pena soffermarsi su alcuni punti chiave. Quando è nata, infatti, l’idea che la natura sia qualcosa di separato dagli esseri umani? Le genesi possibili sono tante. Alcuni fanno risalire questa distinzione all’invenzione dell’agricoltura: quando l’essere umano comincia a “produrre”. Ma è un’idea discutibile, perché in realtà l’agricoltura stessa è stata a lungo (e lo è tuttora in certi casi) il frutto di un dialogo con il non umano. Chi può coltivare davvero senza affidarsi a una relazione? E da quanto tempo, nella storia, gli esseri umani hanno cominciato a pensare a sé stessi come unici protagonisti del gesto agricolo?
Altri ancora sostengono che la distinzione natura/cultura sia molto antica: basti pensare al momento in cui, nella Genesi, si dice “dominerai gli altri animali, ti servirai di loro”. In questa visione c’è già il germe di quello che diventerà l’Antropocene, un mondo in cui l’essere umano domina in modo quasi assoluto. Ma per migliaia di anni, nonostante gli esseri umani abbiano ritagliato città, campi, infrastrutture, la convivenza con l’incolto è rimasta tutto sommato virtuosa, o comunque non ha danneggiato in modo irreversibile l’ambiente.
Per trovare invece dei segni consistenti di ciò che viviamo oggi, bisogna arrivare almeno alla Rivoluzione Industriale, se non addirittura al secondo dopoguerra: è lì che tutte le curve – CO₂ nell’atmosfera, acidificazione degli oceani, produzione di rifiuti, numero di voli internazionali – crescono in modo esponenziale, creando le premesse per il cambiamento climatico che stiamo attraversando.
Tutto questo per dire che l’opposizione natura e cultura è parte di una storia complessa e stratificata, che merita di essere discussa ancora. Ma oggi vorrei provare a innestarmi sul tema che hai evocato, entrando più in dialogo con quello che dicevi sul modo in cui hai immaginato l’esposizione e le performance.
C’è un problema, oggi, per l’arte – e non voglio certo rubare il mestiere a nessuno – ed è proprio quello di pensarsi non più come un ambito separato dal mondo dei non umani. L’arte, per definizione, sembrerebbe una cosa esclusivamente umana, simbolica. Ma proprio per questo, come tu suggerivi, è interessante pensare ad altre società, chiamiamole così per semplificare, dove l’arte si confronta da sempre con questo problema.
Mi vengono in mente, per esempio, i Kanak della Nuova Caledonia, la popolazione nativa di quel territorio. Quando i primi collezionisti francesi ed europei arrivano lì alla fine del xix secolo, trovano delle grandi sculture antropomorfe – quelle che vediamo oggi al Musée de l’Homme a Parigi, al British Museum a Londra, o nei musei etnologici europei –, oggetti che erano stipiti delle capanne, decorazioni interne, oppure le famose flèches fêtières, le frecce sommitali, anch’esse con elementi antropomorfi e decorazioni come conchiglie, che richiamavano il suono, il richiamo, il contatto.
Questi oggetti, i Kanak li lasciavano nella foresta. Venivano dalla foresta e alla foresta ritornavano. E lì dovevano restare. Erano parte del ciclo. I primi oggetti che abbiamo oggi nei musei sono molto rovinati, perché erano rimasti lì per decine, forse centinaia di anni. Ma quando i Kanak si accorgono che gli europei sono pronti a pagare per questi oggetti, cominciano a scolpirne di nuovi, appositamente per il mercato. E quindi, nel giro di vent’anni, si trovano oggetti “fatti bene”, non più rovinati dalla pioggia e dal tempo.
Questa dinamica – l’arte umana che nasce dal selvatico e ad esso ritorna – la ritroviamo in tante culture. Penso, ad esempio, ad alcune società delle Highlands della Papua Nuova Guinea, di cui parlava l’antropologo francese André Itéanu. In quei contesti, le capanne venivano costruite con alberi scelti apposta perché potessero germogliare. Così, quando si abbandonava una capanna, questa si trasformava in un piccolo bosco. Si utilizzava un legno “vivo”, in dialogo con ciò che avrebbe continuato a crescere.
È un modo per dire: noi siamo parte di una circolarità, di una relazione continua con ciò che ci circonda.
E qui ritorna anche l’idea del terzo paesaggio, che tu hai evocato. Una nozione che può essere considerata una sorta di traduzione contemporanea dell’incolto. Il termine viene da Gilles Clément – forse lo conoscete, magari avete visto sue installazioni a Parigi o altrove in Europa. La sua idea, nata anni fa, è che la relazione con l’ambiente non si recupera solo immergendosi nei boschi incontaminati e iperprotetti. Certo, è importante che ci siano, e che siano tutelati. Ma il punto è: la relazione con il vivente si costruisce anche nel parco davanti a casa, nel piccolo giardino urbano, nella siepe disordinata del vicino. Perché tagliamo l’erba ad aprile, quando è piena di fioriture? Lasciamola crescere. Almeno fino a maggio.
Questo è il terzo paesaggio: fare con quello che abbiamo attorno, meravbigliarsi delle vite che ci circondano. È un gesto semplice, ma potentemente simbolico.
Un piccolo aneddoto personale: qualche anno fa ero risalito in una parte della Nuova Caledonia, per cercare un luogo descritto da Georges Haudricourt, un etnobotanico che per primo ha introdotto la nozione di incolto riferendosi alle società oceaniche. I Kanak usano ancora la parola “tribù” per definire i loro insediamenti tradizionali. E mentre cercavo questi luoghi con una guida, a un certo punto lui mi mostra un libretto dove annotava i passaggi degli stranieri, e mi rivela che da lì, venticinque anni prima, era transitato un personaggio importante in Francia, Gilles Clément!
Clément era andato proprio lì, in quei luoghi dove si è formato il pensiero sull’incolto. E Haudricourt, tra l’altro, è stato maestro di Philippe Descola – forse il più importante antropologo contemporaneo a occuparsi di natura e cultura. A volte sono proprio contesti apparentemente lontani, marginali, periferici a permettere il formarsi di idee che si rivelano importanti per l’umanità intera.
Tutti questi passaggi – tra Kanak, Haudricourt, Clément, Descola – ci riportano al senso profondo del terzo paesaggio: un invito a dialogare con la forza generativa della natura che ci circonda, anche dentro la città.
E la foto di copertina del mio libro, che sembra così “esotica”, con il volto coperto di vegetali, in realtà è un’immagine comunissima in Oceania. I danzatori si adornano con ciò che hanno attorno: collane di fiori, foglie, fibre. Costruiscono un’immagine simbolica di sé – non per imitare la natura, ma per dichiarare una relazione.
GRETA MARTINA
Uno dei lavori in mostra che, secondo me, racchiude perfettamente questa idea di riferimento al territorio circostante, e della sua trasposizione nello spazio espositivo, è Corridori Lenti di Umberto Pellini. Si tratta di una serie di quindici sfere realizzate con fango, terra e acqua: materiali raccolti durante un soggiorno dell’artista qui a Bergamo. La pratica si radica quindi nel gesto dell’esplorazione e dell’interazione diretta con il territorio, in una dimensione quasi rituale.
Per mesi, Pellini ha mescolato questi elementi, ripetendo un gesto che definisce “quasi come una carezza”, fino a ottenere queste sfere perfettamente lisce, tonde, artificiali quasi. Eppure il contrasto è forte: la sfera, nella sua perfezione geometrica, è forse la forma che più richiama l’idea di natura, di qualcosa che esiste indipendentemente dall’intervento umano. In questo senso, la sfera diventa un luogo di tensione tra ciò che è organico e ciò che è manipolato, tra ciò che è dato e ciò che è costruito.
Il tempo impiegato per la loro realizzazione — circa un mese per ogni sfera — introduce un altro elemento fondamentale: il ritmo lento, antitetico alla frenesia che caratterizza la nostra quotidianità urbana. È un tempo che non risponde alle logiche della produttività ma si adatta alle esigenze del materiale stesso, al suo comportamento, ai suoi tempi di risposta. Ecco che l’opera diventa così anche un atto di ascolto e di fiducia, poiché l’artista non ha garanzia del risultato finale: ogni sfera può fallire, può non brillare. Eppure, questo rischio è parte stessa del lavoro.
C’è anche un gesto, quasi contraddittorio, nel cercare di trasformare un materiale grezzo come la terra in qualcosa di perfettamente compiuto, leggibile, controllabile. Ed è una tensione che si ritrova anche in un altro lavoro di Pellini: Io, Tu, Una Casa, Una Città, in cui realizza piccole costruzioni modulari in cemento, simili ai giochi per bambini. Anche qui, l’artista tenta di ridurre e semplificare la complessità urbana, di renderla manipolabile, comprensibile. È un tentativo di tradurre in scala ciò che normalmente ci sovrasta, un modo per giocarci, ma anche per prenderne misura.
Tutto questo mi sembra rispondere a un’esigenza profonda: quella di un’arte che non si limita a rappresentare, ma che si confronta direttamente con le condizioni materiali e simboliche del nostro tempo. Un’arte che non offre soluzioni, ma propone percorsi — come tu stesso dici, una “convivenza creativa”.
In questo senso, ti chiederei: come possiamo, oggi, all’interno delle istituzioni artistiche, affrontare quella che nel tuo libro definisci una “semiolimia” — un eccesso, una sovrabbondanza di simboli?
ADRIANO FAVOLE
Ci sono questioni molto interessanti in quello che dicevi prima riguardo l’opera di Umberto Pellini: una è l’idea di rallentare i tempi, che è uno dei nostri grandi problemi contemporanei. Viviamo in un mondo sempre più accelerato, un tempo che ci sfugge, e a cui cerchiamo di reagire. Thomas Erikson, un antropologo norvegese scomparso l’anno scorso, ha scritto un libro molto interessante dal titolo Fuori controllo. Un’antropologia del cambiamento accelerato. Un mondo accelerato, un mondo surriscaldato, dove esplora questa corsa continua, l’affanno che accompagna ogni nostro passo e ogni nostro lavoro. La questione che solleva Erikson è proprio la necessità di fermarsi, rallentare, pensare prima di agire, e questa è una proposta che l’arte potrebbe abbracciare come parola chiave: rallentare.
L’altro tema che affronto sempre con grande interesse e che è molto rilevante anche oggi, è l’improvvisazione. Un concetto che da sempre è stato centrale nell’arte, ma che oggi viene anche molto sottolineato dagli antropologi, in particolare da Tim Ingold, uno dei grandi studiosi di antropologia ambientale. Ingold ha scritto un libro che affronta proprio questo tema dell’improvvisare. Improvvisare, nel suo senso più profondo, non vuol dire agire senza pensare o essere fuori luogo, ma implica costruire opere d’arte, ma anche costruire delle vite, in cui non tutto è già definito, programmato e razionalizzato.
Mi capita di raccontare nei miei viaggi di alcuni mondi che frequento, luoghi che non sono affatto fuori dal mondo o primitivi, ma dove c’è una forte componente di vita quotidiana che resiste alla pianificazione eccessiva che invece domina le nostre società moderne. Parlo dei popoli che noi chiamiamo “indigeni”, che vivevano già nei luoghi che sono stati colonizzati, e una delle loro domande di decolonizzazione è proprio questa: liberarsi dalla razionalità e dalla pianificazione eccessiva delle vite, che è il grande peso della colonizzazione. Spesso nelle nostre società tutto è definito fin da subito. La scuola è un percorso prestabilito, la vita è come un copione che devi seguire, e la “vittoria” dipende da quanto sei veloce nel seguirlo. Ma l’idea che propongono questi popoli è che, invece, ci siano possibilità alternative, spazi di libertà, e l’arte diventa il luogo in cui queste alternative possano essere esplorate. Non c’è una sola strada da percorrere. L’artista, in questa ottica, rivendica la libertà dell’improvvisazione, dove non si sa da dove partirà il cammino, né quale sarà il risultato finale. È la libertà di non avere il controllo assoluto, di vivere senza un piano preordinato, proprio come accade nelle sfere di Pellini.
Mi chiedevi del concetto di “semiolimia”. Semiolimia è un termine che ho introdotto per descrivere l’impressione di vivere in un mondo dove la realtà è dominata dai simboli, dalle parole e dalle rappresentazioni. Noi suoi corsi di filosofia, Gianni Vattimo ci parlava dell’epoca della rappresentazione del mondo, un’idea elaborata da Martin Heidegger. Le mie esperienze di viaggio mi hanno messo davanti al fatto che esistono mondi sociali in cui il simbolico si “dirada”, dove non ci sono cartelli stradali, pubblicità, semafori o segnali visivi che ci sommergono come nella nostra quotidianità. La realtà di questi luoghi è meno densa di quei simboli che noi percepiamo come unici accessi alla realtà stessa.
In alcune isole, come nel nord della Nuova Caledonia, non ci sono segni della simbolizzazione che invade le nostre città. Le case sono come nascoste dalla vegetazione, i cartelli stradali mancano, non ci sono pubblicità o luci lampeggianti. Questo non significa che non esistano simboli in quei luoghi, ma è come se questi fossero meno ossessivi, meno pervasivi. E questo è un punto importante, perché, come semiologi direbbero, la realtà non esiste senza simboli. È vero che l’unico accesso alla realtà passa attraverso i simboli, ma a volte ci sembra che questi simboli ci opprimano, come nel caso delle balene di plastica che vengono esposte nelle città come se la rappresentazione fosse più importante della realtà che dovrebbe rappresentare.
La semiolimia è proprio questa ossessione dei simboli che ci allontanano dalla relazione diretta con i non umani. Può l’arte reintegrare questa relazione? Rimetterci in dialogo e in pace con gli spazi di vita spontanea e tangibile dell’incolto? Mi pare che Fossi io teco fornisca proposte molto interessanti.
GRETA MARTINA
Per me, questo è stato un argomento di cui trattare non perché io abbia assolutamente una risposta definitiva, ma perché, riguardando poi quella che è la mostra, o comunque il progetto espositivo, l’idea principale, o comunque l’attenzione che secondo me è stata data, sia da parte mia sia dagli artisti, è un’attenzione relativa al processo che porta effettivamente poi al risultato. Quello che è il simbolo e il processo assumono un ruolo fondamentale. Il processo, nel caso specifico, non è visto come qualcosa che porta solo al prodotto finale, ma è esso stesso protagonista. Questo procedere ha una peculiarità, un elemento distintivo: si svolge spesso a partire dal luogo e ritorna nel luogo in cui esso ha avuto inizio. È un processo che si nutre di materiali fragili e umili, che non hanno la pretesa di essere grandiosi. Alcuni dei lavori, per esempio, sono realizzati in carta, cartoncino, terra o addirittura il suono, che è semplicemente stato raccolto e registrato. Quindi c’è un’attenzione per le piccole cose, per quella meraviglia che nasce nel sapersi meravigliare di ciò che ci circonda. Questa meraviglia non deve essere necessariamente un simbolo di dimensioni gigantesche, ma si trova nel riscoprire anche l’importanza del più piccolo elemento che possiamo notare.
Poi, sicuramente, il ritmo di questo processo è un altro punto fondamentale. Come dicevo prima, il processo è lento, come per i Corridori lenti, appunto, lenti che sono anche nel titolo, che è emblema di questa idea. È un processo ripetitivo, quindi non si tratta di qualcosa che si compie velocemente, ma di un processo che si svolge con lentezza, meditazione e ripetizione. C’è una stessa gestualità che viene ripetuta, come se fosse un mantra che l’artista deve ripetere più e più volte, e questo implica una certa pazienza, da parte dell’artista prima di tutto. È proprio questa lentezza che caratterizza il processo, un processo meditativo che si distacca da un’idea di velocità o immediatezza, e che alla fine porta alla realizzazione di quello che è l’oggetto in sé. Quest’oggetto però non è necessariamente qualcosa che possiamo percepire a livello visivo: il suono è protagonista di questo progetto e non solo nel senso tradizionale, ma nel senso che se entri in mostra ti rendi conto che lo spazio non è particolarmente pieno di oggetti. La visibilità degli oggetti è volutamente contenuta, ma l’idea che ci sia un movimento è fortemente presente, non tanto quello degli oggetti esposti, ma soprattutto quello dello spettatore. La vera azione, il vero movimento, è quello dello spettatore che entra nel contesto espositivo. È come se lo spettatore entrasse a “abitare” lo spazio della mostra, interagendo con esso. I lavori sono stati concepiti in modo che possano essere appesi o posizionati su plinti di diverse dimensioni. E mi ha colpito molto osservare come, entrando in mostra con alcuni visitatori, questa idea di movimento e di dinamica si riflettesse anche nel linguaggio curatoriale, che ha cercato di abbracciare l’idea di cammino, di ricerca, di scoperta. In mostra ci sono delle piccole casette, così piccole da dover essere ricercate. Quindi il movimento non è solo legato al corpo che cammina, ma anche allo sguardo che si muove nel cercare e nel percepire.
Penso che questa possa essere una via da esplorare: un’esposizione che non sia solo incentrata sull’oggetto esposto, ma che riconosca la presenza umana, non solo come fruitore passivo ma come attore che interagisce con lo spazio. Il concetto di movimento, in questo caso, assume una doppia valenza: è fisico, ma anche visivo, cognitivo. Un’esperienza che non è predefinita, ma che si costruisce attraverso l’interazione e la partecipazione attiva.
Il formato di questa mostra e dei suoi eventi non è uno che punta alla coesione sociale nel senso tradizionale, in cui tutti sono uniti in un grande incontro. C’è una certa apertura, una fruizione libera che permette a ciascun individuo di vivere l’esperienza in maniera autonoma, senza una precisa sequenza temporale. Non c’è bisogno di essere lì esattamente alle 18:00, per esempio, in un preciso pomeriggio. Ma questo formato, pur non mirando alla coesione immediata, apre spazi di incontro che sono programmati. Ci sono eventi che si ripetono, ogni mese, creando appuntamenti che richiamano una collettività di persone diverse, che si incontrano per fare esperienza dell’arte. In questo formato, non si partecipa a una performance già realizzata, ma si è parte di essa, si è parte del processo. Si entra in relazione con l’artista, con il lavoro e con il territorio che ci ospita.
Un esempio chiave di questo processo sarà l’evento di maggio, che coinvolgerà il gruppo O Thiasos Teatro-Natura, una compagnia teatrale che proporrà uno spettacolo itinerante in un contesto verde, che diventa palcoscenico insieme agli artisti. La particolarità di questo spettacolo è che non si svolgerà in un teatro, ma nello spazio naturale che diventa parte integrante dell’evento. La partecipazione del pubblico non sarà più quella passiva di chi osserva, ma attiva: il pubblico camminerà, si sposterà e interagirà con gli spazi e gli artisti. Sarà una vera creazione condivisa con lo spettatore, che non sarà più solo spettatore ma partecipante del processo creativo.
Questo modello di eventi, che integra performance, concerti e spettacoli teatrali, mira a una maggiore inclusione, evitando la struttura tradizionale dove pochi parlano a tanti. In una società che si auspica essere democratica e polifonica, la voce non deve più essere esclusiva di pochi, ma estesa a tutti. Questa è la direzione verso cui dovremmo andare: un’esperienza collettiva che si costruisce insieme, un cammino condiviso dove l’arte non è solo uno spettacolo, ma una continua interazione e scoperta. Ecco perché credo che la partecipazione stessa, l’esperienza vissuta, diventi il vero valore di questi eventi.
Tuttavia, questa è la mia opinione. Naturalmente, ognuno ha una propria visione su cosa l’arte rappresenti, e questa è una questione che rimarrà sempre aperta e in continua evoluzione.
SARA FUMAGALLI
Una cosa che mi ha colpito molto è la sinergia che si crea tra il concetto dell’incolto, di cui parlava Adriano Favole poco fa, e la proposta degli artisti. All’inizio, nella mia visione romantica del verde, mi ha sorpreso che essi non cercassero dei luoghi “fuori”, cioè nel verde, nei boschi, nelle colline, lontano dalla città. Al contrario, gli artisti hanno scelto luoghi dove la natura e la cultura, intesa come espressione della creazione umana in termini storici, architettonici e urbani, sono co-presenti. È proprio questo l’aspetto interessante: l’ascolto attivo della natura non esclude nessuno dei due termini – né la natura né la cultura.
E in questa scelta c’è un elemento chiave che è l’integrazione di questi due mondi, in cui la performance diventa un’esperienza di consapevolezza e riflessione senza che venga verbalizzata esplicitamente, piuttosto vissuta. Quando ci si trova in un contesto urbano, il concetto di riscoperta della natura all’interno della città, e non mi riferisco ai parchi urbani, ma alla vita che si può contemplare in una balconiera, o a quella che possiamo osservare fra i cespugli lungo una strada di città, non è solo un’esperienza di contemplazione passiva, ma un’esperienza di attivazione, un processo di osservazione attenta che invita le persone ad accorgersi dell’incolto, della natura che, pur essendo così vicina, è spesso ignorata.
Forse le scelte che gli artisti hanno fatto rispetto ai luoghi per condurre le loro performance, posso essere considerate una possibile risposta alla domanda che ha posto pocanzi: come portare l’arte a un livello che non sia solo simbolico?
Da ultimo una domanda, le scienze contemporanee, come le neuroscienze, riportano l’attenzione su come fin dai primissimi istanti di vita sia determinante per lo sviluppo dell’essere umano sia in termini biologici sia culturali, la relazione con l’altro. Come incidono questi studi su concezione dell’essere umano?
ADRIANO FAVOLE
La nozione di plasticità cerebrale è proprio questa: l’idea che la relazione e il confronto con gli altri, e con l’ambiente, siano responsabili della formazione dei nostri microcircuiti cerebrali. In fondo, la seconda metà del Novecento per le neuroscienze è stata una vera rivoluzione, perché si è passati dall’idea di un cervello che cresceva sostanzialmente programmato da una genetica ferrea a quella di un cervello che è in continua trasformazione. Quando lavoravo, qualche anno fa, su questi incroci tra antropologia e neuroscienze con il collega Stefano Allovio, avevo notato come molti neuroscienziati utilizzino tantissimo la metafora della scultura, o della potatura degli alberi. Il cervello, infatti, è come un albero da potare, bisogna dargli una forma. C’è quindi questa dimensione, questa ecologia delle relazioni, l’ecologia della mente. Mi viene in mente un libro che si intitola Verso un’ecologia della mente di Gregory Bateson, un famoso antropologo. L’ecologia della mente è un’ecologia della relazione.
Tra l’altro, ho discusso spesso dei temi dell’incolto anche con gli psicanalisti, che hanno visto nell’idea dell’incolto un richiamo all’inconscio. C’è questa dimensione parzialmente coltivata, che si sottrae alla razionalità, ma che non è mai completamente “selvaggia”, come il campo che torna alla sua dimensione naturale, ma non del tutto, perché in realtà l’ambiente in cui viviamo è sempre una sintesi di coltivato e incolto. Un esempio interessante è l’Amazzonia. Per anni abbiamo pensato all’Amazzonia come l’ultima grande foresta incontaminata del mondo, ma non è affatto così. L’Amazzonia è una foresta co-costruita dalle centinaia di migliaia di persone che vivevano in quell’ambiente prima dell’arrivo dell’Occidente. In realtà, la foresta amazzonica è un ambiente completamente ricostruito: le piante sono state spostate, selezionate e rimesse in un dialogo con gli spazi umani. Oggi, grazie ai rilievi aerei, sono state ritrovate più di cinquanta piccole città e una rete stradale che univa gran parte del territorio.
Quindi, questa idea che la natura esista senza dialogo, senza relazione, è un’idea romantica. Qualcuno di voi l’ha definita così, ma è talmente radicata nel senso comune che facciamo fatica a venirne fuori. Per noi, l’idea di natura è molto legata a un concetto separato: noi e la natura, come se fossero due entità distinte.
Q&A
Avrei un’ultima considerazione: quando avevi iniziato a parlare, io, essendo architetto, ho subito pensato a Gilles Clément, che per noi è una specie di mito, soprattutto per la mia generazione, perché ha davvero rivoluzionato il pensiero sull’intervento umano nel paesaggio, sull’arte dei giardini. Quando ho studiato architettura, c’era una disciplina che si chiamava arte dei giardini, ma ora non c’è più, ed è un paradosso. Oggi, il paradosso sta nel fatto che, per esempio, lungo il nostro sentierone (ndr Via XX Settembre, Bergamo), il progetto del centro piecentiniano, che è stato recentemente riqualificato, include quelle aiuole che, credo, siano ancora oggetto di dibattito tra pensionati che si trovano sulle panchine e si chiedono “ma che aiuole sono queste?”. In realtà, quelle aiuole sono state pensate secondo la logica del “terzo paesaggio” di Clément, che auspica la spontaneità.
E la spontaneità è un concetto su cui potremmo aprire grandi dibattiti: che tipo di spontaneità? L’essenza che va a costruire l’aiuola non dovrebbe più essere quella che ricerca l’accordo cromatico o il disegno complessivo, come avveniva in tutta la storia dell’arte dei giardini. C’è sempre stata una rincorsa da una parte alla rappresentazione di una natura che non è più quella naturale, ma quella immaginata dall’uomo e rappresentata. E dall’altra, c’è il mantra dell’ecologia, che però, a sua volta, diventa un paradosso. Così, ci ritroviamo a voler un’apparente spontaneità che forse ritorna ad essere quella pittoresca dei giardini all’inglese, con i salici, le collinette, i percorsi curvilinei, invece della geometria della razionalità rinascimentale e classicista. In effetti, continuiamo a inseguire un’idea che forse ci sfugge.
E in tutto questo, forse l’architettura porta sempre con sé quell’idea di progetto come principio di trasformazione. Ha in sé l’essenza e la volontà di affermare una condizione di pensiero e di azione che comunque produce qualcosa di diverso da ciò che è l’oggetto su cui si esercita il nostro abitare complessivo.
Q&A
Da qualche tempo a Milano hanno iniziato a ridurre il periodo di taglio delle aiuole del verde pubblico e anche nei parchi. In passato, il taglio era molto serrato, ora invece si stanno dilungando i tempi, il che ha portato al ritorno di molti fiori di campo e di specie di insetti, permettendo di fatto a tutti gli organismi, animali e piante che li abitano, di completare i loro cicli vitali.
ADRIANO FAVOLE
Questa opposizione, che ora semplifichiamo in natura-cultura, è molto radicata nel nostro pensiero, è parte del senso comune. Noi antropologi, quando parliamo di senso comune, ci riferiamo a quei saperi che ci sembrano ovvi e scontati, come se “le cose stiano così” e non ci sia niente da discutere. Ma, in realtà, questo senso comune è un modo di vedere le cose che si mette in discussione quando fai un salto e provi a vedere le cose da un altro punto di vista, che sia storico, antropologico o artistico.
Questo discorso si riflette molto nel linguaggio e nelle pratiche quotidiane. Se cominci a pensare che un prato è bello anche se ha una varietà di erbe diverse, invece di vederlo solo come un campo monocromatico di erba selezionata, ti rendi conto di quanto questo sia radicato. Non è che le persone non abbiano sensibilità per l’ambiente, è la cultura in cui siamo cresciuti che ci ha insegnato a vedere le cose in un certo modo. Non è che il mio vicino di casa non abbia sensibilità, ma se vede un’erba diversa nel prato, va davvero in crisi. Se vede una foglia grigia in mezzo al verde, scatta in lui la necessità di prendere la macchina infernale che soffia per spostarla, e questo nonostante il vento finisca per riportarle di nuovo lì. Sono battaglie perse, ma noi ci sentiamo esseri umani facendo questi gesti, perché è così che ci è stato insegnato a fare: lottare, mettere le mani, tagliare l’albero. Però c’è una crescente sensibilità verso questi temi. Quando oggi un’amministrazione decide di abbattere un albero perché è malato o per motivi di sicurezza, può essere denunciata subito, quindi c’è segno di cambiamento, una maggiore attenzione al dialogo con i non umani.
Mi è venuta in mente una foto che ho fatto tempo fa. È interessante come a volte ti si fissa un tema e poi ovunque vai, lo ritrovi. Molti anni fa ho scritto un libro sulla morte e da allora vedevo solo cimiteri, adesso invece vado a cercare le erbacce. Ricordo un posto in Francia, in un’area abbandonata, dove su un garage c’era una scritta che ho poi scoperto essere una citazione di un poeta francese. La frase recitava più o meno così: “L’erbaccia è solo un vegetale che ha imparato tutte le abilità di sopravvivenza, tranne che stare nei ranghi”. Era divertente, una riflessione che rivalutava l’erbaccia, e che ci fa vedere che non siamo i soli a riconoscere il valore di queste piante. Insomma, il discorso ci ha portato lontano dall’architettura, ma è interessante come le idee evolvono anche nel nostro rapporto con la natura.