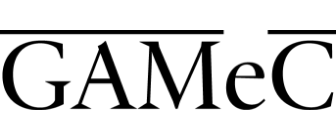Cara Montagna è una corrispondenza. Un gesto di ritorno, di ascolto, di prossimità. È scrivere una lettera sapendo che, in questo caso, la risposta, se arriverà, sarà fatta di vento, silenzi, marmotte o aquile, odori di bosco, scrosci d’acqua.
Il primo episodio di questa serie di podcast racconta dell’essere in cammino. Muoversi nello spazio con i piedi, a contatto con il terreno, significa attivare una forma di pensiero lenta e sensibile, in ascolto del paesaggio e dei suoi ritmi profondi. Come scrive Erling Kagge, alpinista e scrittore, nel suo libro Walking, “camminare è perdere tempo per guadagnare spazio” — un atto minimo che ci restituisce alla dimensione del presente.
Cara Montagna sarà presto online. In attesa del suo lancio, pubblichiamo la trascrizione della conversazione tra Ilaria Gadenz ed Elena Biserna, una delle voci di questo primo appuntamento.
Elena Biserna (1982) è un’artista e dottore di ricerca in studi audiovisivi. I suoi interessi vertono, in particolare, sul suono espanso, sull’ascolto e sulle pratiche contestuali, effimere, partecipative nelle loro intersezioni con le dinamiche urbane, la sfera quotidiana e i processi socio-culturali.
Tra i suoi progetti più significativi, Walking from Scores esplora la notazione come invito all’azione in relazione al cammino e al movimento, pensati come modalità privilegiate per interagire con il contesto e la vita quotidiana. Il progetto si traduce in una raccolta di “istruzioni per camminare”, in cui ascolto, spazio, corpo e gesto si intrecciano. Il titolo stesso gioca volutamente con Working from Scores, il testo scritto da Ken Friedman nel 1990. Friedman riflette sulla natura processuale e aperta dell’opera d’arte, paragonandola a uno spartito musicale.
Anche il cammino può essere letto così: una partitura temporale, una coreografia vivente che prende forma nella relazione con il contesto, il corpo, il tempo.
Cara Montagna è un podcast curato da Ilaria Gadenz, ideato con Valentina Gervasoni.
ELENA BISERNA
Il camminare è ormai riconosciuto come gesto artistico accettato nelle pratiche e teorie dell’arte, ma inizialmente non lo era. È stato utilizzato dagli artisti per uscire dagli spazi dell’arte, per rivolgersi a pubblici diversi, per entrare nella quotidianità e nella sfera sociale. È un modo per essere presenti, visibili e udibili nello spazio pubblico.
Negli anni Sessanta, molti artisti iniziano a camminare come gesto di ri-appropriazione dello spazio pubblico, di condivisione e di critica alla rigidità disciplinare accademica. Il camminare attraversa danza, teatro, arti performative, musica, arti visive, diventando un punto di incontro tra pratiche e persone che vogliono mettere in discussione i confini delle discipline artistiche.
A dire il vero alcuni primi esempi di escursioni artistiche si trovano già nelle avanguardie storiche.
La famosa passeggiata dadaista a Saint-Julien-le-Pauvre ne è un esempio: una visita guidata che portava i partecipanti in luoghi “senza motivo d’esistere”, in opposizione alla Parigi turistica. È una prima uscita dall’idea di rappresentazione del camminare verso l’azione concreta. Anche i surrealisti esplorano la passeggiata notturna, ma è proprio negli anni Sessanta che si crea un vero clima di relazioni interdisciplinari. C’è un interesse per l’azione ordinaria e infraordinaria che attraversa danza (con, fra gli altri, Merce Cunningham e Anna Halprin), letteratura, arti visive, musica. Si cerca di uscire dalla rappresentazione e dai media tradizionali, di criticare le istituzioni artistiche e i loro spazi commerciali.
È negli anni Sessanta che il camminare diventa una pratica importante per chi vuole lavorare con nuovi pubblici, fuori dai circuiti commerciali e istituzionali. Con il libro Going Out mi interessava colmare un vuoto storiografico: esiste molta letteratura sul camminare nelle arti visive, molto meno nelle pratiche sonore e di ascolto. E quando si parla di ascolto e cammino si cita quasi esclusivamente la passeggiata sonora canonizzata dal World Soundscape Project. Ho cercato di collegare altre forme, altre genealogie. Ad esempio, i lavori di Dennis Oppenheim o Adrian Piper di quegli anni, in cui il camminare si intreccia con la registrazione, aprono a un campo ampio e non lineare di pratiche che legano cammino, ascolto e produzione sonora nello spazio pubblico.
ILARIA GADENZ
La ricerca che confluisce nel tuo Walking, Listening e Soundmaking è molto legata allo spazio urbano, le pratiche che elenchi accadono in contesto urbano nella maggioranza dei casi. Ti ho invitato a parlare di montagna però e mi chiedo: cosa succede se sostituiamo l’idea di “strada” con quella di “sentiero”, e lo “spazio urbano” con lo “spazio naturale”? Esiste una bibliografia che affronta la natura come spazio pubblico? Possiamo parlare di “pubblicità” anche negli ambienti naturali?
ELENA BISERNA
È una domanda molto interessante. Secondo me non solo è possibile considerare gli spazi non urbani come spazi pubblici, ma è addirittura necessario. In un momento storico in cui l’ecocidio è imminente, è fondamentale rivendicare il carattere pubblico della natura e la sua dimensione di commons, anche in ambienti come la montagna. Quindi mi sembra proprio necessario immaginare che la montagna sia uno spazio da appropriare tanto quanto quello della piazza.
Penso si debba guardare un po’ più alla letteratura nel campo dell’ecologia critica ma credo sia utile guardare anche ai saperi non occidentali, alle forme di relazione con la natura che la modernità coloniale ha cercato di cancellare in territori come il Nord America, l’America Centrale e Meridionale, o l’Australia. Questi saperi propongono modi alternativi di abitare e attraversare lo spazio naturale, diversi dalla nostra visione cartografica e oggettivante dello spazio.
ILARIA GADENZ
Sì, mi pare che rispetto all’epistemologia occidentale, la conoscenza dello spazio che emerge dai saperi e dalle epistemologie indigene sia sempre legata a un pensiero planetario, mitopoietico, a una spiritualità che va oltre l’idea di spazio pubblico che è emerso con la costituzione dell’uomo moderno, occidentale. Quindi trovo interessante tu parli di natura come commons ma trovo altrettanto problematica l’idea di riappropriarsi della montagna.
ELENA BISERNA
Hai ragione, è una questione molto complessa che non padroneggio per niente, ma vorrei suggerire una riappropriazione finalizzata alla preservazione della wilderness. Per troppo tempo non ci siamo sentiti in relazione con questi spazi: li abbiamo ridotti a luoghi turistici. Andiamo a sciare, ma non ci sentiamo parte dell’ecosistema montagna. Non sentiamo il legame tra quel paesaggio e il nostro corpo, la nostra vita.
Il mancato riconoscimento della nostra relazionalità con il territorio è legato al modo in cui ci siamo costruiti come individui autonomi e abitanti urbani, con un rapporto di dominazione nei confronti della natura. Questo ci porta a distruggere il territorio, o quantomeno a tollerarne la distruzione. Le popolazioni indigene, invece, non hanno mai perso questa connessione.
Per fare un esempio, l’estate scorsa ho viaggiato in Messico e ho passato molto tempo in montagna. Nei villaggi montani, la relazione con il territorio è di totale identificazione e incarnazione. È un’esperienza che colpisce profondamente, perché mette in discussione radicalmente il nostro modo occidentale di abitare lo spazio naturale.
ILARIA GADENZ
Tornando alla montagna: il camminare in montagna è molto legato, nel nostro contesto, alla storia dell’alpinismo. Una storia recente, che non ha nemmeno trecento anni, e comunque una storia di conquista, moderna, diaristica e cartografica. Una storia di controllo e appropriazione antropica. È possibile problematizzare questa storia?
Nel tuo libro relativizzi l’idea del camminatore che non è un soggetto universale. Chi può camminare, come lo può fare, non è scontato. Allo stesso modo, m’interessa molto l’idea del suono come medium che permea lo spazio planimetrico della mappa e lo complica, una ricerca che mi pare affrontassi già anni fa con l’idea di soundborderscape…
ELENA BISERNA
Mi è venuto in mente un libro molto bello che ho letto a questo proposito: Do Glaciers Listen?. Il titolo è una domanda – “I ghiacciai ascoltano?” – ed è un’indagine sulla relazione tra i primi colonizzatori europei in Nord America e i saperi dei popoli nativi. Mostra bene come gli esploratori europei portassero un immaginario di conquista e appropriazione, in netto contrasto con epistemologie indigene basate su codipendenza con il territorio. Ci sono anche riferimenti all’ascolto. È un testo molto interessante anche in relazione alla ricerca sonora e al podcast Cara Montagna che stai producendo.
Sulla questione dell’universalità del corpo in cammino: la letteratura sul camminare è vasta, interdisciplinare e sottolinea spesso il carattere relazionale del cammino, come modo per acquisire un sapere incarnato e situato, per riscrivere lo spazio urbano, o per rivendicare la dimensione pubblica dello spazio, come dice Rebecca Solnit.
C’è poi l’enfasi sul valore emancipatorio del camminare, come una pratica di cittadinanza, come una pratica democratica, come una pratica accessibile e che dà accesso agli spazi.
È una narrazione che ho condiviso a lungo. Ma a un certo punto ho iniziato a chiedermi: chi può camminare? Come può camminare? Qual è il corpo che cammina? E ho iniziato a mettere in discussione questa idea del camminatore come figura universale.
Il camminare è profondamente legato al corpo, alle politiche dei corpi nella sfera pubblica e allo stesso tempo alle differenti realtà geopolitiche, ai diversi contesti in cui possiamo camminare. Dipende da una serie di identità o identificazioni tra cui il genere, l’orientamento sessuale, il fatto di avere certi documenti oppure no, il peso, l’età, lo stato di salute, il fatto di avere un corpo considerato abile o bene, o la razzializzazione. Non tutti i corpi possono camminare ovunque, in ogni momento. E non tutti i territori sono ugualmente accessibili.
Esistono testi fondamentali su questo, come quelli di Garnette Cadogan, che racconta quanto sia rischioso camminare di notte per una persona razzializzata in una società suprematista bianca: si diventa automaticamente sospetti, soggetti al controllo della polizia e allo sguardo diffidente degli altri.
Ci sono esempi storici, come quello di Abdelhafid Khatib, algerino, unico membro razzializzato dell’Internazionale Situazionista. Non riuscì a completare la mappatura psicogeografica di Parigi perché, in quel momento – siamo negli anni Sessanta – intervenne un coprifuoco che impediva alle persone razzializzate e in particolare alle persone con origini nordafricane di uscire la sera e che quindi diventava un vero e proprio momento di segregazione di una parte della popolazione parigina. Un caso emblematico di come il camminare possa essere impedito per ragioni politiche e razziali.
Questo è un campo su cui ho cercato di lavorare, a partire dalla mia esperienza e dalle mie identificazioni. Ho anche iniziato un progetto chiamato Feminist Steps, una continuazione di Walking from Score. Sono passeggiate notturne con gruppi di donne e persone non binarie, pensate per ribaltare assegnazioni come silenzio/visibilità, presenza/invisibilità, attraverso delle partiture scritte da me e da Pauline Oliveros.
Sulla montagna, c’è anche un libro che mi ha prestato una collega: Méfiez-vous des femmes qui marchent (“Non fidatevi delle donne che camminano”), che raccoglie moltissime storie di donne camminatrici in montagna.
ILARIA GADENZ
Rispetto a questo ultimo punto, pensavo a quanto la narrazione contemporanea delle donne in montagna, così come quelle in radio, nella musica elettronica rischi di ribadire il cliché del pioniere, di confermare che questi corpi siano eccezionali perché estranei a degli ambienti che vogliono conquistare…. E hai mai letto The Sonic Color Line di Jennifer Lynn Stoever? Parla di come il suono e la voce siano stati utilizzati nelle politiche di profilazione raziale via etere, nella radio Americana degli Anni Quaranta…
ELENA BISERNA
Sì, lo conosco. È un riferimento molto importante anche per me insieme agli scritti di Nina Sud Eidsheim. Tra l’altro, per l’aneddoto, mi è anche capitato che mi rifiutassero un’intervista in radio in Francia a causa del mio accento italiano.
ILARIA GADENZ
Esiste un fenomeno interessante studiato da Katie Moylan, si chiama accenting e fa riferimento a quelle pratiche radiofoniche, che attraverso produzioni “accentate” articolano identità diasporiche, marginalizzate per resistere al canone linguistico omogeneizzante e dominante dell’inglese stile BBC. È una strategia resistente, per rivendicare la propria identità attraverso la voce.
ELENA BISERNA
Non conoscevo il termine accenting, ma lo trovo molto potente. Come parlante non madrelingua, sento fortemente il controllo linguistico nei media e non solo. Rivendicare il proprio accento può diventare un atto antinazionalista, contro il modello dello Stato-nazione. Bellissimo esempio quello delle radio comunitarie…
ILARIA GADENZ
Per chiudere, torniamo al rapporto tra ascolto e cammino, abbiamo parlato di relazionalità, di conoscenza incarnata…
ELENA BISERNA
Il primo legame tra cammino e ascolto è proprio la relazionalità. Camminare ci porta a entrare in relazione con i territori che attraversiamo, e l’ascolto ci espone costantemente agli altri e al mondo. Il suono è vibrazione, ci attraversa e ci rende porosi, vulnerabili.
Questa vulnerabilità può diventare un modo per dichiararci in codipendenza e interdipendenza con gli spazi e gli esseri viventi, umani e non umani, con cui coesistiamo. È, per me, il nucleo della pratica dell’ascolto e anche del camminare: esporci, lasciarci attraversare, riconoscere le fragilità, vivere e abitare la vulnerabilità come forma di conoscenza.