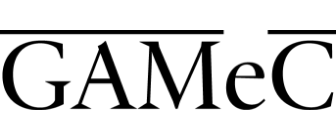Il secondo appuntamento del ciclo Incontri ha visto protagonisti la ricercatrice e tecnica faunistica Elena Bassi insieme a Michela de Mattei e Invernomuto, artisti e registi di Paraflu.
Il confronto, di cui pubblichiamo un estratto, si è concentrato sul tema della ricomparsa del lupo in diverse zone d’Italia, e ha analizzato la figura di questo predatore, simbolo di indipendenza e conoscenza, conflitto e trasformazione.






VALENTINA GERVASONI
Pensare come una montagna nasce da un incontro con un lupo. Mi riferisco a quanto descritto nell’omonimo capitolo di A Sand County Almanac dal suo autore Aldo Leopold, episodio cruciale per lo sviluppo del pensiero ecologico moderno. Leopold racconta di come solo incrociando lo sguardo morente della lupa, a cui lui stesso – cacciatore – aveva sparato, si rese conto dell’impatto di quel gesto sull’ecosistema montano.
I lupi ricordati nello sviluppo di questo progetto sono anche quelli inseguiti da altri, con intenzioni diverse dalla predazione.
La ricerca iniziale degli artisti intorno a Paraflu prende avvio da Baptiste Morizot, che in Sulla pista animale, parla di tracciamenti su grandi predatori. Parla del lupo, parla del grizzly, parla della pantera delle nevi. Per Morizot la possibilità di questo incontro esige una sensibilità sottile alle relazioni ecologiche che ci intrecciano insieme nei territori viventi, esige un decentramento. Questa pratica di relazione con la “natura” è da lui definita “inforestamento”, ovvero un andare nella foresta tanto quanto essa si possa trasferire in noi. Questo libro ne richiama per me un altro, che voglio citare in apertura al nostro incontro.
È La pantera delle nevi di Sylvain Tesson, giornalista e scrittore francese.
Tesson viene invitato dal fotografo naturalista Vincent Munier ad andare in Tibet alla ricerca degli ultimi esemplari della pantera delle nevi. Altro animale sfuggente.
L’apparizione si manifesta osservando una foto. Un falco in primo piano. E dalla cresta della montagna, mimetizzata tra le rocce, la pantera delle nevi li osserva.
Come scrive lo stesso autore, il suo sguardo non l’avrebbe mai scoperta senza aiuto perchè cercava di vedere solo una presenza immediata. I nostri occhi cercano sempre la cosa più facile. Ma nella natura noi siamo osservati. Paraflu è costruito partendo dal considerare, come Morizot invita a fare, il lupo come possessore dell’arte magica del depistaggio.
Se l’inforestarsi prevede un decentramento ciò significa anche interrogarsi rispetto, non solo le tracce visibili, ma anche alle tracce invisibili, perché per seguire la pista siamo obbligati a spostarci nella testa dell’animale. A noi verrebbe naturale pensare che il lupo di fronte alla radura vada avanti, prosegua il suo cammino, in realtà non è così. Poi magari Elena Bassi ci dirà che sto dicendo castronerie, ma Morizot spiega come umanamente tendiamo a immaginarlo proiettato in avanti, e come in realtà lui torni sui suoi passi per circumnavigare la radura. È qui che noi perdiamo le sue tracce.
Ma tracciare sui sentieri implica l’essere tracciabili.
“Chi ti guarda mentre scruti un’impronta?”
Il rapporto oggettivante nei confronti del vivente si rovescia. Viene superata la forma gerarchizzante, cade quel modo di abitare il mondo proprio del colonialismo, del capitalismo e del patriarcato basato sull’affermazione della differenza e della non identità attraverso il più complesso concetto di identità dominante e universale che, per dirla in estrema semplificazione, ha portato a uno sfruttamento del femminile e della natura, inevitabilmente considerati inferiori, perché in una logica duale di presenza/assenza l’altro è sempre definito come assenza, di qualità, di caratteristiche, di ideali.
È la filosofa ecofemminista Val Plumwood che ben descrive come la cultura occidentale abbia sempre trattato per dualismi, ivi compreso il rapporto uomo/natura. Molti degli aspetti problematici del trattamento della natura da parte dell’Occidente, alla base della crisi ambientale, sono inscritti nella costruzione occidentale dell’identità umana come natura “esterna” (Val Plumwood, Feminism and the Mastery of Nature, Routledge, New York 1993).
Paraflu ci invita a riflettere sulle pratiche della visione, del visibile e dell’invisibile, sulle pratiche dell’ascolto e anche sulle pratiche dell’inforestamento, che sicuramente gli ospiti di questo incontro hanno attraversato a diverso titolo.
Simone Bertuzzi e Simone Trabucchi collaborano come Invernomuto dal 2003. Con Michela de Mattei hanno realizzato questo film che attraverso prospettive plurali racconta del ritorno del lupo sulle Alpi. Li accompagna Elena Bassi, tecnica faunistica che da anni studia il lupo con focus sull’ecologia alimentare di questo predatore.
MICHELA DE MATTEI
Nel lavorare a questo film abbiamo attivato tantissimi canali di ricerca. Una delle persone con cui abbiamo lavorato è proprio Elena Bassi. Nel film Elena è presente mentre esegue Wolf howling. Senz’altro Paraflu nasce molto da una dimensione di ascolto, quindi nel cercare di osservare piuttosto che tentare una sintesi intorno al lupo. È un argomento molto polarizzante che suscita tante passioni.
ELENA BASSI
Mi interesso di lupi dal 2008 e attualmente collaboro al progetto Life Imagine, un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma LIFE, dedicata al monitoraggio dei grandi carnivori in Umbria. Mi occupo in particolare del lupo e dell’orso marsicano—anche se, finora, di orsi non ne ho ancora avvistati, ma spero che accada presto.
Nel corso degli anni, ho sperimentato diversi metodi di monitoraggio, dalla tracciatura delle impronte al marcamento genetico. In particolare, seguire le tracce sulla neve mi ha sempre dato la sensazione di essere sia osservatrice che osservata. Chiunque abbia incontrato un lupo racconta la stessa cosa: è un fantasma, non lo senti arrivare, lo percepisci per un istante e, appena ti giri, è già scomparso. Anche quando la popolazione era più ridotta e intercettarli era ancora più difficile, il lupo restava un animale elusivo. Per questo, la maggior parte delle tecniche di monitoraggio si basano su segni indiretti della sua presenza: nessuno si aspetta davvero di vederlo.
Una delle tecniche più affascinanti è il wolf howling, che sfrutta la naturale tendenza dei lupi a rispondere agli stimoli acustici. Viene applicata in estate, quando ci sono i cuccioli che, ancora inesperti, rispondono a quasi ogni suono. L’ululato è una forma di comunicazione che può coprire distanze fino a tre chilometri e viene utilizzata non solo per segnalare la propria presenza ad altri branchi, ma anche per comunicare all’interno del nucleo familiare, composto dai genitori e dai loro figli di diverse generazioni. È un sistema per coordinare le attività del branco, evitare incontri pericolosi con altri lupi e, nei periodi di dispersione, capire se un territorio è già occupato.
Farli rispondere non è semplice: sono animali estremamente intelligenti e prudenti. Tuttavia, questa tecnica funziona e regala momenti unici. Ritrovarsi di notte, nel bosco, al buio, ad ascoltare i lupi che rispondono all’ululato è qualcosa di magico. Attraverso il wolf howling, possiamo stimare il numero minimo di individui in un branco e verificare la presenza di cuccioli. Quando i piccoli rispondono, gli adulti intervengono per segnalare la loro presenza e proteggere la risorsa più importante del gruppo.
L’ululato è anche una metafora della condizione del lupo: supera i confini, attraversa territori che gli animali non percepiscono come separati, sfida l’idea umana di limite. Spesso parliamo di aree protette come spazi chiusi, ma i lupi non vedono confini: seguono le loro traiettorie, si muovono liberamente, adattandosi a un mondo che cambia. Per questo motivo, oggi abbiamo strumenti più avanzati, come le fototrappole, che ci aiutano a osservarli senza interferire con la loro natura schiva.
Il lupo porta con sé una memoria collettiva di persecuzione: fino agli anni Settanta è stato cacciato e braccato, e ancora oggi sa che gli esseri umani possono rappresentare una minaccia. Questo lo rende prudente, lo spinge a evitare il conflitto. E, allo stesso tempo, ci ricorda che la vera sfida è imparare a coesistere. Non significa accettare un lupo nel giardino di casa, ma comprendere che, se si vive in mezzo a un bosco, la presenza di questi animali è parte dell’ambiente. La chiave è trovare un equilibrio, come fanno da sempre pastori e cacciatori.
SIMONE BERTUZZI
Ci raccontavi che quando fate wolf howling usate sempre la stessa traccia audio, ovvero la stessa registrazione di lupi —che tra l’altro è una registrazione piuttosto compressa e di scarsa qualità. Oltre a quella registrazione, in Paraflu, abbiamo usato anche una sound library professionale realizzata da Dmitry Chernov a partire da una serie di registrazioni di vari branchi di lupi. Però per noi è curioso immaginare che nella bassa qualità o nella estrema compressione in realtà ci sia o possa esserci più risposta da parte degli animali.
ELENA BASSI
Mi sono sempre chiesta se i lupi percepissero davvero il nostro ululato e, soprattutto, come lo interpretassero. Nella ricerca scientifica, siamo obbligati a standardizzare gli stimoli per evitare fattori che possano influenzare le risposte. Se uno stimolo fosse qualitativamente migliore di un altro, il risultato della nostra ricerca potrebbe dipendere da questa variabile anziché dalla reazione autentica degli animali. Per questo motivo, abbiamo registrato due lupi in cattività, senza sapere esattamente quale messaggio stessero comunicando.
Ogni anno, durante le sessioni di wolf howling, seguiamo sempre la stessa procedura: usciamo di notte, scegliamo delle stazioni di emissione e, in ogni punto, emettiamo due ululati. Il primo è a volume più basso, per evitare di risultare troppo invasivi nel caso i lupi si trovino nelle vicinanze. Dopo aver ululato, aspettiamo due minuti e mezzo in ascolto passivo. Se non riceviamo risposta, ipotizziamo che possano essere più lontani e quindi ripetiamo l’ululato a un volume più alto, attendendo poi altri tre minuti. Questo metodo è sempre uguale, eppure, nonostante abbia stimolato gli stessi branchi più volte in una stagione e di anno in anno, i lupi continuano a rispondere. Non si abituano a questo stimolo, ma reagiscono ogni volta, confermando l’efficacia del metodo.
Un aspetto interessante è che la frequenza delle vocalizzazioni dei lupi è molto simile a quella umana, il che significa che anche ululare a voce può funzionare. Tuttavia, c’è un limite: se una persona ulula per un’intera notte, inevitabilmente la qualità del suono cala con la stanchezza e i lupi, a un certo punto, smettono di rispondere. Nonostante questo, ho assistito a scene piuttosto curiose: durante alcune uscite di monitoraggio, mi è capitato di essere accompagnata da cacciatori che, dopo aver bevuto abbondanti quantità di vino, sembravano più simili a scimmie urlatrici che a lupi. Eppure, nonostante la scarsa qualità degli ululati, i lupi rispondevano lo stesso. È come se avessero un bisogno istintivo di segnalare la loro presenza e di difendere il territorio, avvertendo che è meglio non avvicinarsi troppo.
MICHELA DE MATTEI
Entrare nel linguaggio dei lupi potrebbe essere percepito come un’invasione del loro territorio. Se un’area è abitata da un branco, l’imitazione dei loro ululati potrebbe essere interpretata come un’intrusione territoriale.
ELENA BASSI
È fondamentale applicare la tecnica del wolf howling con etica, evitando di ripetere le emissioni sonore nello stesso luogo per non disturbare i lupi, soprattutto in presenza di cuccioli. Le registrazioni potrebbero essere percepite come minacciose, inducendo gli adulti a spostare i piccoli, esponendoli a rischi. A differenza di altre metodologie non invasive, questa tecnica richiede particolare attenzione per minimizzare il disturbo agli animali.
MICHELA DE MATTEI
Puoi approfondire il fenomeno della dispersione? In Paraflu ci ha interessato l’analogia tra il lupo e il mago; quando un lupo si disperde, sembra cercare di cancellare le proprie tracce, le urine, il che richiama questa dinamica.
ELENA BASSI
La dispersione è il processo attraverso cui i giovani lupi lasciano il branco natale per cercare un nuovo territorio e formare una famiglia. Avviene solitamente intorno ai due anni, quando gli individui sono maturi dal punto di vista riproduttivo. Spesso sono i genitori stessi a spingerli ad andarsene.
Il fenomeno è graduale: il lupo non parte improvvisamente, ma esplora l’area circostante con cautela, valutando la sicurezza e le risorse disponibili. Il nuovo territorio può essere vicino o simile a quello d’origine, ma per il giovane lupo è sconosciuto, quindi deve muoversi con attenzione. Nelle prime fasi, i lupi in dispersione restano comunque in contatto con la famiglia d’origine, tornando periodicamente prima di staccarsi del tutto.
I maschi tendono a disperdersi prima e a percorrere distanze maggiori, spesso di centinaia di chilometri, prima di trovare un’area idonea e un compagno o una compagna con cui formare un nuovo branco. Le femmine, invece, sono più tollerate all’interno del territorio familiare e possono rimanere nelle vicinanze o addirittura occuparne una parte senza creare conflitti con i genitori. I maschi, al contrario, vengono più spesso allontanati.
VALENTINA GERVASONI
Possiamo raccontare quanto in Paraflu l’ambiente sonoro abbia un ruolo chiave? Da un lato, il suono dell’ocarina, che connota l’incipit del film, sembra realmente emergere dalla nebbia, quasi un richiamo distante, sfuggente. Conferisce al film un’atmosfera sospesa e arcaica, amplificando il senso di mistero che pervade l’intero film. Dall’altro, il parlato che aggiunge un livello narrativo introducendo il tema dell’illusione, della percezione, della relazione di dominio mago-spettatore. Il visibile e l’invisibile, nonché le diverse prospettive portate si intrecciano attorno alla figura del lupo, emblema di una riflessione più ampia sulla paura, il controllo e la relazione tra uomo e natura.
SIMONE TRABUCCHI
Paraflu nasce da una storia che ci è stata raccontata da un amico cacciatore circa un anno e mezzo fa. Questo racconto ha segnato profondamente l’atmosfera del film e la sua direzione. La vicenda si svolge nell’Appennino, in provincia di Piacenza, dove un branco di lupi è stato avvelenato da un cacciatore in seguito a un episodio di conflitto con il proprio cane. La notte precedente, infatti, il cacciatore si sveglia e trova il suo cane agonizzante, attaccato da un branco di lupi. Mosso dal desiderio di vendetta, decide di sacrificare il corpo del suo stesso animale: lo lascia nel cortile, lo cosparge di antigelo—di Paraflu, appunto—e attende. I lupi tornano sul posto e, attirati dalla carcassa, ne mangiano la carne avvelenata. Il mattino successivo vengono trovati tutti sterminati.
Questa pratica, purtroppo, è diffusa, non solo nei confronti dei lupi ma anche di altri animali domestici e selvatici. È una pratica particolarmente crudele, perché, come viene spiegato nel film, l’antigelo non ha un sapore sgradevole, al contrario, pare abbia un gusto dolciastro che attira gli animali, rendendolo un veleno insidioso. Quando abbiamo ascoltato questa storia, abbiamo avvertito immediatamente un’atmosfera da horror.
L’horror, come genere, ci interessa molto proprio per la sua capacità di mettere in scena, costruire tensione e intrattenimento attorno ai nervi scoperti della società: il capitalismo, il patriarcato, la paura del diverso—qualsiasi esso sia.
La colonna sonora nasce da questo e dall’idea di costruire un tema piuttosto ricorrente e quasi ossessivo, utilizzando strumenti legati al territorio. Abbiamo usato l’ocarina, che avevamo già impiegato in un altro progetto, come punto di partenza. A questa si sono aggiunte alcune registrazioni citate in precedenza da Simone, materiali sonori di qualità eccelsa di un sound designer russo che ha seguito e registrato i branchi di lupi. Abbiamo queste soundbank veramente incredibili, alcune, per esempio quelle dei battiti dei denti, sono quasi percussive, estremamente tridimensionali. Tra le registrazioni utilizzate c’è anche Buck e Taiga impiegata per il wolf howling. E poi c’è una fase di rimescolamento, di rielaborazione digitale di questi suoni per costruire la struttura della colonna sonora, su cui si è poi basato il montaggio.
MICHELA DE MATTEI
Il voiceover segue l’analogia tra il lupo e il mago, riprendendo e rielaborando un testo di Dariel Fitzkee, noto illusionista e autore di diversi libri, in particolare sulla misdirection—l’arte di confondere lo spettatore. Il suo manuale per maghi spiega le tecniche per deviare l’attenzione, e proprio questo concetto è stato alla base della nostra riscrittura.
Abbiamo rimaneggiato il testo in profondità, trasformandolo in un elemento che guida il montaggio e introduce un ulteriore livello di misdirection, amplificando il senso di smarrimento e ambiguità nella narrazione. L’obiettivo, in ogni aspetto del progetto—dall’immagine al suono—è stato, come suggerisci, quello di moltiplicare le prospettive, evitando la polarizzazione che spesso accompagna il discorso sul lupo. Abbiamo seguito le tracce lasciate dai ricercatori, dalle immagini e dai percorsi esplorati, e il voiceover sulle tecniche di magia si inserisce perfettamente in questa logica: il lupo stesso gioca con la percezione, sfugge alla definizione univoca.
Molti racconti sugli attacchi dei lupi, ad esempio anche quelli raccolti nelle valli di Bergamo, li descrivono come eventi strategici, quasi sovrannaturali, con le pecore che sembrano saltare autonomamente le recinzioni, come se il branco le avesse indotte a farlo. Le storie che abbiamo seguito—come quella iniziale di Paraflu—mostrano come intorno al lupo si sviluppi una psicosi collettiva, legata forse alla difficoltà di affrontare il suo ritorno. È evidente che una grande parte della sua figura sia frutto dell’immaginazione umana: il lupo diventa un archetipo, una proiezione culturale e simbolica, profondamente legata alla rappresentazione.
Il voiceover riflette questa dimensione, facendo confondere i personaggi fino a rendere indistinguibile la realtà.
SIMONE BERTUZZI
Come avete sentito, a rafforzare questa dinamica contribuisce l’uso di due voci, entrambe generate tramite intelligenza artificiale. La voce maschile è modellata su quella di Silvan, mago iconico dello spettacolo italiano, mentre la voce femminile è quella di Val Plumwood, citata nell’introduzione da Valentina. Questi due elementi, svelati solo nei titoli di coda, che aleggiano aggiungono ulteriori presenze, fantasmi al film.
MICHELA DE MATTEI
Anche in questo caso abbiamo riflettuto sulla scelta della persona narrativa nel testo: quale genere utilizzare? Il maschile, il femminile? Alla fine, ci siamo accordati sulla dimensione del branco, sottolineando la pluralità.
Spesso, quando si parla di lupi, si sente menzionare il maschio alfa, un’espressione che personalmente trovo irritante, perché tende a escludere la figura della femmina alfa, che invece gioca un ruolo altrettanto centrale nella struttura del branco. Elena, forse è importante descrivere l’organizzazione sociale dei lupi.
ELENA BASSI
Nel branco, le dinamiche sono molto più paritarie rispetto a quello che si tende a immaginare. Non si tratta di relazioni verticali, ma piuttosto di rapporti orizzontali e trasversali. Ad esempio, se un anno una coppia si riproduce e ha dei cuccioli, l’anno successivo saranno proprio quei giovani a contribuire allo svezzamento e alla crescita dei nuovi nati. Inizialmente, la femmina resta nella tana per allattare, ma una volta terminato questo periodo, torna a svolgere tutte le attività del gruppo.
Si tratta, a tutti gli effetti, di una struttura familiare basata sulla collaborazione: ogni individuo ha un ruolo e partecipa attivamente alla sopravvivenza del branco. Esistono due figure chiave, quelle dei genitori, unici a riprodursi, ma il sistema non si basa su una rigida gerarchia verticale, né tantomeno su una distinzione di genere. È un sistema collaborativo
Questa molteplicità di livelli e prospettive che avete cercato di rappresentare, si percepisce. Spesso due persone che assistono alla stessa scena la descrivono in modi completamente diversi: per una, i lupi sono quattro e bianchi, per l’altra sono neri. La percezione è talmente soggettiva che diventa difficile ricostruire i fatti con esattezza.
Molte volte, mi è capitato di raccogliere testimonianze di chi era certo di aver visto due lupi in una determinata area, per poi scoprire, grazie alle videocamere, che in realtà erano otto. Al contrario, chi parlava di dieci presenze si sbagliava: erano solo tre. L’utilizzo delle telecamere ha permesso di chiarire molti di questi “misteri”, ma prima che fossero disponibili, l’unica fonte d’informazione erano le testimonianze, che spesso risultavano discordanti tra loro.
Anche le reazioni alla presenza del lupo variano molto a seconda del contesto. In Toscana, dove il lupo non è mai scomparso, i pastori si arrabbiano in caso di attacchi, ma sanno come gestire. Sulle Alpi, invece, la sua ricomparsa è stata accolta con panico e arrabbiatura, perché la convivenza con il lupo è un fenomeno nuovo e manca l’esperienza necessaria per gestirlo.
Ora, la presenza del lupo si sta estendendo anche agli ambienti urbani, e questo ha generato un’ondata di paura e disorientamento. La domanda più frequente è “Cosa devo fare se incontro un lupo?” L’assenza di risposte chiare contribuisce ad alimentare il panico.
MICHELA DE MATTEI
Sì, c’è poca informazione probabilmente, infatti voi fate anche tanta sensibilizzazione.
ELENA BASSI
Esattamente, ed è proprio come dicevi: il lupo è una figura polarizzante, quindi bisogna fare attenzione a come se ne parla, soprattutto in un centro abitato, dove non tutti sono consapevoli della sua presenza. Dichiarare apertamente “Qui c’è il lupo” può generare reazioni molto diverse: chi non ne era a conoscenza potrebbe andare nel panico, mentre chi già lo sapeva potrebbe reagire con rabbia e frustrazione.
Per questo è fondamentale avvicinarsi al tema con delicatezza, ascoltare prima di parlare e percepire qual è l’emozione dominante. Solo così è possibile scegliere le parole giuste e orientare il discorso nella direzione più adeguata. È un processo complesso, ma una cosa è certa: la paura è sempre un elemento permeante.
SIMONE BERTUZZI
Elena, ti va di raccontarci della pratica che state portando avanti recentemente, che riguarda l’avvicinamento dei lupi agli spazi urbani e il fenomeno dell’ibridazione con i cani domestici? In particolare, vorrei sapere di più sull’attività che state svolgendo per arginare questa situazione.
ELENA BASSI
Il lupo è una specie protetta in Italia. La nostra è una sottospecie unica, che si è sviluppata grazie alla particolare geografia del nostro paese: le Alpi a nord e la natura di penisola hanno isolato i lupi, impedendo loro di spostarsi facilmente. Questo isolamento ha portato alla formazione di una popolazione genetica distintiva, che non si ritrova in altre parti d’Europa. Per questo motivo, la conservazione del lupo è così importante, visto che in altre nazioni, come la Spagna o la Svizzera, i lupi sono di una specie diversa dal punto di vista genetico.
Tuttavia, avvicinandosi ai centri abitati e a causa di una gestione inadeguata dei cani, in particolare dei cani da guardiania del bestiame o dei cani randagi, si è verificato un fenomeno problematico: l’ibridazione tra lupi e cani. Questo accade tipicamente quando una femmina di lupo si accoppia con un maschio di cane. I cuccioli che nascono da questa unione vengono allevati da lupi e crescono in natura, ma geneticamente sono ibridi tra un lupo e un cane.
Questa ibridazione comporta implicazioni sia genetiche che ecologiche. Da un punto di vista genetico, l’inquinamento del genoma del lupo italiano è una preoccupazione, mentre sul piano ecologico potrebbe esserci un impatto sul comportamento degli animali. I cuccioli ibridi, sebbene cresciuti in natura, potrebbero comportarsi come lupi, ma con tratti comportamentali e fisici derivanti dai geni del cane, come ad esempio colorazioni insolite come il pelo nero o morfologie differenti, come orecchie abbassate o code diverse. Tuttavia, non esistono ancora studi completi sugli effetti a lungo termine di questa introgressione genetica nel comportamento del lupo.
Per cercare di contenere questo fenomeno, è fondamentale una corretta gestione dei cani e, parallelamente, interventi specifici sulla popolazione di lupi. Nell’ambito del progetto LIFE, sono state avviate delle catture mirate a sterilizzare gli animali ibridi, in modo da evitare la disgregazione del branco e impedire che gli ibridi possano riprodursi. L’obiettivo è mantenere il gruppo coeso, evitando che gli animali non più parte del branco diventino solitari e imprevedibili.
Purtroppo, le catture effettuate in una zona sopra Gubbio, dove si trovava un grosso branco, non hanno portato a risultati positivi. Sebbene siano stati catturati tre femmine di lupi puri, non sono stati trovati ibridi. Potrebbe essere che i geni dei cani rendano questi animali più elusivi, più difficili da catturare, forse anche più abituati alla presenza umana e quindi più difficili da intercettare.
Negli ultimi anni, diversi progetti si sono concentrati proprio sulla gestione degli ibridi, ma ci sono ancora molte difficoltà legate alla legislazione. Infatti, non è ancora chiaro come trattare legalmente un ibrido: non si sa se applicare la normativa sul lupo o quella sul cane, il che crea alcune incertezze.
MICHELA DE MATTEI
Mi ha fatto molta impressione quello che hai raccontato. Da una parte c’è l’esigenza di preservare la purezza del lupo, intervenendo con la sterilizzazione degli ibridi. Dall’altra, però, c’è il problema che l’uomo sta sempre più invadendo il suo territorio naturale, creando una sorta di conflitto tra la conservazione della specie e l’espansione degli spazi urbani.
ELENA BASSI
Da un lato c’è la preoccupazione di preservare la purezza del lupo, ma dall’altro si potrebbe anche vederlo come un fenomeno naturale: non c’è mai stato un intervento umano per far accoppiare un cane con una lupa, né tanto meno quando si trattava di cani vaganti che semplicemente incontravano un lupo e si accoppiavano. Questi animali si sono incontrati e, essendo della stessa specie, hanno deciso di accoppiarsi.
Funziona così per tutta la montagna. È un po’ come accade per gli ungulati: prima li abbiamo reintrodotti per aumentarne il numero, poi, quando sono aumentati troppo, abbiamo iniziato a cacciarli per contenere la popolazione.
È sempre un errore umano, una sorta di negoziazione tra noi e la natura.
Il problema nasce proprio dalla nostra mancanza di lungimiranza: spesso non prevediamo le conseguenze delle nostre azioni, e quando gli ecosistemi non riescono a reggere, interveniamo cercando soluzioni che non sempre funzionano. Le città sono cresciute molto, soprattutto dopo lo spopolamento delle montagne nel corso degli anni Settanta in particolare, e questa espansione ha portato l’uomo a occupare sempre più spazi che una volta erano dei lupi e degli altri animali. In alcuni casi, però, questi animali sono spariti da secoli, quindi il ritorno dei lupi in certi luoghi è una novità.
A livello ecologico, è fondamentale mantenere un ecosistema sano, ricco: senza predatori naturali, come i lupi, gli ungulati distruggerebbero il bosco, mangiando tutte le gemme prodotta a terra. Tuttavia, il vero problema è che non tutti gli allevatori, in particolare quelli che gestiscono piccole realtà, riescono a gestire gli attacchi dei lupi, e spesso le istituzioni non offrono supporto adeguato. Anche se ci sono misure preventive, il vero ostacolo sono le difficoltà pratiche che gli allevatori affrontano da soli.
La coesistenza tra uomo e lupo non è a costo zero. Se vogliamo che i lupi non invadano i centri abitati, bisogna fare degli sforzi: spaventarli affinché capiscano che la città non è il loro ambiente, anche se questo potrebbe causare qualche trauma agli animali. In passato, i lupi che rischiavano di farsi vedere erano quelli più coraggiosi, e sono stati eliminati, restavano solo quelli più timidi. Ora che la popolazione è aumentata, i lupi più audaci stanno tornando, e bisogna far capire loro che non è sicuro avvicinarsi troppo agli spazi umani.
VALENTINA GERVASONI
In Paraflu, l’alternarsi tra riprese di fiction e situazioni in natura sembra sottolineare questo contrasto tra l’ambiente naturale, la montagna brumosa dei lupi, e l’invasione degli “spazi umani”, mettendo in evidenza come i confini tra natura e urbanizzazione diventino sempre più sfumati. Mi riferisco in particolare alle riprese in piscina.
SIMONE BERTUZZI
Abbiamo girato alcune scene con dei lupi cecoslovacchi; parlando con alcuni esperti c’è stato un po’ di ostruzionismo, perché ci sono segni evidenti del fatto che non si tratta di un vero lupo italiano. Però volevamo mantenere questo aspetto di finzione nel film. Le scene che citi sono state girate in una casa privata, in provincia di Bergamo, con una piscina e un’inaspettata antenna parabolica dotata di una serie di specchi. Questa ha creato i giochi di illusione che cercavamo, l’antenna in movimento è stata utilizzata per creare le luci sul paesaggio circostante, senza post-produzione. C’era anche un’altra scena che avremmo voluto girare come immagine finale, un impatto tra una jeep e un lupo, ma non ha funzionato, quindi l’abbiamo esclusa, lasciando solo un frammento. In quel caso, abbiamo usato l’intelligenza artificiale per evocarla e creando l’immagine finale con la neve, la jeep che se ne va e il sangue che cola.
SIMONE TRABUCCHI
Questa è stata girata con un cane lupo italiano, esito di un altro esperimento di ibridazione controllata pensata negli anni Sessanta per le forze dell’ordine, simile a quella del lupo cecoslovacco, di cui esistono pochi esemplari.
Poi c’è il “Centro Uomini e Lupi”, in provincia di Cuneo, ed è un luogo dove vengono soccorsi e recuperati lupi feriti in natura, spesso non più reintroducibili perché hanno trascorso troppo tempo a contatto con l’uomo. Ci hanno raccontato di un fenomeno interessante, il “lupo omega”: in natura, un lupo emarginato potrebbe andare in dispersione e in realtà emanciparsi, mentre in cattività diventa un reietto. Non può lasciare il branco, ma viene escluso e continuamente cerca un contatto ululando o osservando gli altri. È una condizione della cattività che ci ha colpito parecchio.
MICHELA DE MATTEI
E poi c’è un lupo vero. L’ultimo giorno di riprese, con l’ultima pellicola che avevamo – perché abbiamo girato tutto in 16 mm – è successa questa magia: una comparsa inaspettata. Abbiamo visto due lupi nella provincia di Piacenza, a Ponte dell’Olio, vicinissimi alle case in effetti. Sono scappati subito, ma siamo riusciti a filmarli in tempo. È stato un regalo.
VALENTINA GERVASONI
Simone [ndr: Trabucchi] suggerisce tre lupi perché ce n’è un terzo presente, in effetti, ma di altra specie. Vorrei ricollegarmi proprio alla presenza di Lupo, il bambino che beatamente dorme ninnato e forse, come un cucciolo, protetto dagli ululati, perché prima Elena parlava delle ibridazioni e del fatto che i lupi neri in natura non esistono. Il nero nel lupo non è una caratteristica originaria della specie. Eppure, nell’immaginario collettivo, nelle storie più cupe, il lupo è sempre il lupo nero, simbolo di paura, minaccia, oscurità. È interessante come questa narrazione si sia consolidata, mentre la realtà biologica racconta altro. Da qui nasce la possibilità – e forse il dovere – di costruire una contronarrazione, che ribalti stereotipi e apra nuove prospettive su questi animali e sul nostro rapporto con loro.
MICHELA DE MATTEI
Sì, assolutamente. Mentre lo dicevi, mi veniva in mente che persino nella ninna nanna che canto a mio figlio si parla del “lupo nero”. Questo dimostra quanto sia importante costruire una contronarrazione.
Il lupo è spesso il simbolo del male, del nemico. Questo ha radici profonde, legate anche alla costruzione della religione, che si fonda su un’idea di società pastorale: il pastore, il gregge, la pecorella smarrita. In questo schema, il lupo è sempre la minaccia, il pericolo che incombe. Lo stesso accade nelle fiabe per bambini, dove viene quasi sempre dipinto in una luce estremamente negativa.
Mi capita spesso di parlare con persone che hanno idee completamente distorte sul lupo, frutto di questa narrazione antica e consolidata. E penso che capiterà sempre più spesso.
ELENA BASSI
A questo proposito c’è un aneddoto interessante: in Groenlandia i lupi non ci sono, e non sono mai stati. In Norvegia, invece, i lupi esistono e stanno tornando, e i norvegesi storicamente li odiano. La cosa curiosa è che se vai in Groenlandia, i groenlandesi parlano del lupo nello stesso modo dei norvegesi, con lo stesso timore e disprezzo, pur non avendone mai visto uno.
Questo dimostra quanto l’immagine del lupo come figura negativa sia una costruzione culturale piuttosto che una realtà basata sull’esperienza diretta e indipendente dalla presenza effettiva dell’animale nel territorio.
MICHELA DE MATTEI
Anche quando si parla di branco in certi contesti, come negli attacchi di gruppo a sfondo sessuale, c’è sempre questa associazione con l’immagine del lupo. È un simbolo negativo radicato nell’immaginario collettivo.
Sto sviluppando un lavoro sulla tigre della Tasmania. Il lupo è stato un capro espiatorio anche per l’estinzione della tigre della Tasmania avvenuta nel 1936. Pur essendo un marsupiale, essa è stata assimilata al lupo dagli europei quando arrivati. Hanno iniziato a chiamarla il “lupo della Tasmania”, a rappresentarla nelle illustrazioni con tratti simili al lupo e ad associare a lei la stessa reputazione negativa. Questo ha portato a vere e proprie campagne di sterminio perché accusate di predare il bestiame. Di fatto, una narrazione culturale ha contribuito all’estinzione di questo animale.
ELENA BASSI
Invece nel contesto completamente diverso delle Vancouver Island, parlando con una ricercatrice che vive lì, scoprii che i nativi locali affrontano il problema del lupo in modo molto diverso. Lì, il lupo è visto come sacro, la reincarnazione degli antenati, quindi sparare a un lupo è completamente fuori discussione. Quando un lupo arriva in centro città, la comunità nativa si mobilita attivamente per proteggerlo. In questi casi, un elicottero viene inviato per catturare il lupo e riportarlo in natura senza fargli del male. Questo dimostra come le popolazioni native, che hanno una connessione spirituale e culturale con il lupo, siano parte integrante del processo decisionale e lo influenzino. Al contrario, le popolazioni europee, con una visione più utilitaristica e antagonista, non tollerano la presenza del lupo. È un contrasto culturale significativo, che riflette differenti percezioni e trattamenti degli animali.
VALENTINA GERVASONI
Elena, ci sono degli esempi di cooperazione all’interno dei branchi?
ELENA BASSI
A livello di tracciamento, le fototrappole hanno mostrato che, ad esempio, se un membro del branco ha difficoltà di deambulazione, come un lupo tripode, gli altri membri del gruppo non lo lasciano indietro. Gli animali più sani portano cibo all’animale che non può partecipare alla battuta di caccia, aiutandolo a sopravvivere, mostrando un comportamento molto solidale. In generale, tranne durante la stagione estiva, quando i cuccioli richiedono molta attenzione per crescere, il branco opera in modo molto cooperativo. Questo periodo dura solo 4 mesi, dopo di che la cooperazione riprende, e tutte le attività, come la caccia, il riposo e gli spostamenti, vengono fatte insieme.
In natura, a differenza della cattività, i branchi hanno dimensioni regolate da fattori sociali. Non esistono branchi troppo grandi, perché ogni individuo deve riuscire a mantenere relazioni con tutti gli altri membri del gruppo. Mediamente un branco non supera mai il numero di 8 individui per evitare difficoltà nelle interazioni sociali. Se il branco fosse troppo numeroso, questo diventerebbe difficile, e i membri non riuscirebbero a interagire adeguatamente tra loro. Inoltre, esiste un limite alla quantità di stress sociale che ogni individuo può sopportare, quindi c’è un equilibrio da mantenere. Quando il branco diventa troppo grande, raggiungendo dimensioni di 12-14 esemplari, i lupi possono dividersi in due sottogruppi per andare a caccia o svolgere altre attività, per poi riunirsi una volta completato il compito. Nei branchi più grandi, tipici del Nord America dove i territori sono più estesi e le prede sono più grandi, a volte possono verificarsi adozioni, per cui un lupo che era in dispersione viene accolto in un gruppo già formato. Tuttavia, questi eventi sono rari e non costituiscono la norma.
Q&A
Un lupo da solo può sopravvivere o a un certo punto deve per forza ricostruire un branco?
ELENA BASSI
In natura, la chiave di tutto è la riproduzione, cioè mandare avanti la propria linea genetica. Sebbene possa sopravvivere da solo, un lupo alla fine sente il desiderio di riprodursi. Quando un esemplare invecchia può vivere isolato, ma solo ai margini di qualche branco, poiché la vita solitaria comporta delle difficoltà, come la caccia. Anche se un lupo sa cacciare da solo, è un’attività che viene svolta meglio in gruppo, dove la cooperazione facilita la riuscita.
In alcuni casi, i lupi che si disperdono possono incontrare un altro lupo disperso e formare un nuovo branco. Questo è un meccanismo naturale che permette di evitare che esemplari della stessa famiglia si accoppino tra loro, cosa che sarebbe dannosa per la specie.
Q&A
Un territorio può essere condiviso anche da più branchi?
ELENA BASSI
Sì, solitamente adottano strategie di segregazione spaziale e temporale. Questo significa che, pur utilizzando lo stesso spazio, ciascun branco si muove in momenti diversi, evitando di incontrarsi. Entrambi i branchi sono consapevoli che l’altro frequenta quella zona, ma sanno anche che non si troveranno mai nello stesso posto nello stesso momento.