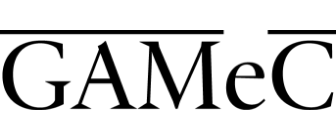IRENE GUANDALINI
Alessandra, nella Sua ricerca si è occupata a lungo della dimensione teatrale delle celebrazioni pubbliche. Parliamo di cerimonie civili e religiose che sono spesso espressione di un potere egemone, temporale o spirituale, che prevede da un lato un officiante e dall’altro un parterre di spettatori. Che funzione hanno tali riti e come agiscono sulla collettività?
ALESSANDRA MIGNATTI
Non dobbiamo confondere il tema più generale della festa con quello del rito. La festa, al cui interno possono svolgersi più riti, realizza una vera e propria sospensione della quotidianità, accende un tempo nuovo e una realtà a metà tra il reale e il sogno. Richiede tutta una serie di preparativi: si trasforma lo spazio stesso, ci si veste in modo diverso, si apprestano cibi e bevande, musiche e profumi. La festa, infatti, gioca su tanti codici espressivi e attiva tutta una serie di percezioni, agisce in modo sinestetico sui partecipanti per far leva sulle loro emozioni. Grazie a questa nuova realtà affiorano gli archetipi di una comunità, affiora il sacro, quell’insieme di elementi fondanti della stessa comunità. In questo modo la società ne esce rigenerata.
Nel corso dei secoli la festa è stata usata per rappresentare e affermare l’autorità, che in questo modo rinnovava i fondamenti essenziali del proprio essere, ma questo non vuol dire che il tempo della festa servisse necessariamente per esercitare un potere egemonico. Tutte le società hanno delle feste, le feste sono state necessarie dal momento in cui l’essere umano ha iniziato a vivere assieme agli altri e ha cercato di superare i momenti più difficili attraverso dei riti, ad esempio per superare la paura della morte o affrontare i conflitti. I momenti festivi servono per rinsaldare la comunità. Durante la festa si crea dunque uno spazio diverso e tutto diviene altamente simbolico. Sappiamo che il simbolo ha il potere di parlare direttamente al nostro inconscio e di agire profondamente nell’animo delle persone. Anche il linguaggio cambia, non si usa più solo il linguaggio quotidiano ma anche una serie di parole ed espressioni dall’alto valore significante.
Recentemente mi è capitato di vedere il video di un gioco realizzato da due fratellini durante il periodo di lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19 a Ponte Nossa, un paesino del bergamasco famoso per l’antica tradizione della Festa del Màs. Si tratta di un rito primaverile che celebra la fertilità e la rinascita della natura, che si articola in momenti diversi nell’arco di più di un mese: dapprima il “sacrificio” con la scure di un grosso abete, che viene poi trasportato a Ponte Nossa, dove viene accolto da un corteo festante e da tutte le autorità, con l’accompagnamento sonoro della banda; attraversato il paese, viene posto sul sagrato della chiesa parrocchiale e, dopo la Messa, viene benedetto e affidato nuovamente ai Soci del Màs, che lo dovranno preparare per il trasporto successivo. Il primo maggio l’albero viene trasportato a braccia e con l’aiuto di funi fino alla sommità del Monte Pés – una prova di forza cui la comunità non si sottrae, ma ne fa motivo di vanto. L’albero rimarrà sulla cima fino alla sera del primo giugno, quando viene tagliato e arso, attorniato dalla comunità festante. I due fratellini avevano nostalgia della festa in un momento così critico in cui le feste pubbliche non erano permesse: hanno pertanto ricreato la festa, con tutti i personaggi e le varie fasi, con i Lego. C’erano i due diversi momenti del trasporto del tronco, la benedizione del prete, il falò, la parte conviviale con il banchetto dove si mangia e si beve insieme – come si diceva prima, tutti i sensi vengono sollecitati in una festa, tutte le percezioni si attivano. Ho trovato il video straordinario, perché in un momento di forte difficoltà per la comunità, i due ragazzini hanno sentito il bisogno di fare comunità all’interno delle mura domestiche, hanno ripercorso i tratti essenziali e più significativi della festa con il gioco. Nel video anche le voci, la fatica della salita, la musica della banda. L’essere umano ha bisogno della festa, di quei magici momenti in cui riaffiorano gli archetipi e il sacro, momenti in cui la comunità si rinsalda.
IRENE GUANDALINI
Ancora oggi Dossena, il paese nella Val Brembana in cui si colloca l’intervento di Adele e Roberto, è particolarmente vivace in termini di feste, di tradizioni e di partecipazione collettiva alla vita pubblica. Questo patrimonio rischia tuttavia di scomparire a causa dello spopolamento cui è soggetto il paese. Com’è stato il vostro approccio con Dossena e in che modo vi siete interfacciate con la storia, in primis culturale, del paese?
ROBERTO CASTI
Con Adele abbiamo trascorso un mese di residenza a Dossena e fin da subito sono affiorati due aspetti a cui il paese è profondamente legato: la festa, in particolare le mascherate, e la presenza della miniera. Ci siamo interessati soprattutto al rapporto della comunità con il suo passato minerario e a come veniva percepito il tema del lavoro in rapporto ad esso, ragionando sulla connessione con l’ambiente montano circostante e chiedendoci se oggi il legame con la miniera possa trasformarsi in una relazione ecologica. Per quanto riguarda invece le mascherate, si tratta di un tema che i dossenesi sentono tuttora con grande orgoglio, essendo parte vivente di un patrimonio culturale che ha segnato profondamente la memoria collettiva. Nonostante oggi non vengano più organizzate, le mascherate rimangono comunque radicate nel ricordo e nella vita delle persone.
ADELE DIPASQUALE
Il giorno in cui siamo arrivati a Dossena siamo stati accolti da una festa, una sagra in una contrada sotto il paese dove si stava insieme, si mangiava, si cantavano e suonavano delle canzoni popolari che tutte le persone lì presenti conoscevano. Questo è stato il primo impatto, abbiamo conosciuto alcune persone che suonavano la fisarmonica e che poi attraverso le nostre interviste abbiamo scoperto essere anche parte del gruppo di ex-minatori. Per noi inoltre è stato molto interessante incontrare generazioni diverse, da quella molto giovane dell’amministrazione pubblica a quella più anziana. Quest’ultima ha un rapporto differente con il lavoro – spesso ha sviluppato un legame traumatico con la miniera – ma è anche depositaria di una memoria contadina legata a un’economia di sussistenza, in un rapporto con la geografia del territorio (e ancora una volta, con il lavoro) che è cambiato moltissimo negli ultimi anni. Vedendo come nello stesso territorio ci siano temporalità diverse che convergono, ci siamo chieste non solo quale sia il rapporto di questo paese con il suo passato ma anche come si prospetta il suo futuro in un’economia globale neocapitalista, dove una serie di dinamiche legate alla ritualità, alla comunità e al modo di concepire il lavoro stanno avendo una mutazione velocissima. A Dossena questi piani si sovrappongono e ci si interroga ad esempio sul senso di portare avanti la tradizione delle mascherate. Alcuni abitanti ci hanno raccontato del conflitto che c’è stato in passato tra le persone che performavano le maschere, con un’ala per così dire più conservatrice che voleva mantenere la tradizione intatta e le dinamiche come sono sempre state, e un’altra frangia che voleva far diventare la mascherata qualcosa di diverso, ritenendo che questa trasformazione non avrebbe stravolto il contenuto vero della mascherata.
IRENE GUANDALINI
In effetti la Val Seriana e in generale l’area delle Alpi Orobiche è un terreno di osservazione particolarmente interessante per vedere come un modo di guardare o di sentire per così dire archetipico si siano radicati nel tessuto storico e sociale ed evolvano nel tempo.
Alessandra ha a lungo studiato da una prospettiva storica il territorio bergamasco, cercando di capire meglio il suo essere considerato un territorio liminale, che rappresentava il selvaggio e l’incolto. Nel Cinquecento Bergamo con i suoi boschi veniva contrapposta a una delle città per eccellenza, ovvero Venezia, che rappresentava invece la civiltà ordinata e razionale. Si tratta di una dicotomia che ha a lungo informato l’idea occidentale di natura, dove ciò che è sconosciuto e che non è direttamente sotto il controllo umano affascina, ma al contempo spaventa.
Inoltre è interessante vedere come nel tempo i bergamaschi siano stati protagonisti di un esodo costretto dalla povertà, dalla fame e dall’indigenza verso territori più ricchi come Genova o la già menzionata Venezia, dove svolgevano anche compiti ingrati, talvolta facendo lavori più umili come i facchini, talvolta legati a tabù come quello della morte e lavorando come becchini. è impressionante vedere come alcune dinamiche migratorie siano incredibilmente simili a quelle attuali globali – senza spostarci troppo in là basti considerare ad esempio il Mediterraneo.
Ci può dire di più sia sull’origine di Bergamo come soglia tra il colto e l’incolto, sia sulla reputazione dei bergamaschi come migranti, individuando l’eredità culturale ancora presente oggi?
ALESSANDRA MIGNATTI
Bergamo annovera nella sua storia illustri architetti, capitani di ventura, soldati, musicisti, ma nonostante i nomi illustri la fama della città è legata a qualcosa di “diverso”, alla maschera. In particolare, alla maschera del servo. In passato mi sono occupata di questa alterità di Bergamo attraverso la figura dello Zanni, una maschera che approda alla commedia dell’arte, che in realtà prende vari nomi e cambia d’abito – diventando Arlecchino, Brighella, Scarpino o Truffaldino – a seconda di chi lo impersona e del luogo in cui viene agito.
Nella commedia dell’arte, che ebbe una grandissima diffusione ed era nota almeno in tutta Europa, Zanni parla bergamasco; tuttavia, non mi sento di dire che sia una maschera bergamasca, dal momento che ritroviamo il suo nome in tante regioni d’ Italia e d’Europa. Qualcuno dice che il suo nome derivi dai Sanniones, i mimi della commedia dell’antica Roma. Più verosimilmente viene dal nome Giovanni. Le due cose possono benissimo non collidere e una può essere la prosecuzione dell’altra – d’altronde sappiamo come le culture si mescolino e si trasformino. Troviamo il termine Hans, Jan o nomi simili in tutta Europa con accezioni molto simili a quella del nostro Zanni, cioè una figura che rappresenta il folle, lo sporco, il letame, il pazzo, ma anche addirittura la Morte; inoltre ritroviamo Zanni e le sue varianti in una serie di nomignoli di animali, parassiti delle piante e della frutta, ma può diventare il nome di un vento, e così via. Il discorso è molto lungo e complesso, mi scuso se le mie risposte risulteranno frammentarie e incomplete.
Secondo i Grimm, che nell’Ottocento andavano a ricercare nel Medioevo le origini della nostra cultura, il nome Giovanni ha la sua fortuna proprio intorno all’anno Mille, nel momento in cui si pensa siano state ritrovate le spoglie di san Giovanni Battista. I Vangeli ci raccontano che il figlio di Elisabetta riconosce Gesù quando è ancora in grembo, ragion per cui la nascita del santo viene celebrata sei mesi prima della nascita di Gesù: il Salvatore nasce nel solstizio d’inverno, san Giovanni invece nel solstizio d’estate. Il solstizio d’inverno è un momento calendariale molto importante per quelle società che sono legate alla fertilità della terra e degli animali. Con il solstizio d’inverno le ore di luce cominciano gradatamente ad aumentare, per questo è stato celebrato in epoca precristiana come la nascita del sole. In effetti metaforicamente Gesù è colui che ci porta la luce, la luce che vince le tenebre della morte. San Giovanni invece è celebrato nel solstizio d’estate, quando le ore di luce cominciano a calare. È il momento in cui il lavoro dei campi è al massimo, ma poi pian piano andrà scemando, fa buio sempre prima e ci si prepara al momento dell’ombra, dell’oscurità, che il santo deve tenere a bada. Inoltre, san Giovanni Battista è conosciuto non solo per la sua attività di battezzatore, ma anche per la sua permanenza nel deserto, dove si copre di pelli e si ciba di miele e locuste, proprio come un Homo Selvaticus. Il deserto rappresenta nella Bibbia il luogo della tentazione che può portare alla perdizione, dove ci si ritrova soli, ma anche dove si manifesta il meraviglioso. Nel nostro panorama geografico europeo tuttavia non ci sono deserti, quindi il suo corrispettivo è la foresta, il bosco: nel bosco si manifesta il meraviglioso, c’è il pericolo, la tentazione, il lupo famelico che incontra Cappuccetto Rosso, ma c’è anche il cacciatore che può uccidere il lupo, così come i sette nani, e così via. Il bosco è quel luogo di solitudine in cui l’eroe della fiaba rischia di perdersi o di morire, ma in cui può incontrare gli aiutanti magici e ricevere quegli aiuti che riescono a farlo trionfare e che, interpretando le fiabe in termini psicologici, consentono all’eroe di completare il proprio processo di individuazione.
Quindi cosa vuol dire quindi avere una maschera che si chiama così e che rappresenta l’altra parte, la parte oscura, l’ombra? Jung assimilava queste maschere all’archetipo del Briccone divino dei nativi del Nord America e diceva che erano proprio immagini dell’Ombra, cioè di quella parte del nostro inconscio che a volte fa degli scherzi e che rappresenta quel primo passo che ogni individuo deve compiere per raggiungere la propria individuazione.
Bergamo e soprattutto le sue valli hanno rappresentato questo. Sull’operosità, l’ingegno, il coraggio militare, la capacità imprenditoriale di tanti bergamaschi che sono emigrati per lavoro prevale quella del rozzo montanaro che dalle valli boscose di Bergamo emigra per fare lavori umili, come il facchino. Tracce di questo esodo dalle valli si hanno fin dal Medioevo, uomini spinti dalla fame che, riuniti in Confraternite, si spingevano fino a Genova, Pisa, Livorno, Roma, ma anche in Germania, Spagna e Francia, a Venezia e a Genova, dove ottenevano privilegi particolari per il loro lavoro. Ogni Confraternita aveva uno statuto speciale, la cosiddetta mariegola: non era quindi una semplice accozzaglia di gente senza arte né parte. I bergamaschi migranti che si presentavano a Venezia, a Genova, a Bologna, a Ferrara o a Roma erano portatori di una cultura del bosco, cioè del deserto non biblico, ma di quello europeo. Facevano feste, danze, ma la loro rozzezza richiamava ancor di più il selvatico, il non quotidiano. Famosa era anche la danza Bergamasca, di cui anche Shakespeare parla, che originariamente consisteva in una danza saltellata. Le danze saltellate sono tipiche di alcune feste, penso ad esempio alla taranta, che portano ad andare fuori di sé, a sospendere temporaneamente la propria identità, il proprio essere, per farsi tutt’uno con gli altri. Pensiamo a quanto sia importante in una dinamica collettiva. Il tema del saltellato ci riporta sempre al concetto di liminalità. Nel suo libro Storia notturna, Carlo Ginzburg descrive alcuni esseri presenti nei miti o nelle fiabe che, poiché hanno visitato il mondo dei morti, hanno lasciato nell’aldilà un osso e quindi ora zoppicano. Sono esseri che sono sul limite tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti e il loro incedere saltellante, non quotidiano, non normale è il segno del viaggio che hanno fatto.
Bergamo rappresenta quindi il mondo non costruito in contrapposizione alla città, un deserto da frequentare per rigenerarsi, ma rappresenta anche la possibilità di entrare in contatto con il meraviglioso. I facchini bergamaschi venivano descritti come persone rozze, dall’aspetto scimmiesco, incapaci di parlare adeguatamente, con poco cervello, però dei gran lavoratori. Tommaso Garzoni scrive che i bergamaschi hanno aspetto e virtù più che asinesche. Siamo abituati a pensare che l’asino sia sinonimo di ignoranza, ma l’asino è famoso innanzitutto per le sue virtù sessuali – e lì si allude anche ai facchini bergamaschi – ma ha anche virtù profetiche. A Dossena la maschera dell’asino era quella che interveniva per rivelare profezie, svelare quello che sarebbe successo. D’altronde indossare una maschera vuol dire questo, rinunciare al tempo quotidiano, rinunciare ad un’identità per aprirsi all’ignoto, per compiere un viaggio.
ADELE DIPASQUALE
Sì, in effetti durante la nostra residenza abbiamo avuto l’occasione di vedere la maschera dell’asino e il suo costume e ci è parso molto bello. In generale, non è facile però capire con che lente guardare alle tradizioni del passato, considerando che il contesto a livello globale è molto cambiato: le comunità si stanno disgregando, le istituzioni familiari si stanno sfaldando, il lavoro si è trasformato radicalmente. Ci siamo interrogate sul ruolo che può rivestire oggi una simile festa.
Riporto un esempio che ci hanno raccontato e che trovo esemplificativo. Un anno, durante una mascherata, era stato reinscenato un caso di stupro che era avvenuto in paese, facendo così della satira nei confronti di una figura clericale che era stata accusata di quello stupro. Ci è sembrato un potente strumento di democrazia diretta, ma anche di un modo di fare politica che esce dall’istituzione statale o dai meccanismi standard dell’esercizio della democrazia. In generale ci è parso che la questione di genere fosse un tema caldo nel paese, dove c’è un conflitto vivace tra la parte di popolazione maschile più anziana e quella più giovane. Abbiamo imparato, ad esempio, che le mascherate erano esclusivamente maschili, cioè che tutti i ruoli venivano impersonificati solo dagli uomini, anche i ruoli femminili. Mi sembra una questione interessante da porre, perché anche se parliamo della festa come momento di alterazione e inversione dei ruoli, sappiamo bene come questa si svolga comunque all’interno delle strutture patriarcali che prevedevano la possibilità di vivere questa ebbrezza solamente per una fascia della popolazione maschile. Nel nostro progetto proviamo a includere questo tipo di lettura della mascherata all’interno di un sistema di potere e di ruoli di genere ben più ampio e complesso, un sistema che in questo periodo storico sta cambiando drasticamente a livello globale.
Un altro aspetto che ci ha interessato riguarda i luoghi in cui avvenivano le mascherate e come questi siano cambiati nel tempo. Inizialmente, infatti, le mascherate avvenivano in tutte le contrade, ci si spostava da una strada all’altra e questa era l’occasione per incontrarsi anche con le persone di altre contrade. Successivamente le mascherate si sono spostate sulla piazza del paese di fronte alla chiesa, quindi davanti a una delle istituzioni più importanti del paese.
ROBERTO CASTI
Aggiungo anche un altro punto su cui ci siamo a lungo interrogati. La festa, in questo caso il carnevale, è un momento di sospensione in cui si lascia spazio alla satira, alla critica del potere e del governo. Si mette in discussione un ordine, si sovvertono le regole, durante la festa si può parlare male del padrone. La festa rappresenta un momento di riappropriazione dello spazio pubblico. Mi chiedo se oggi esistano ancora delle feste che abbiano questo potere di sovversione, di messa in discussione del sistema egemone, di critica e al contempo di azione collettiva di ripresa dello spazio pubblico.
ALESSANDRA MIGNATTI
Avete posto delle questioni enormi. Tuttavia, ho dei dubbi sul carnevale come momento di critica sociale – e in generale delle feste come momento in cui si possa esprimere una radicale critica sociale. Nel caso dello stupro di cui ha parlato Adele, il fatto di rappresentarlo, cioè di “renderlo presente di nuovo” attraverso la finzione, implica il poterlo governare. Pensiamo al bambino quando gioca a fare la mamma o il papà, il maestro o la maestra, cioè quando cerca di impersonare le figure che gli possono dire dei no, che possono sgridarlo. Nel momento in cui rappresenta tali figure, le fa sue, le governa e non ne ha più paura. Per rendere più esplicito questo esempio, si cita sempre il saggio di Freud sul piccolo Hans. Quando la mamma usciva, Hans giocava con un rocchetto di filo allontanandolo e ritirandolo a sé, a simboleggiare la madre che usciva e che lui poteva far tornare a sé, per poter così governare questo fatto e sconfiggere la paura. Nel gioco infantile ritroviamo perfettamente i meccanismi della rappresentazione. Rappresentare qualcosa di negativo che una comunità ha vissuto serve a renderlo presente per accettare che sia accaduta, e quindi per superarla. Questi sistemi, come il carnevale, rappresentano la crisi e contengono in sé i meccanismi per superare la crisi stessa.
Il carnevale fa parte di quelle feste in cui è lecito insanire, eccedere, andare oltre i limiti. Serve portare il caos perché solo dal caos possono nascere le cose nuove, possono rendersi palesi le divinità, gli spiriti. Rimanendo ancorati al lavoro nei campi, è solo quando si rivolta la terra, che poi si può riseminare. La festa, il carnevale sono sempre caratterizzati da un eccesso, che sia eccesso alimentare, eccesso nei movimenti, eccesso di luci, eccesso di volgarità … è sempre qualcosa oltre. Quindi sì, è vero che il carnevale stravolge gli ordini stabiliti e il potere – c’era il vescovo da burla, il re da burla – ma poi il sistema politico o religioso tornava ad essere tale e quale.
Per quanto riguarda Dossena, è vero che il carnevale nel tempo ha perso largamente la sua dimensione itinerante. Prima, come diceva Adele, si faceva di contrada in contrada, poi davanti alla chiesa (ma si noti che quando il teatro è uscito dalle chiese, si è spostato sul sagrato, prima di rinchiudersi nei teatri). Originariamente nei carnevali di tradizione lo Zanni andava di qua e di là per le case a rubacchiare, che era un modo per portare il caos nel paese, per poi risacralizzarlo. In questo senso non credo che nel carnevale ci sia una forma di democrazia diretta. Il carnevale serve a superare un fatto, non a sovvertirlo. Si inverte l’ordine affinché tutto torni come prima. L’essere umano ha bisogno di questi momenti per avere un equilibrio, per non impazzire, per non fare la rivoluzione vera, magari in maniera disorganizzata.
Il Carnevale fa parte dei riti del Capodanno, quindi quando deve rinascere il nuovo mondo. E per rinascere c’è bisogno del caos. Le maschere portano il caos, perché cancellano l’identità e rimandano sempre a qualcosa di diverso, non quotidiano, a qualcosa che è nell’ombra. Spesso d’altronde sono connesse a esseri che vengono dal sottosuolo e che prendono nomi di animali o di spiriti.
Nella nostra cultura, inoltre, i morti riposano laddove si mettono i semi, laddove viene la fertilità e il benessere della società. Essendo la nostra una società che ha radici contadine, c’è un forte legame tra il mondo dei morti e la fertilità, che le maschere in qualche modo evocano. Il Carnevale e le maschere si fondano d’altro canto sull’idea che, rispetto al calendario astrale, finito il lavoro nei campi e nel momento in cui anche gli animali vanno in letargo, non si può più fare nulla materialmente e bisogna allora propiziare il nuovo raccolto attraverso forme di preghiera e di riti specifici.
Nelle nostre tradizioni ancora adesso è forte il culto dei morti: in Sicilia sono i morti che portano i regali ai bambini, a Bergamo è Santa Lucia, mentre in Sardegna c’è la tradizione delle “animeddas”, un’antica tradizione per commemorare i defunti, simile a Halloween, in cui si lasciano tavole imbandite per i defunti, mentre i bambini si travestono da “animeddas” e vanno di porta in porta per raccogliere doni. I bambini sono quanto di più vicino al mondo degli spiriti, al mondo dei morti.
A questo si aggiunge poi il discorso della sessualità, che è strettamente connessa ai morti, e ancora una volta alla fertilità dei campi. La fertilità dell’uomo era legata alla fertilità dei campi: in una civiltà contadina avere molti figli voleva infatti dire avere più braccia che coltivavano la terra. In questo senso ritroviamo una serie di attributi sessuali tipicamente maschili anche in Zanni, che ne ha molti tra quelli che mette in mostra e quelli che racconta. Le maschere come quella degli Zanni d’altronde sono legate a componimenti come i mariazzi, realizzati in occasione delle nozze, o come gli charivari o le scampanate, legate invece ai coscritti, ovvero alla popolazione maschile che deve diventare adulta. Le scampanate oggi sono rimaste in uso durante un matrimonio e consiste nel chiasso, nel caos o negli scherzi che si fanno ai giovani agli sposi la sera prima o il giorno del matrimonio. Ma le scampanate nascono come forma di controllo sociale, quando cioè si sanzionava un matrimonio tra una persona più anziana e una più giovane, con ricadute dirette sulla fertilità del gruppo. È noto, infatti, che due giovani possono fare più figli rispetto a un anziano, che indubbiamente vede diminuita la sua capacità sessuale, con una ricaduta sul benessere dell’intera comunità. Analogamente la scampanata condannava anche quei casi in cui un ragazzo o una ragazza venivano portati via da un compagno o una compagna di un altro paese. Ci sono tante rappresentazioni anche iconografiche di Zanni che segue Pantalone, cioè un vecchio ricco, che cerca di circuire e sposare qualche giovane fanciulla. Pantalone viene rappresentato su un asino che deve cavalcare proprio al rovescio, in un’inversione totale. E cosa fa Zanni? Insuffla nel posteriore dell’animale dell’aria con un mantice, cosicché poi l’animale generi del rumore e Pantalone venga irriso. Nei canovacci, cioè nelle strutture fisse della commedia dell’arte, quando si devono scongiurare matrimoni tra giovani e vecchi, i servi fanno un gran caos, creano confusione con la loro stoltezza, affinché alla fine i vecchi non possano sposare le giovani fanciulle. Così le famiglie possono continuare a crescere, la vegetazione può continuare a fiorire e gli animali che possono continuare a generare. Va rilevato, inoltre, che gli zanni della commedia sono fannulloni, si muovono tanto ma combinano poco. Altro che bergamaschi gran lavoratori, altro che sacrificio! Vogliono solo riempire la pancia e fare l’amore. Solitamente i servi sono due: uno dei due si dà più da fare, ma come dice Nicoll “è difficile dire chi dei due sia il meno stupido e chi il più scaltro”.
ADELE DIPASQUALE
Torno sull’idea dell’ebbrezza connessa alla festa, con l’alterazione e l’eccesso che sono aspetti che trovo molto interessanti. A tal proposito vorrei riportare il caso di uno dei primi attriti che c’è stato tra noi e la popolazione di Dossena. In un’occasione di scambio, stavamo parlavamo degli Alpini con una persona del paese che aveva un rapporto di fiducia con questo corpo militare. Questa persona è rimasta molto colpita dal racconto di una mia esperienza risalente a quando avevo 16 anni a Torino, città dove vivevo e dove quell’anno si svolgeva il periodico raduno nazionale degli Alpini. Per la prima volta ho visto la mia città cambiare, in quei giorni le regole erano ribaltate, una fetta della popolazione maschile poteva arrivare in città e disporre di spazi e persone a suo piacimento, sia verbalmente sia fisicamente. E questa cosa era tollerata dalle autorità locali, che invece erano assai più restrittive con altri tipi di feste. Per me questo è un caso piuttosto esemplificativo di cosa possono essere le feste oggi e di cosa significhi avere a disposizione dei momenti di caos e di ribaltamento.
VALENTINA GERVASONI
L’esempio che riporti mostra anche come le celebrazioni collettive possano diventare espressioni di appartenenza identitaria a un determinato gruppo con cui condividi un preciso sistema di codici e di valori. Rispetto ai temi fin qui trattati, ci raccontate in cosa consistono i vostri progetti per Dossena e quali figure e maschere avete incluso?
ADELE DIPASQUALE
Il nostro lavoro a Dossena prevede una prima parte laboratoriale in cui scriveremo un canto con diverse fasce della popolazione e che parlerà del loro rapporto con il passato, il presente e il futuro del luogo. Il canto viene in un secondo momento fruito dalla popolazione attraverso un’installazione all’interno del paese realizzata tramite un processo partecipativo a partire dal materiale di scarto della produzione mineraria, ferma ormai da moltissimi anni. In seguito un performer reinterpreta questo canto indossando varie maschere (l’Arlecchino, l’Homo salvadego, la Vecchia, l’Asino, la Morte) e riorganizzando le strofe di modo che l’ordine temporale venga scardinato, al fine di creare una narrazione non lineare del luogo. Il video viene girato all’interno delle miniere, luogo simbolo dell’ombra e dove l’oscurità non è solo un fattore fisico ma anche metaforico, in un rimando al passato più complesso e talvolta drammatico di Dossena. In questo senso mi sembra interessantissimo quello che ha detto Alessandra e che finora non avevamo ancora messo a fuoco in maniera così puntuale sulla maschera come figura dell’ombra, del loro rapporto tra il mondo dei morti e il mondo dei vivi e dei bambini come figure liminali tra quello che c’era prima e quello che poi verrà.
IRENE GUANDALINI
Avete nominato tra gli aspetti che più vi hanno colpito la presenza della miniera. La miniera è tutt’oggi un luogo centrale nella vita di Dossena, depositario di una complessa eredità ancora molto vivace. Ha dato lavoro a intere generazioni di lavoratori e lavoratrici, permettendo di riuscire a vivere (o sopravvivere) alle condizioni indigenti cui sarebbero altrimenti stati condannati. Il lavoro in miniera era però un lavoro fisico massacrante, che ha portato a morti, infortuni e malattie respiratorie fatali. Nonostante lo sfruttamento ambientale e fisico dei corpi messi a lavoro, si è comunque andata a creare e legittimare una narrazione che ruota attorno al concetto di sacrificio necessario e in qualche modo nobilitante, pur appunto risultando distruttivo. Durante la vostra residenza e nelle vostre ricerche, che tipo di relazione avete ritrovato oggi tra gli abitanti del paese e la miniera? Pensando anche alla tradizione dei canti dei minatori di Dossena, espressione canora di un determinato sistema-mondo, ritenete che l’ascolto possa essere una forma di pensiero collettivo?
ROBERTO CASTI
Fin dai primi approcci, come raccontava Adele riguardo alla sagra, abbiamo capito che c’è una forte cultura legata alla musica e che il suono è parte del DNA della comunità: troviamo infatti l’utilizzo di diversi strumenti musicali popolari (come la fisarmonica o la chitarra) e orchestrali, ma anche un importante uso del canto, che è infatti il linguaggio su cui abbiamo deciso di concentrarci maggiormente. Durante la fase di ricerca abbiamo avuto la fortuna di ascoltare diversi canti dal vivo— spesso incentrati sul lavoro in miniera —, alcuni dei quali eseguiti da parenti o amici di ex-minatori morti a causa di malattie respiratorie. In queste occasioni, il canto ha avuto la forza di riportare alla luce alcuni traumi del passato e ascoltare dal vivo le voci di chi si porta dietro questa memoria è stato incredibile. Per questo il canto è stato il linguaggio che abbiamo da subito individuato come quello più adatto.
La nostra idea è quella di pensare a un canto nuovo, perché vogliamo che dall’opera esca una dimensione temporale, legata sì al passato ma anche al presente e al futuro. Vorremmo che da questo brano emerga sia la storia degli abitanti, anche con i loro traumi; sia l’eredità che tale passato esercita sul presente, su che cosa significa oggi vivere a Dossena; sia il futuro che si affaccia con le sfide che il paese dovrà affrontare, dalle problematiche legate allo spopolamento, ai problemi ambientali o alle trasformazioni del lavoro. Vorremmo quindi creare una narrazione intergenerazionale attraverso un canto frammentato, costituito dalle voci dei bambini, del coro parrocchiale e degli ex-minatori del paese. Un racconto che supera i confini temporali e che parla della comunità.
Una volta registrato il canto, questo verrà installato nello spazio pubblico. Come diceva prima Adele, il luogo d’incontro che fungerà da area di ascolto del brano — costituito da alcune panchine e da un orto comunitario — sarà realizzato con i materiali di scarto delle miniere, ovvero le pietre che con il tempo sono state estratte e gettate via perché prive di valore economico. Le persone potranno incontrarsi, utilizzare le piante dell’orto, guardare il paesaggio e attendere che il canto venga riprodotto. Quest’ultimo, infatti, scandirà l’arco della giornata: una strofa verrà riprodotta all’alba, un’altra a mezzogiorno e l’ultima al tramonto, quando i lampioni si accenderanno.
Gli scarti delle miniere sono per noi importanti per parlare inoltre del rapporto con il lavoro e della retorica del sacrificio ad esso connessa. I materiali riciclati sono frutto di un sacrificio passato ma non sono mai entrati in un processo economico. Al contrario sono stati gettati attorno alla miniera, stratificandosi e creando così un nuovo paesaggio naturale. Vorremmo quindi utilizzare queste pietre che, nonostante non abbiano valore per la macchina estrattivista umana, rimangono sicuramente dei simboli importanti per chi ha lavorato in miniera. Abbiamo deciso di utilizzarle per creare qualcosa per la comunità.
VALENTINA GERVASONI
C’è un particolare interesse nei vostri lavori e nella vostra pratica artistica per il suono, la voce e la parola. Guardate ad essi come a dispositivi che a tratti possono essere attraenti, a tratti spaventosi. Se doveste definire il suono come spazio politico, che tipo di spazio sarebbe?
ADELE DIPASQUALE
Mi occupo di voce e del rapporto tra voce e linguaggio da un po’ di anni. Il linguaggio normativo, per come l’abbiamo ricevuto storicamente, è spesso uno strumento di oppressione, di controllo, di definizione di identità che stanno strette e da cui è difficile uscire. Nell’ultimo periodo mi sono focalizzata soprattutto su come si può usare la voce per ampliare o uscire dalle categorie prestabilite e riscrivere nuovi linguaggi attraverso l’oralità, i linguaggi non verbali e tutte quelle forme di comunicazione che in qualche modo non sono state storicamente validate. L’obiettivo è uscire quindi da strutture di oppressione, di potere e dare voce a voci silenziate, soppresse, per amplificarle. Favorire le polifonie alle narrazioni uniche e totalizzanti.
IRENE GUANDALINI
C’è un aspetto specifico della tua ricerca artistica, Adele, che riguarda la magia come genere letterario e le sue relazioni con la poesia e la parola che evoca. Caratterizzate da un linguaggio che allude, più che spiegare, le formule magiche aprono a ciò che è sconosciuto, misterioso, a volte connesso all’aldilà, in generale a ciò che non possiamo controllare o conoscere e possedere pienamente. Le formule magiche hanno il potere di incidere sulla realtà e far accadere qualcosa, hanno cioè potere performativo. A tal proposito in passato hai parlato di linguaggio di insubordinazione, intendendo le parole magiche come forme di resistenza all’epistemologia egemonica contemporanea. è un aspetto che apre a un discorso in un certo senso più esoterico, di connessione con gli spiriti e un al di là che mi sembra risuoni perfettamente con quanto ci raccontava prima Alessandra delle maschere.
ADELE DIPASQUALE
Il mio interesse per la parola magica nasce proprio dalla sua capacità di avere un effetto reale. Quindi dico, e dicendo produco azione, produco un risultato.
La seconda linea di interesse nella mia ricerca è quella di pensare alla pratica medianica, all’idea di farsi corpo per una voce altra. È una metodologia che per me funziona anche applicata nella pratica artistica, dove l’artista, attraverso se stessa o attraverso il proprio corpus di lavori, incarna queste polifonie e ne diventa veicolo. Mi interessa molto che sia una pratica anche incarnata, e non solo teorica, e che abbia a che fare con un tipo di conoscenza esperienziale e legata ai sensi, e non esclusivamente logica, razionale.
La terza linea di interesse infine riguarda il pensare la magia come un ordine di realtà altro. Siamo soliti dare per validi e per reali concetti molto astratti, come i confini, il denaro o le carte d’identità, tutti elementi teorici che però hanno un peso reale sulla vita delle persone, con delle conseguenze materiali. Dall’altra parte pensiamo agli spiriti o agli angeli come non reali. Si tratta di una divisione tra sistemi di realtà che viene validata da una divisione linguistica. In questo caso per me il pensiero magico riporta alla luce quanto il prodotto della società attuale sia in realtà il prodotto di una divisione linguistica. La parola magica ha il potere di mettere in discussione quello che noi consideriamo realtà.
ALESSANDRA MIGNATTI
Mi riallaccio per concludere a quello che ha detto Roberto sul canto, perché cantare, in particolare il canto corale porta ad avere un respiro comune, e induce lo stesso respiro in chi ascolta. E questo porta a fare comunità. Siamo nel campo del non comunicativo, dove la cosa più importante non è mandare un messaggio, ma mettere in comunicazione. Essere nel canto porta all’incanto, cioè a potersi meravigliare. Del canto come veicolo se ne è occupato un grandissimo maestro del teatro, Gerzy Grotowski, per cui l’attore, che lui chiama performer, è colui che va al di là delle cose, capace di far vibrare una realtà diversa e come una sorta di ascensore porta verso forze primigenie.
Una visione che ci riavvicina tantissimo anche al discorso della maschera. Chi ha provato a indossarla, sa che la maschera è una forza che trascina, modifica completamente sia la tua struttura corporea che la tua capacità di parlare. Devi prima metterti in ascolto della maschera, per poterla poi eventualmente dominare e non essere sopraffatta dallo spirito della maschera. Trovo molto interessante questo lavoro sul canto per questo motivo, perché può far vivere un’esperienza di conoscenza e un’esperienza di trasformazione personale, solo attraverso una vera vibrazione. Anche la maschera come il canto sa farlo, sia quando fa ridere, sia quando fa molta paura. Questo è l’importante, ancora prima dei messaggi da dare, noi dobbiamo agire sulle persone facendo comunità.
Solo se ritroviamo anche un senso della comunità più stretto, riusciamo veramente ad andare oltre tante divisioni e creare qualche cosa di nuovo. Però prima bisogna, secondo me, ricucire tanti strati. E il canto può farlo, perché parlando del passato, ha la possibilità di parlare del futuro. Allo stesso modo nel carnevale c’era sempre qualcuno che faceva le profezie e si noti che le profezie non profetizzavano altro che quello che si sapeva già, ma era comunque confortante l’idea che il mondo potesse andare avanti.
Quindi ben venga la parola che va oltre la parola, la voce che va oltre la cosa. Peter Brook dice che nel teatro in fondo il messaggio è secondario, vengono prima la relazione tra le persone e lo stare assieme. Riscoprire questo anche in un lavoro che si fa a Dossena è bellissimo e sono molto contenta che lo facciate. Questo è il modo per ritrovare l’autenticità della maschera, richiamare una realtà all’altra.