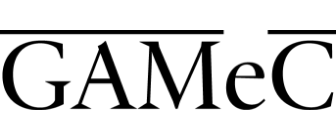Le riflessioni dell’architetta e ricercatrice Francesca Gotti e dell’artista Alessandro Quaranta si incontrano nel rapporto tra persone e luoghi, intrecciando memorie individuali e pratiche condivise di cura del territorio.
Nel giugno 2025, in occasione del Festival Na.Tur.Arte – L’Area Wilderness Valparina tra ospitalità, Arte e Natura e nell’ambito del quarto ciclo di Pensare come una montagna – Il Biennale delle Orobie, i partecipanti all’incontro sono stati invitati a condividere narrazioni che esplorano forme di relazione con l’ambiente naturale.
Segue questa introduzione la pubblicazione di un estratto dell’incontro.
FRANCESCA GOTTI
La cinematografia italiana ed europea degli ultimi venti anni ha prodotto molteplici racconti del ritorno alle montagne – “Il vento fa il suo giro” di Giorgio Diritti (2005), “Le otto montagne” di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (2022), “Anatomia di una caduta” di Justine Triet (2023) – o alla vita rurale – “Le meraviglie” di Alice Rohrwacher (2014), “As bestas” di Sorogoyen (2022): racconti che hanno in principio un taglio romantico, idilliaco, ma che prendono presto una deriva cruda, se non addirittura cupa. Queste narrazioni condividono il desiderio di esplorare la possibilità di ricongiungersi con una dimensione selvatica ed estrema della natura, un cambio di vita e di paradigma guidato da un bisogno interiore.[1]
La ricerca di un luogo remoto riflette un richiamo inconscio, profondo: ricominciare, mettersi alla prova, fare spazio, imparare, orientarsi. Questa intuizione del ritorno mette in discussione innanzitutto la dimensione temporale della relazione che intessiamo con un luogo: quanto ci tratteniamo? Quanto spesso torniamo? E se restiamo, quanto spesso ci allontaniamo?
Il ritmo con cui ci relazioniamo al luogo è dettato dal nostro bisogno di (ri)congiungerci con esso e dalle nostre capacità di soddisfare questo bisogno; al tempo stesso il tempo determina e scandisce le possibilità che abbiamo di plasmare il luogo e farci plasmare reciprocamente.[2]
Quello che le pellicole illustrano con sensibilità è la fragilità dei nostri bisogni di fronte alla “Natura estrema”: non è solo l’essere esposti a stagioni ed eventi climatici, o all’imprevedibilità e crudeltà del selvatico; scontrarsi con l’imperturbabilità della “Natura immensa” dinanzi ai drammi umani. Ma è anche la complessità delle micro e macro trasformazioni del paesaggio, dove si stratificano il lavorio incessante delle secolari metamorfosi geologiche, la violenza dei deturpanti interventi antropici, l’abbattersi di improvvise catastrofi, il declino dei sistemi produttivi tradizionali.[3]
Più intense sono frequenza e durata delle nostre interazioni con il luogo, e più chiari ci appariranno i fattori che concorrono a modificarlo, più comprensibili risulteranno segni, apparizioni, e assenze, che resterebbero altrimenti oscuri e indecifrabili. E nella manifestazione più estrema della restanza,[4] come scelta consapevole e radicale, entriamo attivamente nella vita del luogo. Da osservatori diventiamo custodi: comprendiamo come il paesaggio, che ci si rivela infine come sistema di sistemi (vegetale, animale, geologico, sociale, produttivo, logistico…), sia costantemente attraversato da eventi che ci condizionano e dei quali siamo fautori – più o meno direttamente –, e che questi cambiamenti ci seguono anche quando ci allontaniamo e finché nuovamente torniamo.
Siamo pronti allora ad affacciarci al paesaggio come un bene comune: qualcosa che abbiamo il diritto e il dovere di preservare, del quale siamo responsabili.[5] Questo significa riscoprire quel mondo di pratiche secolari che hanno assistito, non certo passivamente, all’avanzare del bosco e alla scomparsa dei pascoli di altura, all’abbandono di terrazzamenti e muretti a secco, alla costruzione di impianti e infrastrutture, allo sbancamento di cave, allo sgretolamento di artefatti montani come i calecć o i baitei.[6] Pratiche che si sono opposte lottando, ricostruendo, riconquistando, o semplicemente restando, abitando, lavorando. Ma quando arriva il momento per le vecchie guardie della montagna di andarsene, allora diventa ancora più necessario tornare: è quello che fanno molti giovani, guidati da un richiamo antico, disposti ad offrire le loro fragilità alla Natura.[7]
Attraversare, tornare, osservare, ascoltare, registrare il paesaggio costituiscono le prime e fondamentali azioni di cura che tutti abbiamo il diritto e il dovere di reclamare, per poter continuare a tutelare luoghi che rischiano altrimenti di essere cancellati se non addirittura distrutti.
ALESSANDRO QUARANTA
Sono un artista che lavora con il mezzo video, mi occupo di immagini. Con il mio lavoro voglio mostrare ciò che non si vede in una fotografia che ritrae, in modo oggettivo, un paesaggio. Molto spesso la fonte di ispirazione è legata a un luogo. Ma che cos’è un luogo?
Un luogo non è necessariamente qualcosa di riconoscibile — come un edificio, una chiesa, una cappellina. Può essere anche un punto ben preciso in un bosco, in una radura. Un posto che conserva una memoria, un ricordo, un legame affettivo. E proprio questo legame fa sì che quel posto venga frequentato, e che quella frequentazione diventi quasi rituale, perché il luogo diventa depositario di presenze, di sedimentazioni. Per rendere tutto più concreto, ora vi racconto un luogo che non vedete — potete solo immaginarlo. Dopo che l’ho raccontato, vi passerò una fotografia.
Tutti i luoghi che racconto sono luoghi di montagna, perché la montagna per me è un riferimento importante. Sono nato a Torino ma ho un legame molto forte con la montagna, per ragioni familiari. I miei genitori provengono da un piccolo paese in una vallata della provincia di Cuneo, una realtà simile a quella della Val Brembana. Anche lì si è verificato uno spopolamento dagli anni Sessanta in poi. Come è successo anche qui. Sono figlio di una generazione che si è trasferita in città per una vita più comoda, un lavoro meno faticoso, più remunerativo rispetto al tenere le bestie, curare i prati, i terrazzamenti. Mi interessa il pensiero che sta dietro all’abitare la montagna. Anche il luogo che ho scelto di raccontarvi è montuoso.
Siamo nelle Alpi dell’Alta Provenza. Nel 2015, non so se vi ricordate, ma in primavera, verso maggio, sentii alla radio una notizia scioccante: un incidente aereo. Un pilota della compagnia Germanwings si era schiantato volontariamente contro una montagna. Il massiccio si chiama Tête de l’Estrop, raggiunge i 2600–2700 metri. L’aereo partiva da Barcellona ed era diretto a Francoforte. Gli aerei che seguono quella rotta passano sempre su questa zona montuosa. Quel giorno, quel pilota ha deciso di suicidarsi durante il volo. Sono morte tutte le persone a bordo, passeggeri ed equipaggio.
Mi trovavo a pochi chilometri dal luogo dell’impatto. Cercavo di immaginare se la montagna, nel suo silenzio, avesse conservato memoria di quell’impatto. Non era rimasto nulla. L’aereo si era disintegrato. Siccome l’impatto era avvenuto in una zona molto lontana dai centri abitati, nessuno aveva sentito nulla. Non ci sono memorie, nessuna testimonianza acustica.
Camminando nei dintorni, mi sono trovato in una boscaglia molto fitta. Avanzando, sono arrivato a una depressione del terreno. Mi avvicino, ed entro in punta di piedi. Là sotto, trovo un laghetto, come in un cratere, circondato da una pietraia. Dall’altra parte del lago, vedo un cerbiatto che si sta abbeverando. È stata una visione magica. Pensavo a quell’aereo, all’impatto devastante. Di fronte a me c’era il silenzio assoluto, un animale che si dissetava alla fonte. Da quel momento ho iniziato a tornare lì, a fotografare, a fare riprese video. Ci sono tornato anche d’inverno, e sotto il ghiaccio del lago ho visto le ranocchie, in letargo. Sembravano congelate, immobili sotto una lastra di vetro. Un’altra presenza importante.
Ecco, per me un luogo è un vuoto abitato da una presenza. In questo caso, la presenza è rappresentata dagli animali. Il cerbiatto, le rane. Quel posto ha assunto un’importanza sacrale. “Sacro” ci fa subito pensare al religioso, ma in questo caso parlo di un sacro che ci radica alla terra. Un senso di appartenenza. Pur non essendo originario di quel posto, sentivo un’appartenenza magnetica. Un luogo che può essere frequentato, visitato più volte, che genera una ritualità. Adesso vi mostra una fotografia. Probabilmente, sovrapporrete il racconto che avete ascoltato a questa immagine. Se l’aveste vista prima, senza il racconto, probabilmente l’avreste guardata con altri occhi.
Vi racconto un altro luogo. Siamo nelle Alpi Cozie, in provincia di Cuneo, sotto il Monviso. Il Monviso è questa montagna piramidale di gneiss, alta 3841 metri sul livello del mare, accompagnata dal Visolotto, un’altra montagna triangolare che lo affianca. Sotto c’è la valle Po, con molte praterie, cenge, un po’ come potrebbero essere anche qui. L’aspetto orografico è un po’ diverso, perché la valle è esposta in direzione nord-sud: il versante a nord è completamente esposto al sole, quello opposto, invece, è in ombra. Dopo una lunga escursione, arrivato al Pian del Re, scendo sul versante, eludendo il sentiero segnato sulla cartina geografica. A un certo punto, guardando verso valle, vedo una piccola borgata di case abbandonate, tutte in pietra, colta da un raggio di sole che trapassa le nuvole e illumina proprio quella borgata. Si crea un effetto magico, sarà capitato anche a molti di voi. Mentre scendo verso questa borgata, vedo un gruppo di caprioli con un piccolo che pascolano. Avvicinandomi, scappano. Anche qui, sono stati loro a indicarmi il luogo. L’animale, la frequentazione: finalmente, quel luogo si è riempito di una presenza. Quel tipo di borgate, nella parlata locale, in lingua occitana, si chiamano “meire”: piccole località in pietra usate come ricovero per le bestie, soprattutto durante la stagione estiva. Spesso questi luoghi hanno una denominazione particolare, che si perde nella notte dei tempi, e che probabilmente nemmeno i nostri nonni conoscono. Forse quei nomi custodiscono incontri simili a quelli che sto raccontando. Avrei potuto dare io stesso un nome a quel posto, a partire da quell’apparizione. Invece, questa località ha già un nome: si chiama Meire Fondue.
L’uomo, da sempre, ha bisogno di nominare i luoghi: per poterseli ritrovare, per poterli mappare, per avere una relazione stabile tra sé e lo spazio. Vorrei riportare un estratto di un bellissimo romanzo di un autore svizzero che scrive in romancio, una lingua neolatina del cantone dei Grigioni. È dedicato a un pastore che abita in un piccolo rifugio, vive di pastorizia e definisce un luogo.
“Quattro galline si siedono sul sasso del ghiacciaio. Giacumbert gira la testa. Quattro galline volano via dal sasso del ghiacciaio.
Ecco la Gaglinera. Si sono svegliate.
Tutte stanno in riga, nell’orizzonte grigio, sembra che si mettano sull’attenti, sulla roccia levigata dal ghiacciaio.
Le file scendono giù, all’improvviso: una, due, quattro.
Una più veloce, come tante perline Gaglinera.
Sono le sei e Giacumbert è già tutto zuppo. Guarda e guarda, stupito. Questo sarebbe anche il giorno del giudizio”.
Lui definisce quel luogo la Gaglinera, perché su quel sasso levigato dai ghiacciai pascolavano le galline.
Vi racconto quest’ultimo luogo. Anche in questo caso siamo nel mio paese d’origine, si chiama Aisone, in mezzo alla Valle Stura di Demonte, in provincia di Cuneo. Dietro il paese, un po’ come qui, c’è una parete rocciosa calcarea alta 300-400 metri. Sopra quella parete, ci sono boschi di faggio. In un periodo della mia vita segnato da infelicità e instabilità psicologica, mi sono inerpicato oltre quelle rocce calcaree. Dopo una lunga e impervia camminata, sono giunto su una radura erbosa. Affacciandomi su un poggio, su una sorta di precipizio che guarda a valle, proprio in quel momento ho avuto un’apparizione repentina: un’aquila, sfruttando le correnti ascensionali, si è sollevata dalle pareti sottostanti e mi è apparsa davanti, in volo. Me la sono trovata lì, di fronte. Anche lei si è spaventata, non si aspettava di trovare qualcuno. Ha fatto un volo improvviso e si è riprecipitata giù. In quel punto esatto, mi sono fermato. Il tempo, per me, si è fermato. Ho capito che quella coincidenza — trovarmi lì, proprio mentre il vero abitante di quel luogo stava salendo — era qualcosa di molto forte. In quel momento mi sono sentito un intruso, o forse un testimone. Da allora, ogni estate, quel posto è diventato per me una meta di pellegrinaggio. Non sempre nello stesso periodo, ma se posso ci torno. È un luogo che mi dà pace, mi riconnette a quell’evento, e mi ricorda quanto noi, come esseri viventi, siamo in relazione profonda con l’ambiente in cui viviamo. Vi passo la fotografia, così potete guardarla. E potete constatare quanto un’immagine, scollegata dal suo racconto, abbia un valore completamente diverso.
Sulla base di questi stimoli, vi chiedo ora di descrivere un vostro luogo. Ripeto: non un luogo sacro nel senso dogmatico, riconosciuto dalla Chiesa o da un credo collettivo. Ma un luogo sacro per voi. Un luogo importante nella vostra esperienza.
PARTECIPANTE
È molto interessante che i tuoi luoghi siano diventati speciali nel momento in cui hai incontrato degli animali. A me questa cosa non è mai successa. I miei luoghi sono quelli in cui ho annullato tutti. E questa cosa un po’ mi colpisce, mi fa paura.
Io sono Anna Maria; il mio luogo è un posto che si chiama Corna di Ca, qui a Roncobello. Da lì guardi verso la valle, guardi al punto d’accesso al paese. Era un po’ che non pensavo a questo posto: qui non è successo un fatto particolare ma è un posto in cui da ragazza andavo in cerca di ispirazione. Ciò che accadeva nella valle verso Roncobello mi stimolava pensieri importanti ed è un posto che ho condiviso solo con una mia amica: spesso andavamo lì insieme ma nel silenzio. Non ci sono più stata. Forse perché è diventato più difficile da raggiungere visto le parecchie piante.
ALESSANDRO QUARANTA
Puoi dirmi solo cosa si vede da lì?
PARTECIPANTE (ANNA MARIA)
Il vuoto, la valle, lo strapiombo, la strada che arriva a Roncobello, le rocce, l’orizzonte, quindi l’apertura verso il mondo. Quello è il punto più stretto prima di arrivare in paese e, da sopra, vedi questo, vedi tanto verde. Forse adesso meno a causa delle tempeste. Vedi il colore delle rocce, molto intenso; senti la corriera che arriva e suona. Non so se suona ancora ma un tempo suonava. Le auto a salire il venerdì sera erano molte di più, quindi era più divertente cercare di capire chi arriva, cosa vorrà, cosa porterà. E vedi il sole tramontare.
PARTECIPANTE
Sono Paolo. Premetto che in montagna mi è sempre piaciuto andare da solo perché mi dà un senso di libertà. C’è un posto vicino a una montagna che si vede dappertutto, si vede dalla valle, però è un posto dove non passa più nessuno da anni. Me l’aveva fatto scoprire un cacciatore di camosci. Quel posto si chiama Vendulpia. Probabilmente da lì non è mai passato nessuno di voi. C’era un lungo sentiero che collegava varie baite, oggi tutte in disuso. Mi piaceva passare da lì da ragazzo perché non trovavo mai nessuno, ti sentivi proprio libero. Vedevi i camosci, vedevi le aquile, vedevi le vipere. Ti interrogavi sul perché dei nomi strani di questi luoghi, tipo Vendulpia, o come Pas dell’Aesì, Ol baitù, I cuncoi. Ad esempio, l’Aesì è un pentolino di pietra ollare, il fatto che il passo sulla cima di una montagna si chiami così generava in me un po’ di curiosità…per cui mi piaceva girare lì, quando ero lì, ero contento.
PARTECIPANTE
Sono Fiorella e sono anche moglie di Paolo. Anch’io amo andare da sola in montagna, soprattutto quando fa il secondo [NdE: turno operaio]: lui non lo sa, ma io scappo.
Il mio posto del cuore è Monte Campo sopra le baite di Mezzeno. Lo raggiungo facilmente partendo da casa, seguendo tutto il sentiero dei roccoli storici. Si arriva a questo pianoro da cui si apre una visione immensa sulla Presolana, l’Arera, i Tre pizzi. In primavera, fioriture immense di crocus. Sul finire dell’inverno, nelle pozze semi sgelate vedi il riflesso della Arera. È molto ampio lo sguardo che hai sulla valle, verso Piazza Lenna, per cui al tramonto c’è molto silenzio, molta quiete, ti dà proprio una sensazione di pace. Spesso e volentieri si vede l’Aquila che gira, ma anche il gallo forcello piuttosto che camosci. Essendo da sola riesco ad arrivare anche molto vicino ai caprioli che pascolano. Sono sempre incontri inaspettati ovviamente, però ravvicinati, ma è la pace.
ALESSANDRO QUARANTA
Ci torni spesso?
PARTECIPANTE (FIORELLA)
Almeno tre o quattro volte l’anno.
ALESSANDRO QUARANTA
Da quando hai iniziato a frequentarlo, hai notato dei cambiamenti? Hai visto evolversi il paesaggio nel corso degli anni?
Partecipante (Fiorella)
No, l’ambiente è sempre lo stesso, non ha subito particolari cambiamenti nel tempo. Ci sono i roccoli che dominano dall’alto, ognuno curato e mantenuto con attenzione nel tempo. Anche i sentieri vengono sistemati, perché ovviamente la natura cresce e si espande. C’è sempre questa sensazione che, anche se non vedi nessuno, qualcuno è passato, ha mantenuto il posto. E questo ti restituisce un senso del passato, ma anche del presente: un sentiero ripristinato, una piccola frana sistemata dopo l’inverno, una pianta caduta che non c’è più al passaggio successivo. Ti accorgi che, piano piano, la gente si prende cura del luogo. Non sono mete di turismo di massa, è comunque frequentato da gente che lo rispetta. E quei roccoli, per essere mantenuti, vanno puliti, e questo contribuisce a tenere viva l’intera area.
PARTECIPANTE
Io sono Francesco. Ho disegnato le creste del Menna e del Pizzo che sono due montagne locali e che in realtà non sono un luogo specifico, però sono il luogo in cui torno quasi tutti gli anni perché mi permettono di vedere, tutti insieme, in un colpo solo o in poco tempo, altri luoghi significativi per me. Quindi è un punto di osservazione.
Io sono di Seriate, quindi questo percorso mi permette di tenere assieme in un gesto solo, in poco sguardo, oscillazione del campo visivo, i luoghi importanti della mia formazione. La cosa a cui ho pensato dopo averle disegnate è da che punto di vista le ho ritratte. Sono creste, potevo disegnarle di qua e di là e su e di giù, ma in realtà mi sono accorto che le stavo disegnando dalla prospettiva della prima casa in cui sono stato qui a Roncobello per più anni. Senza neanche accorgermi le ho disegnate da quel posto specifico, ci ho pensato dopo. Anche quello è un luogo significativo, quindi in realtà ne ho rappresentati due in uno.
PARTECIPANTE
Io sono Mauro. Mi ricollego direttamente al tuo racconto perché anch’io ho pensato a una cresta in realtà. Io sono di Gromo, Valle Seriana, siamo dall’altra parte. Il mio luogo d’affezione è un laghetto alpino, poco sopra un paio di ore di camminata da casa di mia madre, dove io sono cresciuto, che si chiama Cardeto. Il 2019 è l’anno in cui è venuto a mancare mio papà, e arrivato a questo laghetto c’era gente, più del solito che è vuoto. Avevo bisogno di un luogo meno rumoroso, ho provato ad andare oltre il laghetto, salendo proprio dalla montagna: un percorso inventato, totalmente inventato, in mezzo ai rododendri, in mezzo ai rovi, fino a quando siamo arrivati proprio sulla cresta, che non ha un nome probabilmente, perché conduce poi al Madonnino. Mi sono seduto e di fronte a me c’era questo sinuoso moto della montagna che conduceva lo sguardo verso l’orizzonte, ma l’orizzonte altro non era che una corona di altre montagne. Vedevo la Presolana, il Monte Secco; si vedevano anche gli impianti sciistici degli spiazzi di Gromo. Quella è stata la prima volta che ci sono andato. Lo penso in effetti come un luogo sacro, o forse consacrato al pensiero di quel momento in cui avevo bisogno di immergermi in un luogo nuovo, un momento in cui meditavo ancora molto circa la scomparsa di mio papà. Avevo proprio bisogno di un posto pulito cioè che non avesse un precedente nella mia memoria, ma che potesse da quel momento essere associato a questa cosa.
Non ci vado spesso. Il mio disegnino è quella crestina che accompagna lo sguardo e in qualche modo ti distende. Era molto verde tra l’altro, siccome non è una quota elevata. Questa erba di montagna, che punge anche un po’, è come se sciogliesse i nodi del pensiero…questo verde potente.
PARTECIPANTE
Mi chiamo Maria Luisa, frequento Roncobello da cinquant’anni; vengo solo in vacanza, sono una cittadina, ma è un paese che amo. Non ho un luogo particolare, quello che mi colpisce, che mi fa veramente pensare, che mi ruba il cuore, sono i profumi, gli odori.
Il profumo del tiglio, del timo, della silene, i fiori. Sono i profumi che mi fanno stare bene, ma anche i rumori, delle cicale o i grilli alla sera. A volte quando sono a casa mi sembra di sentirli, di avere dentro di me certi profumi di montagna. Il nuovo cimitero di Roncobello iniziava curvando su un viale che era pieno, pieno, pieno di tigli. Il profumo del tiglio è una cosa che mi fa impazzire. A volte a casa quando sento il profumo di tiglio, penso a questo posto, a questo nuovo cimiterino, che era bellissimo.
FRANCESCA GOTTI
È qualcosa di atmosferico. È il potere di luoghi o atmosfere che poi riusciamo a trattenere con noi in un altro momento, cioè che possiamo rievocare, riattivare. Sono delle memorie olfattive.
PARTECIPANTE
Mi chiamo Oscar, sono messicano, ma frequento l’Italia da un po’. Il luogo che mi piace più frequentare, in tutti i paesi in cui arrivo, è il mercato. Perché arrivi da solo, nessuno ti conosce, entri in mezzo a una massa di gente, una massa di rumori, un cumulo di sensazioni, un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. A tal punto che quasi percepisci un senso di vuoto.
A volte, proprio dove c’è l’accumulazione di tante cose, ti sembra di avvertire il vuoto.
Martedì scorso, per esempio, il mercato non era così bello, però era vuoto, ma ancora si sentiva il rumore: le scatole che si muovevano, la voce di qualcuno che offriva frutta, verdura. Mi piace molto quel tipo di rumore. A volte ti fanno assaggiare qualcosa: è come se, entrando al mercato, si attraversassero tanti luoghi geografici diversi, che non sono tuoi, ma che si mescolano. In Messico, i mercati non sono come qui, dove la gente arriva e poi se ne va e tutto si svuota. Sono spazi che si riempiono, si svuotano, ma nel frattempo le persone si mescolano così tanto che quasi si cancellano. E questa cosa, a me, dà pace. Come se nessuno ti guardasse davvero, nessuno ti facesse pesare la tua presenza. Solo se ti avvicini, magari c’è un contatto con qualcuno, uno sconosciuto. Anche se poi tutto si svuota, rimane un ricordo. Magari non lo racconti nemmeno, ma ti resta dentro. In Messico, poi, c’è l’odore delle spezie. Qui magari è l’odore delle persone, degli oggetti vecchi, dei vestiti nuovi o usati. Tutto si mescola. Per me sono esperienze molto diverse. E a volte non compro nemmeno nulla. Ci vado solo perché mi piace confusione, questa pluralità. E mi piace anche che in Italia, nei mercati, arrivino persone che parlano tantissime lingue, idiomi, dialetti.
FRANCESCA GOTTI
Secondo me, tutto questo ha molto a che fare con il carattere rituale di certe processioni religiose: questa marea di corpi che improvvisamente si coordina, generando un caos. Ci sono i suoni, le voci, tutti questi corpi assieme che, nonostante la densità, sono uniti in un momento magico. E poi, tutto sparisce. C’è una componente magica, direi una sacralità profana, che però — soprattutto nel contesto urbano, che è chiaramente diverso da questo — ti permette di fare un’esperienza rara. Perché nella vita politica urbana non ci sono tante occasioni di sacralità: è molto più frammentata.
Invece queste ricorrenze — come i mercati all’aperto che arrivano, si montano e poi spariscono — creano impalcature magiche. E poi, svaniscono.
Mi ha colpito il tema che hai portato tu, Oscar, quello degli odori. Ma c’è anche la luce. Qui da voi, più che in città, la luce è completamente diversa. C’è anche la foschia, quando guardi nella valle. E poi, nel mercato, c’è anche il tatto, che non abbiamo nominato molto, ma che ti riporta un po’ alla realtà, alla natura. È paradossale, ma quasi: per fare esperienza della natura, in città, vai al mercato e tocchi le verdure. Anche lì si crea una connessione.
PARTECIPANTE
Io ho disegnato un laghetto che si trova alla base di una cima. È un piccolo laghetto naturale, con un sasso al centro e tanti altri intorno.
L’ho disegnato perché è la prima meta montana che ho raggiunto insieme a mio papà — o almeno, la prima che ricordo. E io credo, o forse mi piace pensare, che una parte di me si sia formata in quel luogo. Ogni tanto ci torno, per riscoprirla, per rinfrescarla.
È il lago di Pietraquadra, appena sopra quello descritto prima.
FRANCESCA GOTTI
Se posso, vorrei riprendere da quello che state raccontando.
Mi è piaciuto molto quando prima si parlava dei roccoli, e del fatto che su questi viene fatta manutenzione. Forse noi, da cittadini — da animali urbani — viviamo la natura in modo diverso. La esperiamo in modo completamente diverso da chi la abita ogni giorno. E tendiamo a dare per scontate molte cose.
Io vengo da Bergamo città, vicino alla Maresana. Se dovessi pensare a un luogo che, per un periodo della mia vita, ha avuto una dimensione “sacra”, sarebbe proprio lì: un campo, subito dopo il quale inizia la Maresana.
Ho iniziato ad andarci in un periodo di transizione, di formazione, e tornavo quasi ogni giorno. Cercavo qualcosa. Come diceva prima chi andava in un luogo per pensare, per guardare l’orizzonte. Con il tempo ho iniziato a percepire i cambiamenti stagionali: l’erba che cresce, che viene tagliata, i fiori… A settembre, un anno, hanno recintato il campo per far passare la transumanza. Poi, dopo il Covid, è stato recintato completamente. E non si poteva più entrare. Per me, quel campo era diventato un ritorno costante. Ma a quel punto ho capito che non era uno spazio pubblico: era un terreno privato. La proprietà ha deciso di chiuderlo, e tutti si sono adeguati.
E lì ho realizzato qualcosa: quando vedi un bosco, un colle, un versante, immagini che potrai andarci sempre, che sarà sempre lì. E invece, se lo conosci bene, ti accorgi che c’è manutenzione: qualcuno taglia, qualcuno pulisce i sentieri. Magari voi che vivete qui potete dirci se avete visto cambiamenti legati a questo. Perché quando una parte dei campi non viene più coltivata, il bosco si riprende tutto. È qualcosa a cui non avevo mai pensato, ma parlando con allevatori e agricoltori ho iniziato a capire meglio le logiche della natura, che non è selvaggia al 100%.
PARTECIPANTE (PAOLO)
Se lasci fare al bosco, va avanti da solo. Magari si strappa qualche pianta ma i prati si perdono subito. Quello che i nostri nonni hanno fatto con tanta fatica — togliere radici, togliere sassi per avere erba da dare agli animali — basta lasciarlo andare per 3 o 4 anni, e non è più un prato. Arrivano le piante pioniere, gli spini… Il prato è delicato. Tenerlo richiede impegno. Se lo si abbandona, sparisce.
È lo stesso con i sentieri: bisogna tagliare, sistemare. Tanta gente lo fa senza dirlo a nessuno: va su, e sistema. Ma se non li segui, si chiudono. Se lasci fare alla natura, in certi posti non ci passi più. Serve un po’ la mano dell’uomo, se vogliamo continuare a godere di quei luoghi. Perché senza sentiero, non ci vai.
PARTECIPANTE (FIORELLA)
Il pino mugo cresce tantissimo in larghezza, quindi chiude i passaggi. Dove una volta si poteva camminare, adesso — se non è frequentato — non si passa più. È una pianta “infestante”, diciamo così.
Chi vuole continuare ad arrivare in un punto, spesso si mette a tenerlo pulito da sé. Oppure lo fa qualcuno per volontariato, perché ama passarci. Dice: “Si sta chiudendo”, e lo libera.
Quando poi nevica, la neve schiaccia il pino e chiude tutto. Per tenerlo accessibile, bisogna tagliare. La natura cresce veloce, cambia i paesaggi.
Quando ero bambina, tutta quella zona erano prati. Adesso è solo bosco. Tutto prato, anche in alto verso il Branchino. C’erano animali, si faceva fieno. I miei genitori andavano a fare il fieno fino al Branchino. Tutto prato. Dopo gli anni Settanta è cambiato tutto. Ora sono quasi solo boschi. Ma la natura è veloce a riconquistare terreno. Prima arbusti, poi alberi. Poi quelli che non resistono, cadono con il brutto tempo… se mai torneranno quelle grandi nevicate. Anche questo è cambiato.
PARTECIPANTE (PAOLO)
Prendi il nome del paese: Roncobello. Una volta si chiamava solo Ronco. Ma siccome in Italia c’erano tanti “Ronco”, ognuno ha dovuto specificare: Roncobello, Roncoscrivia, e così via.
La parola ronco viene dal dialetto, e vuol dire prato tolto al bosco. Cioè, bisognava tagliare il bosco, togliere le radici, togliere i sassi… e alla fine, lì nasceva l’erba. Quello era il runc, il prato ricavato così. Col tempo, ingrassando il terreno, veniva fuori un prato buono. E ancora oggi si trovano località che si chiamano “Ruc”, perché un tempo lì c’era il bosco, poi è diventato prato.
PARTECIPANTE (MAURO)
Avevo fatto un piccolo progetto proprio su un’abitazione che si chiamava Ruc. Il tema era questo: la necessità di dialogare con la natura per poter mantenere uno spazio accessibile.
Mi ha fatto pensare a un fenomeno che si nota spesso nelle nostre valli, soprattutto quelle alte. Se ti avventuri in un bosco — quello che oggi chiamiamo “bosco” — ti accorgi che un tempo non lo era affatto. Perché? Perché si vedono piccole case, vecchie stalle. Mia nonna, e anche mia mamma, mi dicevano che non erano in mezzo al bosco. Erano in mezzo ai prati.
Ci stavano gli animali, ci dormivano la notte. Questo è il risultato anche dello spopolamento, della fine di certe attività che hanno spinto le persone ad andarsene. E tutto questo è visibile nel paesaggio. È un tema davvero affascinante.
PARTECIPANTE (PAOLO)
Una volta si diceva proprio: “Runcafò”. Era anche un verbo: tirare fuori il prato dal bosco. Era un lavoro durissimo: si tagliavano gli alberi, si tiravano via le radici, si sistemava la terra, si “ingrassava”. I nostri vecchi hanno fatto tanta fatica. E oggi, vedendo quei prati che si stanno perdendo, è come se tornassero indietro con la memoria.
PARTECIPANTE (FIORELLA)
I pastori stavano in montagna per mesi. Quei prati li ricavavano togliendo sassi, spostandoli per formare recinti o mucchi, liberando lo spazio per gli animali. Così mantenevano il territorio anche in alta montagna, dove oggi ci sono bei prati: tutto frutto di un enorme lavoro, fatto dai pastori, dai mandriani. Bisognava liberare il terreno per gli animali. O si ammucchiavano, o si facevano muretti a secco. Era un lavoro anche di manutenzione del territorio.
PARTECIPANTE
Mi chiamo Marco. Io ho pensato a diversi luoghi, ma quello più significativo è un bosco di querce da sughero, vicino a casa mia, al di là di una piccola valle. La particolarità è che, da casa, se qualcuno ti chiamava, non lo sentivi. Dietro quella piccola montagnetta, le voci non arrivavano. È sempre stato per me un luogo d’evasione. L’ho frequentato dai sei agli undici anni. Lì avevo costruito un piccolo villaggio, che dovevo ricostruire ogni giorno, perché la natura, se no, se lo rimangiava. Era la mia scusa per uscire di casa, per dimenticare tutto.
Ci passavo ore, e tornavo che era già buio. Oggi, quel luogo è ancora significativo: ci ho messo dentro tanto tempo, tanto sudore. E poi, nel giro di un mese, la natura si è ripresa tutto. Ma è rimasto un luogo in cui, se voglio uscire dal mio contesto e rientrare in me stesso, vado lì. È il luogo per eccellenza. Lì, il tempo si ferma. È come quando prima si parlava dell’aquila che appare all’improvviso: è un luogo in cui il tempo non esiste, o almeno non scorre in modo lineare. Credo che questa sia la cosa più potente: trovare un posto fuori dal tempo. E poi c’era la fatica. Ogni giorno portavo un secchio pieno di cose, perché il villaggio cresceva: diventava sempre più complicato, sempre più grande. Dopo cinque anni era diventato una cosa gigantesca.
ALESSANDRO QUARANTA
Cosa ci mettevi dentro questo secchio?
PARTECIPANTE (MARCO)
In questo secchio: tutto. Ci mettevo frammenti di mattone, ci mettevo vari attrezzi che a mano a mano mi potevano servire. Poi era diventato il luogo della fantasia, quindi aveva un pozzo, aveva una chiesa, aveva un luogo di rappresentanza. Aveva tutto: una cinta muraria, un fossato. Ogni giorno questo luogo cresceva di più, e ogni giorno aveva sempre più bisogno di me. Era perfetto, perfetto per me. A un certo punto ho dovuto abbandonare il progetto, perché era diventato troppo impegnativo.
FRANCESCA GOTTI
Quale ritieni essere lo step successivo del prendersi cura, se arrivi addirittura a costruire una tua città?
PARTECIPANTE (MARCO)
Nel mio caso era proprio il desiderio di evasione. Uscivo da scuola e volevo andare là. C’erano delle entità, per me, là dentro. Le sento ancora adesso. Solo a pensarci mi vengono i brividi, ma era reale. Quelle entità avevano bisogno di me. Magari tornavo il giorno dopo e trovavo il tetto crollato su una scuola o una casa: non poteva restare così. Non era ammissibile.
ALESSANDRO QUARANTA
Quindi, in quanto luogo sacro, è diventato il tuo altare sacrificale?
PARTECIPANTE (MARCO)
Sacrificale del mio tempo. Il mio tempo lontano dal mondo. E la cosa più forte che sentivo era che non potevo esimermi: dovevo andarci. Era come una chiamata. Credo che quel luogo mi abbia salvato, senza far rumore. Probabilmente coincide con gli anni più traumatici della mia vita: la fine delle elementari, dai 7 agli 11 anni. Uno spartiacque. Non ho ricordi di nient’altro. È incredibile. La mia mente ha operato una rimozione totale, tranne che per quel luogo. Ricordo tutto quello che facevo lì. Ma non ricordo nulla della scuola, né dei miei compagni. Solo quel posto.
FRANCESCA GOTTI
Quindi ritieni che l’atto del costruire ha fissato tutto, ha sovrascritto il resto?
PARTECIPANTE (MARCO)
Esatto. Costruire, ma soprattutto sentirmi utile. Sentire che la mia presenza era necessaria. Questo ha reso ogni gesto significativo. Tutto il resto no. È il mio luogo d’elezione, senza dubbio: quel bosco di querce. Si trova a Trevignano, in provincia di Roma, sul lago di Bracciano.
È un luogo che si è mantenuto integro, perché fa parte di una zona parco. La campagna è rimasta campagna. Non ci sono costruzioni, non ci sono elementi che disturbano la vista. Negli anni ’60, come in tutta Italia, si è costruito tanto… ma lì, la forma del luogo è rimasta. È ancora un luogo intatto, con punti di vista puri, che non sono stati “calati dall’alto”.
FRANCESCA GOTTI
Prendersi cura di qualcosa, ci salva.
PARTECIPANTE (MARCO)
Assolutamente. E poi la cura passa anche da sé stessi. È qualcosa di reciproco.
Non credo possa esistere una cura del mondo esterno se prima non hai una qualche idea di benessere personale, di equilibrio interiore.
FRANCESCA GOTTI
Siamo in uno scambio mutuale. Prendendoci cura di un luogo che scegliamo — un sentiero, un prato, un nuovo mondo, un villaggio immaginario — ci stiamo prendendo cura anche di noi stessi. Lo abitiamo, lo addomestichiamo, lo costruiamo. È questo che ci tiene ancorati, rispetto ai cambiamenti, ai traumi, a ciò che accade.
Parlavo con Alessandro proprio oggi: si può prendersi cura di un luogo tagliando l’erba o gli alberi, ma anche semplicemente tornandoci. Tornare è già un atto di cura: lo tuteli, lo osservi, diventi un guardiano silenzioso. Verifichi che non venga cancellato, rovinato, costruito sopra.
Ci sono esempi anche estremi, come un pastore nel sud-ovest della Sardegna che ha protetto il proprio terreno dalla speculazione edilizia. Sono gesti di grande forza.
PARTECIPANTE (MARCO)
Lui l’ha trasformato, l’ha restituito. Ha creato dei punti di vista unici. Non so se parliamo della stessa persona, ma mi pare avesse costruito anche un teatro.
FRANCESCA GOTTI
Sì, lui era Ovidio. Ovidio e le sue pecore.
Il problema è che, quando si entra in ambito urbano, tutto diventa più complicato: ci sono questioni di proprietà, di suolo, di edifici, di occupazione.
Nel mondo naturale e vegetale c’è più margine di azione. Non so se anche a te sia mai capitato che qualcuno ti dicesse qualcosa…
PARTECIPANTE (MARCO)
No, perché era un luogo isolato. Questo discorso lo rivedo molto nei luoghi abbandonati: quelli che non hanno più funzione pubblica. Diventano contenitori accessibili. Se penso ai miei primi lavori con Giulia, era proprio lì che lavoravamo: i luoghi abbandonati erano i luoghi per eccellenza.
In città, dove tutto è costruito e tutto ha una funzione, i luoghi che perdono la funzione diventano spazi dove puoi sovrascrivere, dove hai tempo e possibilità di creare.
FRANCESCA GOTTI
Sì, sono luoghi della possibilità. Dicevamo prima: arrivo in un posto nascosto, cammino, non sono osservato, mi sento solo, e ho una prospettiva privilegiata su qualcosa: una vallata, un cortile, un campo. Da lì posso immaginare, e magari realizzare qualcosa. Ma anche solo resettare. Non ho memorie lì, e posso costruirne di nuove.
Nei contesti urbani, questi luoghi vengono rinaturalizzati: la natura o gli animali se li riprendono. È una riscrittura dei luoghi.
Penso all’ex SNIA: era una fabbrica, poi un cantiere speculativo. Ma il terreno è ceduto, si è aperto ed è nato un lago. Sembra rocambolesco, ma è successo. E attorno a quel lago è nato un collettivo: abitanti, artisti, studenti, che lo hanno presidiato per impedirne l’ulteriore sfruttamento.
Più siamo isolati, meno ci attiviamo, forse. Ma anche in montagna si lotta. Ho visto il gruppo APE, l’Associazione Proletaria Escursionista di Bergamo, organizzare camminate contro la costruzione di un impianto di risalita. Dalle vette alle valli, fino alle città, ci sono forme di cura e resistenza. Anche piccoli ritagli di territorio diventano fondamentali.
Che si tratti di camminare, costruire un mondo parallelo, o salvare un lago appena nato, tutto questo ci riconnette. Dopo il Covid, c’è stato un ritorno nei paesi, una riconnessione diffusa. E anche se magari ora si torna indietro, queste pratiche di cura ci tengono insieme, ci permettono di incontrarci, anche se veniamo da contesti diversi: città, campagna, montagna.
È un modo di riconnettersi a scale più ampie, di riaprire l’orizzonte, sapere che esiste un luogo dove tornare.
PARTECIPANTE (PAOLO)
Sì, e soprattutto per un giovane. Anche solo girare nella natura, che sia in montagna o no, ti costruisce un carattere. La natura non è sempre bella. Ti mette alla prova. Ma proprio perché sei da solo, ti fa crescere. Ti dà sicurezza. Ti dà la misura di ciò che sei. Quando sei ragazzo e hai mille dubbi, fare qualcosa da solo nella natura, e sentire che la natura ti lascia fare, ti aiuta tantissimo.
ALESSANDRO QUARANTA
Sì, perché nel silenzio della natura emerge quello che sei. Non c’è nessuno che ti dice cosa devi fare. E allora, come nel suo racconto, fai cose anche assurde — apparentemente — ma motivato da dentro, non da fuori. È uno spazio vuoto, che non è occupato da nulla, aspetta te. Aspetta di essere riempito da te.
FRANCESCA GOTTI
Ti affacci a qualcosa — una valle, un luogo vuoto — e c’è fatica. Può essere una fatica scelta: decidi di camminare, di salire. Ma ti misuri con te stesso. Ogni giorno fai un pezzo in più, conosci il tuo corpo, la tua testa. La fatica fisica scava pensieri, crea lucidità. Nel 2016 ho attraversato l’Umbria e le Marche, da Assisi al lago di Fiastra. Avevo bisogno di svuotarmi. E quel cammino, quel ritmo, riordina tutto. È una fatica diversa da chi lavora, da chi fa il pastore, certo. Ma ha una dimensione sacra: ti affacci al vuoto e trovi risposte. Come un urlo nella valle: il vuoto ti restituisce qualcosa.
PARTECIPANTE (PAOLO)
C’era un vecchio cacciatore che mi diceva: “Per andare in cima, tu vai lì. Poi te lo dice la montagna dove passare”. Io ci credevo. Anche se i sentieri non c’erano più. Non ti scoraggiavano. Ti dicevano: “Vai!”. E se vedevi un camoscio, glielo raccontavi. Era un insegnamento prezioso: seguire l’istinto, leggere il paesaggio. Anche se non c’è sentiero, te lo dice la montagna.
FRANCESCA GOTTI
È quasi una forma istintiva, no?
PARTECIPANTE (PAOLO)
Sì, sviluppi l’istinto di conservazione. Anche la paura è utile. Ti fa capire i tuoi limiti, ti fa decidere con consapevolezza. E prendersi cura di un sentiero è importante. I nostri vecchi hanno speso fatica. Oggi basterebbe poco: tagliare, sistemare. Ma lasciare un sentiero in buono stato è lasciare qualcosa a chi verrà dopo.
ALESSANDRO QUARANTA
È anche una questione di memoria. Siamo un frammento di una catena che ci precede. Mantenere i sentieri è onorare il lavoro degli avi. Potresti stare sul divano, ma qualcosa dentro ti spinge a prenderti cura, perché tu hai ricevuto — e vuoi restituire.
Vuoi che anche chi verrà possa emozionarsi come te.
[1] Thoreau, Henry David (1854) Walden. Ovvero vita nei boschi
[2] Kropotkin, Petr (2020) Il mutuo appoggio: un fattore dell’evoluzione
[3] Magnaghi, Alberto (2020) Il principio territoriale, Bollati Boringhieri: Torino
[4] Rumiz, Paolo (2007) La leggenda dei monti naviganti, Feltrinelli: Milano
[5] Settis, Salvatore (2012) Il paesaggio come bene commune, Belfagor, 67(1), pp. 81–90
[6] Corti, Michele (2004) L’alpeggio nelle Alpi lombarde tra passato e presente, in SM Annali di San Michele, vol. 17, pp. 31- 155
[7] UNCEM (2025) Rapporto Montagne Italia. Istituzioni Movimenti Innovazioni. Le Green Community e le sfide dei territori. Rubbettino: Soveria Mannelli