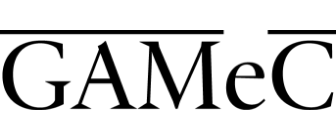ASUNCIÓN MOLINOS GORDO
Quando sono stata invitata a partecipare a Thinking Like a Mountain, mi sono sentita subito spinta a immergermi nel progetto. Il sottotitolo viene da un saggio di Aldo Leopold, e ha risuonato con qualcosa che stavo già sviluppando nella mia pratica artistica: un concetto che chiamo campesino thinking — o pensiero contadino. In sostanza, il concetto propone uno sguardo sul lavoro delle e dei contadini di tutto il mondo che li colloca come esperti e produttori culturali — intellettuali — invece di ridurli a “produttori di cibo” o “fornitori di materie prime”. Il loro lavoro implica enormi quantità di ricerca, tentativi ed errori e una produzione di conoscenza altamente sofisticata. E quando parlo di pensamiento campesino, intendo l’intero spettro: allevamento, pesca, tutto — non solo agricoltura.
Questa riflessione sul pensiero contadino è iniziata quando vivevo in Egitto e viaggiavo in tutto il bacino del Mediterraneo. Lì ho visto che molte e molti contadini — che possono non condividere religione, lingua, metodologie, economie o sistemi politici — condividono comunque una visione del mondo: un senso collettivo di identità e un modo di pensare sorprendentemente simile. Pensano, per esempio, sul lungo periodo. Molti seminano o piantano alberi i cui frutti non gusteranno mai, perché capiscono di far parte di una catena molto più lunga. Inoltre, praticano forme intergenerazionali di responsabilità e di produzione di conoscenza — forme non immediatamente “registrabili” o visibili.
Spesso cerco di mettere in primo piano il suolo stesso come prova di questa conoscenza: un terreno fertile è il risultato del lavoro intellettuale dei contadini. Nel laboratorio che ho concepito per Bergamo, il seme è diventato la prova. I semi sono anch’essi il prodotto del lavoro intellettuale dei contadini e nel laboratorio impareremo le storie che contengono, come sono diventati ciò che sono oggi.
GIULIA COSTANZO TALARICO
Anche a me Thinking Like a Mountain ha colpito subito — considerando la mia formazione accademica, il mio attivismo e il mio lavoro. Mi definisco un’attivista ecofemminista e anche un’accademica attivista: lavoro dentro l’università partecipando allo stesso tempo a forme di produzione collettiva di conoscenza.
Oggi la conoscenza viene costruita in modi profondamente violenti, che escludono tante fonti situate e valide: contadini/e, comunità indigene, donne. Gli studi postcoloniali e decoloniali esaminano come si producano le relazioni tra soggetti dominanti e dominati e come le identità di questi gruppi vengano costruite come “subalterne”. Gayatri Spivak sostiene che ciò comporta violenza epistemica, perché costruisce l’“Altro” come qualcuno la cui soggettività viene cancellata, negata, trattando le “persone subalterne” come se fossero senza storia, come se non avessero voce. In questo senso, la teoria femminista ha formulato critiche potenti al pensiero occidentale, sostenendo che l’epistemologia occidentale tradizionale esclude sistematicamente le donne come soggetti della conoscenza. Come spiega Sandra Harding, la razionalità moderna si presenta come oggettiva e neutrale; eppure lo fa universalizzando un punto di vista parziale — quello dell’uomo bianco, borghese, eterosessuale — escludendo così altre prospettive. Per molti anni, il movimento femminista ha proposto epistemologie alternative che riconoscono le donne come soggetti legittimi della conoscenza. Io lavoro soprattutto con donne in contesti rurali, e ancora non sono considerate fonti legittime di conoscenza. Nella mia esperienza ho osservato che le donne sono in gran parte invisibili in agricoltura, e che il loro lavoro viene spesso visto come un semplice “aiuto” agli uomini nella produzione. Allo stesso modo, il lavoro domestico non è riconosciuto come lavoro, ma trattato come una “obbligazione femminile”. Questo è il risultato della divisione sessuale del lavoro nei contesti rurali, prodotta da un sistema capitalistico e patriarcale. Eppure, portano prospettive radicate nei territori e nei corpi — forme di comprensione profondamente radicate che vanno ben oltre il ritmo frenetico che modella l’odierna “Società della stanchezza”, come la chiama il filosofo Byung-Chul Han.
Ciò che risveglia in me l’idea di pensare come una montagna, è precisamente questo pensiero a lungo termine che menzioni. Una montagna è lì, nel suo territorio. Cosa penserebbe? Che storia racconterebbe dopo secoli e secoli? E quali trasformazioni — quali rotture — nominerebbe?
Come accademica che lavora sul sistema agroalimentare e sulle sue conseguenze, mi trovo spesso a cercare di spiegare concetti come la “deterritorializzazione” — il modo in cui il locale viene svuotato, trasformando i luoghi in ciò che il sociologo Jan Douwe van der Ploeg chiama “non-luoghi”. La deterritorializzazione è un processo complessivo di disgregazione rurale che si riferisce a una rottura tra agricoltura e territorio, cioè una separazione delle attività agricole dalle loro realtà locali. L’agricoltura non svolge più la sua funzione primaria di nutrire e sostenere la comunità; allo stesso tempo, la deterritorializzazione prende forma anche nelle relazioni sociali, cioè in un progressivo indebolimento dei punti di riferimento simbolici e culturali dell’identità collettiva quotidiana. Se dovessi spiegarlo a mio nonno, direi: significa che non sappiamo più da dove viene il nostro cibo. Per i miei nonni, questo è inconcepibile; il cibo veniva sempre dal tuo orto, dal tuo frutteto, dalla tua fattoria. Ma oggi non è più così. Il sistema alimentare globale ci permette di mangiare qualsiasi cosa, ogni giorno, a ogni ora. Alcuni anni fa, un rapporto della ONG Amigos de la Tierra ha classificato molti prodotti “food miles” come quelli che invadono sia la grande distribuzione sia i piccoli rivenditori e che possono percorrere fino a 9.000 chilometri prima di arrivare sulla nostra tavola. Ceci dal Messico, pesce da Cina e Argentina, cereali dall’Ucraina, frutta da Perù e Uruguay e caffè dal Vietnam sono solo alcuni esempi. Questo rapporto presenta dati solo per la Spagna, che ha importato più di 25,4 milioni di tonnellate di cibo che hanno viaggiato in media 3.827 chilometri. Tuttavia, è un problema globale. Questa è la deterritorializzazione, e crea disconnessione dalla nostra terra. E, cosa ancora più grave, contribuisce a processi legati al cambiamento climatico, alla desertificazione e così via.
Allora cosa penserebbe una montagna guardando tutto questo dispiegarsi? Dopo secoli di stagioni verdi, stagioni gialle, stagioni marroni — improvvisamente la standardizzazione e l’omogeneizzazione dei paesaggi: terreni appiattiti, monocolture, la terra di fatto “assassinata” per fare spazio a esse. Come dice Vandana Shiva, queste sono monocolture della mente, prodotte da una “cultura della morte” radicata in valori neoliberali che alimentano una violenza intrinseca capace di manipolare natura e società per generare e accumulare profitto e potere.
ASUNCIÓN MOLINOS GORDO
Certo, dobbiamo aggiungere un ulteriore livello: il tempo geologico. Il tempo del mondo e delle comunità che lo hanno abitato. Molte culture indigene, per esempio, ridono dell’idea di estinzione: pensano che la vita sia infinita. Culture più sintonizzate con la vita non concettualizzano l’estinzione nello stesso modo. L’idea stessa di estinzione è legata a una particolare visione del mondo — industriale, capitalista. In termini di modalità di pensiero, come pensiamo è inseparabile da come viviamo e, a seconda dei compiti di ciascuno, si pensa diversamente a vita, morte, continuità. Per persone come i tuoi nonni — che sanno da dove vengono il cibo e la vita — è difficile immaginare una fine, perché comprendono la vita come fondamentalmente inarrestabile. E nel tempo geologico — che supera di gran lunga il tempo umano — ci sono innumerevoli spostamenti e trasformazioni. Il tempo geologico può assorbire ogni sorta di alternanze sistemiche senza implicare una fine apocalittica.
Mi ha colpito anche ciò che hai detto sul non-luogo e sulla separazione del cibo dal territorio. Per me, quella separazione è direttamente legata all’espropriazione delle comunità agricole tradizionali: quando le comunità contadine vengono private della terra, dell’accesso all’acqua, del loro lavoro, dei mezzi di produzione — vengono gradualmente spogliate del loro ruolo storico di produttrici di cibo, e questo è il primo passo verso la deterritorializzazione. Le comunità contadine, e le aziende familiari di piccola e media scala, hanno nutrito il mondo fin dalle origini dell’agricoltura. Eppure, negli ultimi decenni, sono state spiazzate dai sistemi industriali. La produzione industriale riduce il cibo a merce, a luogo di speculazione. È di breve periodo: coltivi un raccolto finché esaurisci la terra, poi ti sposti in un altro paese e ripeti il ciclo — una mentalità estrattiva. Al contrario, la caratteristica definitoria delle comunità contadine e agricole non è l’estrazione ma la conservazione: mantenere, sostenere, garantire un ciclo continuo. È per questo che il sociologo van der Ploeg parla di “decontadinizzazione”: l’erosione dell’agricoltura familiare nel mondo, per molte ragioni diverse. E con quella erosione, viene spazzato via un intero modo di vivere — un sistema-mondo che ci ha sostenuto fino a oggi.
Mentre facevo ricerca sul suolo, ho trovato un fatto sorprendente: tutta la vita sulla Terra dipende dai primi venti centimetri di suolo fertile — da microrganismi a uccelli e insetti. Contadini e agricoltori sono i custodi di quei venti centimetri. Quindi cosa succede quando quei custodi scompaiono, vengono erosi e sostituiti da logiche estrattive?
GIULIA COSTANZO TALARICO
Vandana Shiva dice che il nostro attuale modello agroalimentare sta creando un’agricoltura senza contadini —farming without farmers. In parole di Shiva, i contadini “non sono redditizi” per l’agrobusiness perché la loro agricoltura tende a essere autonoma: conservano i semi, diversificano e dipendono meno da input acquistati. Questo riduce i punti di estrazione del profitto aziendale, poiché la redditività viene amplificata da standardizzazione e controllo: la selezione industriale e i pacchetti di input sono progettati per riportare gli agricoltori sul mercato ripetutamente, mentre sistemi contadini diversificati e radicati nel luogo sono più difficili da inglobare in catene di fornitura uniformi. Ecco perché il modello corporate spinge standardizzazione e dipendenza, estendendole alla fase “digitale” dell’agricoltura industriale: “agricoltura digitale”, strumenti di sorveglianza e piattaforme basate sui dati approfondiscono la dipendenza e consolidano il controllo, culminando nella visione di “coltivare senza contadini”. Nel sistema neoliberale, avere contadini che si prendono cura dell’agricoltura non è redditizio. È meglio — secondo quella logica — rimuoverli: non servono, sono considerati sporchi, arretrati. E la produzione di conoscenza esclude un contadinato che possiede non solo la saggezza del cibo ma anche la saggezza del territorio. Lo trovo scandaloso.
La tua domanda, in effetti, è retorica: cosa viene prodotto da questo modo di agire? Ne stiamo già vedendo i risultati. Il cambiamento climatico è solo la punta dell’iceberg. I dati sono terrificanti: secondo il WWF, in media stiamo consumando l’equivalente di 1,75 pianeti. Se guardi al quadro dei confini planetari, abbiamo già superato sei confini e siamo vicini a superarne un settimo — su nove. Significa che abbiamo oltrepassato soglie oltre le quali non c’è ritorno. L’umanità è in pericolo — il nostro pianeta, tutti gli esseri viventi. Questo modo di produzione semplicemente non funziona.
Ascoltandoti, pensavo anche ai movimenti contadini e indigeni. Di recente, ai contro-vertici intorno alla COP30 a Belém, in Brasile, gruppi difensori indigeni e locali hanno protestato contro la COP stessa — contro ciò che si fa a livello internazionale, che nella pratica è nulla. Gli accordi internazionali falliscono perché non producono alternative reali, mentre a livello di base — nei movimenti — le alternative emergono da una saggezza antica, di lunga durata. Un esempio interessante è La Vía Campesina, un movimento internazionale che riunisce milioni di contadini in tutto il mondo, piccoli agricoltori, popoli indigeni e lavoratori rurali. Lotta per la “sovranità alimentare” (il diritto dei popoli di definire le proprie politiche alimentari e di produrre cibo sano localmente) e promuove l’agroecologia, in opposizione al modello agroindustriale corporate. La sovranità alimentare è saggezza collettiva plasmata da realtà vissute attraverso generazioni, che integra metodi nuovi e conoscenze ancestrali in armonia con la natura, promuovendo giustizia, uguaglianza e solidarietà. Come diciamo in Spagna, la sabiduría de toda la vida, la “saggezza di sempre”, al di là termini di altisonanti come economia verde o economia circolare. È l’economia contadina che ha sempre saputo sostenere il territorio, prendersi cura delle foreste, degli animali e delle persone.
Due cose sono importanti da sottolineare. Primo: non è solo saggezza generale o comunitaria — è anche una saggezza profondamente segnata dal genere, in gran parte prodotta da donne invisibilizzate. Storicamente, in molti luoghi — soprattutto nel Sud globale — gli uomini migravano e le donne restavano nelle aree rurali. Restavano a prendersi cura del territorio, delle foreste, degli animali. Questo vale ancora oggi. Secondo: queste forme di saggezza non sono dunque “una qualsiasi” saggezza — sono spesso saggezze di donne, cancellate. È cruciale renderlo visibile perché le difensore ambientali riconosciute a livello internazionale sono sempre più a rischio, incluse molte donne che proteggono i semi nativi. Sono custodi dei semi — semi di resistenza. In molti casi, le protettrici sono donne. Secondo La Vía Campesina, le donne contadine continuano questo lavoro di conservare, proteggere e salvaguardare i semi, che sono la base della sovranità alimentare. In tutto il mondo, per secoli, le donne sono state responsabili della selezione, conservazione e gestione di una grande varietà di semi. Inoltre, le donne guidano le lotte contro alcune delle maggiori minacce dell’umanità, come il cambiamento climatico, estinzioni di specie, inquinamento ambientale; in America Latina sono ampiamente riconosciute come difensore dell’ambiente, las defensoras, che guidano la resistenza territoriale mettendo a rischio la propria vita — come nei casi di Berta Cáceres e Marielle Franco, tragicamente assassinate.
Un’altra idea chiave da tempo enfatizzata dai movimenti indigeni, contadini e femministi — ripetuta per decenni nei contro-vertici della giustizia globale — è questa: che cosa lasceremo a chi verrà dopo di noi? Viviamo in una società che consuma senza limiti. Consumiamo un pianeta e mezzo — se non di più. E questa è solo la media. Alcuni paesi consumano l’equivalente di cinque pianeti — come gli Stati Uniti. La Spagna consuma circa 2,5. Questi numeri sono devastanti. Non ci fermiamo a pensare a cosa lasceremo ai nostri nipoti o alle generazioni future. Invece, siamo ossessionati dal non morire, dal restare giovani per sempre, dall’apparire giovani. Sono priorità assurde, se ci pensi. Non diamo valore all’invecchiare serenamente, all’essere una persona anziana che sa e trasmette conoscenza. Tutto questo scompare sotto la pressione di consumare e apparire attraenti. Quindi questa domanda — che cosa lasceremo a chi verrà dopo? — è centrale nei movimenti indigeni, contadini e femministi globali. E si allinea a ciò che dicevi: non si tratta di discutere “estinzione: sì o no”, “collasso: sì o no”, ma di vivere in un modo che sostenga davvero la vita. Lo sviluppo sostenibile è, ovviamente, un ossimoro. Ciò che conta è la sostenibilità della vita, o delle vite — come dice l’economia femminista. La vita deve essere al centro. E non solo la vita umana. Quando parliamo di suolo, certo parliamo di nutrienti e insetti, ma per molte persone nei villaggi la terra viene nominata come se fosse una persona viva, con una personalità. Se non piove, la terra sta male perché ha sete, come mi disse una volta un anziano del mio paese.
Non possiamo dimenticare quelle forme di comprensione che un tempo erano ovvie. Non sto cercando di idealizzare o romanticizzare il pensiero contadino — la vita rurale non è idilliaca. Ma dovremmo recuperare conoscenze e saggezze radicate nel territorio, vive, che propongono comprensioni cicliche della vita e insistono sulla continuità con chi verrà dopo — non sul consumo sfrenato.
ASUNCIÓN MOLINOS GORDO
Sì, assolutamente. Credo che la chiave sia ri-significare queste forme di conoscenza, mentre molti di questi gruppi — soprattutto donne del Sud globale ma anche dei paesi industrializzati — vengono stigmatizzati. Sono considerati non istruiti, selvaggi, bisognosi di civilizzazione o cultura. Quando privi le persone del riconoscimento culturale, è più facile eliminarle. Quando c’è un progetto militare per entrare e appropriarsi di una terra, è molto diverso se il proprietario gode o meno di un’ampia legittimità sociale: se la società pensa che i contadini siano destinati a scomparire, diventa facile metterli da parte.
Quanto spesso sentiamo nei media che un certo paese è ancora per lo più agricolo, come se fosse una cosa negativa e l’agricoltura fosse solo una fase da superare per diventare moderni, industriali. Ma quando i paesi abbandonano l’agricoltura, perdono la capacità di produrre cibo e finiamo in crisi complesse su molti livelli. E alla fine, tornando alla nozione di non-luogo, non sappiamo più chi produrrà il nostro cibo, perché sempre meno persone vogliono farlo. Lo stigma sociale associato alle comunità contadine nel mondo è enorme. Pensa alle rappresentazioni cinematografiche: contadini senza denti, inarticolati, goffi, persi nella modernità — o, al contrario, “buoni selvaggi”, troppo dolci e romanticizzati. Ma raramente vengono rappresentati come persone intere: Con idiosincrasie, con autonomia intellettuale, capaci di prendere decisioni, di sfidare il potere — di protestare ai cancelli di una corporazione o di difendersi quando necessario.
Il lavoro che facciamo io e te — e il lavoro di molte collaboratrici e collaboratori, e di pensatrici come Vandana Shiva — è precisamente questo: dalle piattaforme accettate di produzione della conoscenza (come l’accademia, la letteratura scientifica o il mondo dell’arte) lavoriamo per il riconoscimento della produzione di conoscenza rurale, per il riconoscimento della loro produzione culturale e quindi per il riconoscimento dei loro diritti culturali come co-creatori di moltissime cose, inclusi gli stessi semi.
Infatti, il laboratorio che stiamo realizzando dentro Thinking Like a Mountain mira a rendere visibile che i semi che abbiamo oggi sono il risultato del lavoro intellettuale dei contadini di tutto il mondo. Grazie alla loro inventiva nello sviluppare tecniche di miglioramento delle sementi, hanno creato un’enorme diversità di varietà — riso, mais e molte altre — che oggi stanno scomparendo a causa dell’industrializzazione. Molte di queste varietà sono state create artigianalmente — artisticamente, potremmo dire — da collettivi contadini. Alcuni semi tollerano la salinità o la siccità, eppure non sono mai passati da un laboratorio. E alle persone che li hanno sviluppati non è mai venuto in mente di rivendicare brevetti o proprietà; per loro, i semi fanno parte dei beni comuni. Attraverso questi semi, hanno ereditato conoscenze ancestrali. Possono migliorare qualcosa, ma resta per la generazione successiva. Nessuno dice “questo è mio”. Questa logica non esiste nelle culture contadine — oltre i confini, nonostante le differenze — perché condividono una certezza profonda: non puoi recintare un campo, brevettare un seme o rivendicare proprietà privata su un’eredità condivisa.
Il nostro laboratorio, intitolato Crops Are Not Orphans (I raccolti non sono orfani), risponde al termine orphan crops — usato in inglese per indicare colture ritenute poco interessanti per il mercato globale o per l’industria sementiera. Sono chiamate orfane perché non hanno valore commerciale. Ma questi semi sono tutt’altro che orfani: sono indispensabili per molte comunità. Sono parte di diete fondamentali, possiedono proprietà curative, svolgono ruoli cerimoniali, vengono usati come doni. I semi hanno avuto molti usi — venivano persino usati come moneta molto prima che esistesse il denaro. Quindi, quando l’industria etichetta questi semi come “orfani”, ne cancella origini e appartenenza. Se qualcosa è detto orfano, si presume che non abbia custodi — e dunque può essere preso, spogliato, sfruttato. È una strategia cinica di svalutazione di ciò che è prezioso per chi viene considerato irrilevante.
Ecco perché il nostro lavoro — negli spazi che abitiamo — è cruciale: per costruire complicità con la società più ampia. Per rendere visibile ciò che non è ovvio perché la conoscenza è incarnata; perché per le persone con cui collaboriamo queste logiche sono autoevidenti. E se qualcosa è autoevidente, non necessariamente viene spiegata. Quindi accademia, attivismo e arte devono creare ponti, offrendo accesso a conoscenze che non tutti hanno l’opportunità di ricercare, specialmente chi non vive in ambienti rurali — o chi ci vive, ma ne è disconnesso.
GIULIA COSTANZO TALARICO
Hai perfettamente ragione. E vedo anche un altro rischio. L’accademia ha un ruolo importante nel rendere visibili le cose, ma dobbiamo farlo con cautela, perché l’accademia spesso appropria e co-opta sia spazi sia saperi. I tipi di conoscenza di cui parli — semi, territori, modi di vedere e sentire — spesso non sono scritti: non ci sono brevetti, non c’è autorità formale, perché sono mentalità, visioni del mondo, cosmovisioni, cosmogonie — conoscenza trasmessa oralmente. Ma talvolta l’accademia si appropria di queste cosmovisioni e, da una prospettiva decoloniale, parliamo di estrattivismo epistemico. Silvia Rivera Cusicanqui ci mette in guardia. Denuncia l’appropriazione intellettuale compiuta in nome di un “discorso della decolonizzazione”. Ciò implica recuperare strategicamente i contributi di attivisti e pensatori del Sud globale, per poi farli circolare come propri e senza impegno politico. Avverte dunque che non può esistere un discorso o una teoria della decolonizzazione senza una pratica decolonizzante. Quindi è qualcosa che dobbiamo esaminare dentro l’accademia: il privilegio di poter scrivere e assegnare un nome e un cognome alle idee.
È fondamentale chiarire che ciò che diciamo non è nostro. Lo abbiamo imparato da contadini e contadine, dalle persone anziane nei nostri paesi, dalle persone che custodiscono questa conoscenza. Quello di cui discutiamo è una questione epistemologica: come decidiamo di costruire conoscenza. Perché operiamo ancora dentro una gerarchia in cui un tipo di conoscenza è valido e un altro no — considerato improprio o inferiore — e ciò è legato a come la conoscenza dominante è stata storicamente costruita. Francesca Gargallo, studiosa di origine italiana poi naturalizzata in Messico, ha scritto di come l’epistemologia occidentale trasformi altri saperi in “altri”: rifiuta di trattarli come eguali perché non li vuole come eguali. Vuole minoritizzarli — non numericamente ma ideologicamente. Fornisce molti esempi, soprattutto riguardo alle donne indigene e rurali in America Latina, e sottolinea che siamo metà del mondo, eppure veniamo trattate come una minoranza. E credo che lo stesso valga qui. Non si può davvero dire che le popolazioni contadine siano una minoranza. Chiunque viva in città ha qualche parente che vive in un’area rurale. Eppure, la vita contadina viene trattata come periferica, marginale. Questa marginalizzazione è profondamente violenta — prima simbolicamente, poi materialmente attraverso i sistemi economici.
Quindi abbiamo estrattivismo epistemico da un lato — centralizzare uno sguardo occidentale, moderno — e marginalizzare tutto il resto, generando la sensazione di essere ignoranti e di possedere una conoscenza che non conta. Chiamare i semi “orfani” è assurdo: ciò che ti nutre e ti dà vita viene etichettato come orfano semplicemente perché nessuno lo ha nominato o brevettato — non è abbastanza redditizio da contare. È un modo estremamente violento di costruire conoscenza — e si riflette in sistemi economici e politici distruttivi fino al punto sin non ritorno.
ASUNCIÓN MOLINOS GORDO
È esattamente questa la violenza in gioco: violenza sistemica e simbolica nei luoghi dell’enunciazione. E come dicevi, avviene attraverso l’estrattivismo culturale che possono mettere in atto gli accademici, e anche gli artisti — abbiamo visto molti casi — mettendo la conoscenza rurale in una sorta di scatola “d’altri tempi” da studiare di nuovo: tu sei l’oggetto di studio e io sono l’osservatore brillante.
Nell’arte contemporanea spagnola, le narrazioni rurali sono apparse improvvisamente, e molte artiste e artisti ci lavorano. C’è perfino un forum su cultura e ruralità. Sul piano della rappresentazione, piccoli spazi iniziano ad aprirsi per le persone rurali. Eppure, quegli spazi spesso non sono occupati da chi proviene davvero da aree rurali. Invece, sono presi dai neo-rurali — persone di città, spesso di classe agiata, che decidono di andare a guardare una gallina deporre un uovo e, dopo tre mesi di “progetto rurale”, vengono invitate da grandi istituzioni a sedersi su una sedia che non è la loro. Le comunità rurali non hanno bisogno che altri parlino al posto loro. Come abbiamo appena detto, abbiamo la nostra voce e ambiti culturali sovrani. Non abbiamo bisogno di un portavoce che traduca i nostri mondi: cerchiamo solo riconoscimento e inviti a condividere la nostra conoscenza nei nostri termini. Per me, questa è una torsione sopra una torsione. Perché ora, anche quando si apre un po’ di spazio, non siamo noi a occuparlo. Quindi una cosa che sostengo con fermezza è questa: ogni volta che si creano gruppi consultivi — per politiche sulle aree rurali o per progetti artistici, fattorie, parchi eolici, qualsiasi cosa — deve esserci qualcuno “a livello del terreno” coinvolto. Non solo qualcuno della zona, ma qualcuno riconosciuto dalla comunità — qualcuno di fidato, che abbia guadagnato rispetto con un buon lavoro. Se possiamo usare le nostre posizioni per aiutare a ottenere un riconoscimento reale di queste figure come intellettuali, come esperti, come persone competenti che dovrebbero essere invitate a quei tavoli, come Josep Maria Escriba, un agricoltore di Lleida che ha finanziato un gruppo di lavoro per sviluppare un piano di gestione dell’acqua in Catalogna, o Josep Bertomeu Polet, un agricoltore del Delta dell’Ebro, diventato un difensore per tutta la vita della salute del fiume, delle sue acque e dei suoi sedimenti.
E il luogo dell’enunciazione conta. I femminismi ci hanno insegnato che il corpo è un luogo d’enunciazione: le circostanze di vita di ogni persona — la sua spina dorsale — devono essere presenti in questi spazi. Quindi le domande sono: come mettiamo insieme le persone? Come costruiamo reti in cui ognuno contribuisce con qualcosa? Io potrei essere brava a intrecciare cesti o a scrivere testi — qualunque cosa possa avere valore.
Tuttavia, sono preoccupata per la velocità con cui tutto si muove, e per la velocità con cui lo strato sociale contadino viene smantellato, a volte attraverso violenza diretta — come incursioni militari — altre volte attraverso soffocamento economico. Ci sono statistiche di cui non si parla, ma i sindacati — almeno in Francia — hanno iniziato a evidenziare i suicidi degli agricoltori. Negli ultimi anni, era quasi due persone al giorno — circa 600 persone nel mondo agricolo che hanno scelto di togliersi la vita. Questa non è violenza diretta: sono persone completamente spossessate della capacità di sostenersi nel tempo. Perdono comunità e la solitudine è un problema enorme. Inoltre, l’Europa rurale, a differenza di Abya Yala (un termine usato tra comunità indigene per riferirsi all’intero continente americano), si è mascolinizzata, perché noi donne ce ne siamo andate. Per esempio, nella mia famiglia, i miei due fratelli sono agricoltori, come lo erano i miei genitori e i miei nonni. Io sono la prima che non lo è. E lo stesso vale per tutte le mie amiche e i miei amici — i ragazzi sono quelli rimasti; con industrializzazione e meccanizzazione, l’agricoltura si è mascolinizzata anche dentro una sorta di narrazione “testosterone”. Per questo la velocità mi preoccupa: pensare a quanto rapidamente tutto stia accelerando e se siamo davvero capaci di rispondere alla scala del problema.
GIULIA COSTANZO TALARICO
Ricordo che da bambina negli anni ’90 la globalizzazione veniva presentata come una panacea, qualcosa di magico e meraviglioso. Era venduta come un’unione culturale e folklorica, in cui tutti avrebbero viaggiato ovunque e tutti i problemi sarebbero stati risolti. E poco a poco abbiamo scoperto che globalizzazione significava globalizzazione neoliberale: politiche strutturali che modellavano un mondo che impedisse ai territori di essere sostenuti come prima.
Quindi sì, è travolgente, ma ci sono molti luoghi in cui le persone stanno pensando localmente e proponendo alternative — non come modelli globali da copiare, ma come esperienze da condividere, radicate in un luogo specifico. Per esempio, in Spagna Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) — la Rete di Reti per l’Economia Alternativa e Solidale — è una rete nazionale con una forte struttura territoriale che lavora a livello locale e condivide esperienze attraverso incontri nazionali. Promuove iniziative a livello nazionale, locale e comunitario, per esempio organizzando riunioni e laboratori per coordinare le reti locali e condividere prospettive e visioni. In questo senso, REAS si basa su una Carta dei Principi condivisa — redatta nel 1995 e poi aggiornata — che mira a favorire economie trasformative e giuste. Inoltre, ai contro-vertici, al Forum Sociale Mondiale, le persone condividono le loro alternative territoriali e la diversità diventa una forza. Credo davvero che la trasformazione sociale sia possibile se guardiamo dall’interno dei nostri territori — se re-territorializziamo un mondo che la globalizzazione neoliberale ha deterritorializzato.
La ripopolazione, per esempio, è essenziale nelle campagne. In tutta Europa — e in Occidente più in generale — abbiamo visto le campagne mascolinizzarsi. E anche quando le donne sono presenti, restano invisibili, perché vengono inquadrate come aiutanti, non come lavoratrici. Si tratta di ciò che le esperte chiamano “invisibilità statistica”, e spinge le donne ad andarsene del tutto. Ma i movimenti di ripopolazione esistono. In Spagna, e più in generale nel Sud Europa, anche in Italia o Portogallo, molte delle persone che si spostano verso la campagna sono donne che avevano lasciato le aree rurali, hanno vissuto in città e poi sono tornate — a volte non nel proprio paese ma in un altro — portando ciò che hanno imparato e condividendolo collettivamente.
Anche a me la velocità preoccupa — tutti vogliono le cose in fretta, tutto deve essere immediato, viviamo in una società che pretende soluzioni rapide, mentre le soluzioni sono lente. È per questo che le saggezze contadine resistono: si costruiscono nel tempo, non di fretta. Nel movimento Zapatista, la chiocciola è un simbolo che rappresenta l’infinito, é circolare, in movimento, ma lenta. Come dicono: “Andiamo piano perché andiamo lontano.” Se vogliamo andare lontano, se vogliamo lasciare qualcosa di significativo a chi verrà dopo di noi, dobbiamo costruire in modo dignitoso — e questo, secondo me, significa anche lentamente. Il processo ha bisogno di tempo per dispiegarsi e credo che dobbiamo reimpararlo. E se stiamo cercando di recuperare saperi del passato — che sono anche patriarcali — a volte dobbiamo ri-significare le cose. E ri-significare richiede mettere il corpo in processi che a volte fanno male. Tutte le volte che mi sono presa l’influenza, dovevo tornare al lavoro due giorni dopo. Amo la medicina tradizionale, i rimedi delle piante, perché contengono una saggezza incredibile e funzionano davvero, ma sono lenti. Non posso prendermi dieci giorni per riprendermi da un raffreddore, quindi assumo ibuprofene, ibuprofene e basta. E siamo praticamente dipendenti, ma sembra necessario. Sono le richieste della nostra società, in cui non abbiamo le condizioni per fare le cose diversamente.
Mia nonna mi raccontava di come le vicine si riunivano per fare il pane e, mentre lavoravano, parlavano dei loro problemi. Dobbiamo riunirci e parlare, perché quando lo facciamo, ci umanizziamo di nuovo. Ci riconosciamo. E credo che è lì che avviene la “trasformazione sociale”.
ASUNCIÓN MOLINOS GORDO
Sì — assolutamente. Recuperare legami reali, esperienze condivise. In fondo, è anche questo che costruisce identità: costruiamo identità collettive attraverso l’esperienza collettiva.