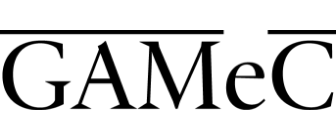VALENTINA GERVASONI
Questa conversazione nasce dal desiderio di esplorare modi consapevoli e non ingenui di abitare la montagna, modalità lontane dall’idea spesso stereotipata e convenzionale degli ambienti alpini come luoghi idilliaci, rifugi naturali alla frenesia urbana. Il dialogo seguirà due linee nello specifico: il cortometraggio MUT dell’artista Giulio Squillacciotti e il lavoro di ricerca sul design della curatrice Angela Rui. MUT racconta la ciclicità della vita in alpeggio e in particolare della tradizione casearia nel bergamasco attraverso l’esperienza di due giovani allevatori e dei loro genitori: una quotidianità scandita da azioni e da momenti che si ripetono dall’alba al tramonto e che mettono in luce sia la responsabilità precoce di Dario, tredicenne già coinvolto nella gestione del pascolo, sia lo sguardo spontaneo e affettuoso del fratellino Omar nel rapporto con gli animali. Puoi raccontarci com’è nato questo progetto e come sei entrato in contatto con i protagonisti?
GIULIO SQUILLACCIOTTI
Il progetto è nato con la commissione di GAMeC a lavorare su un film documentario per il Biennale delle Orobie che avesse come tema l’alpeggio nel contesto “orobico”. Conosco e frequento la zona da tempo – dalla Val Brembana alla Seriana fino alla Val di Scalve – e frequento la pratica documentaria con il mio lavoro, per cui l’unione tra i due ambiti è stata naturale. Nello specifico l’identificazione della Famiglia Mussetti come protagonista del documentario è avvenuta passo passo con l’aiuto della produzione di Lab 80 Film, dopo aver vagliato le varie opzioni di allevatori disposti a far parte del film. Mi sembrava interessante, anche prima di averli conosciuti, che fossero solo in quattro a gestire l’alpeggio: madre, padre e due figli piccoli di 12 e 6/7 anni. Così sono salito a luglio in alpeggio a conoscerli e ci siamo reciprocamente addomesticati sulle mie volontà cinematografiche e sull’effettiva capacità montana del mio passo – volevano assicurarsi che non avessi il passo del turista lento. Appurata la capacità di riuscire a star dietro al ritmo del lavoro in montagna e approvato il mio interesse a concentrarmi sui due membri della famiglia più giovani, a settembre – prima che iniziassero le scuole – sono risalito in alpeggio e lì sono rimasto per poco più di una settimana a girare, con la semplice regola del seguire passo passo le giornate e i diktat tecnici a lavorare in uno specifico formato e metodo di ripresa.
VALENTINA GERVASONI
Angela, tu ti occupi in maniera critica di modi nuovi e sperimentali di abitare lo spazio circostante, in un rapporto tra ambiente urbano e naturale che esplora i paesaggi lontani dalla percezione comune. Sostieni che il design contemporaneo debba essere “rigenerativo”, ovvero non solo rispondere a bisogni, ma produrre visioni che aiutino a ricostruire relazioni ecologiche più sane, ambienti più sostenibili, diritti tra specie, casa e spazio comune. Come si intrecciano le potenzialità del design con l’analisi del contesto naturale nella tua attività di ricerca?
ANGELA RUI
Definire cos’è natura è una questione che mi ha sempre affascinato. Spesso consideriamo la natura come tutto ciò che sta al di fuori di noi, come se fosse una dimensione esterna, separata dall’umano. Ma se dovessimo provare a definirla daremmo risposte molto diverse tra loro: potremmo parlare di oggetti naturali oppure di dinamiche relazionali, potremmo considerare natura come altro da noi o come qualcosa che riguarda strutturalmente il comportamento umano.
Se dovessi spiegarlo in parole povere, nel mio lavoro cerco di cambiare l’idea – piuttosto diffusa in Italia – del design come una serie di artefatti e di oggetti, per tornare invece al suo significato originario di progettazione. Se ci pensiamo, tutto è progettato: il mondo in cui viviamo è progettato, la conoscenza a cui attingiamo è progettata. La mia ricerca si fonda essenzialmente sulla volontà di capire se i mondi che abbiamo costruito possono essere decostruiti o possono essere riprogettati per sentire di appartenere loro.
Vorrei chiedere a Giulio in che modo hai concepito il tuo cortometraggio. In particolare penso al formato quadrato che hai utilizzato. Sin dal titolo — “monte”, in dialetto bergamasco — si evince il ruolo della montagna che, onnipresente, modella i ritmi e le esperienze di chi la abita. Nel film, tuttavia, questa resta sullo sfondo delle azioni dei giovani protagonisti. La tua è stata una scelta stilistica che rinuncia ai campi aperti e descrittivi per immergere lo spettatore in una prospettiva intima e guida l’attenzione verso i dettagli e le interazioni fra i membri della famiglia e fra loro e gli animali. La montagna dunque, non è rappresentata dal paesaggio. Da dove nasce questa decisione?
GIULIO SQUILLACCIOTTI
Nel mio lavoro cerco sempre di inserirmi nel contesto in cui opero, adottando un approccio che mi consenta di immergermi nella storia da raccontare riducendo al minimo i preconcetti. Il contesto, di conseguenza, diventa parte integrante della ricerca e ne orienta la forma. In questo caso volevo raccontare un paesaggio e un ambiente in cui si intrecciano molteplici dimensioni: la pratica millenaria dell’alpeggio, la ciclicità delle stagioni, le relazioni tra esseri umani e animali. Il mio intento era di concentrarmi su ciò che accade dentro questo mondo, su ciò che si manifesta quotidianamente al suo interno. Per questo il formato quadrato mi è parso il più adeguato. Passare da formati tradizionalmente associati alla rappresentazione del paesaggio – come il Cinemascope o il 16:9 – a un formato più contenuto come il 6×6 implica un cambiamento radicale: lavorare con diaframmi molto aperti e quindi con una profondità di campo ridotta. Le figure umane emergono in primo piano, mentre il paesaggio sullo sfondo si appiattisce, perdendo la sua funzione descrittiva. Ne deriva un rovesciamento del punto di vista: il paesaggio non è più qualcosa che si osserva, ma qualcosa che si incarna nei corpi. È come se le persone diventassero portatrici del mondo che le circonda, un mondo che non sempre vediamo, ma che possiamo intuire, immaginare, percepire attraverso di loro. La difficoltà principale di questo sistema è che richiede una certa stabilità dell’immagine, per cui ho dovuto correre con un cavalletto su e giù a seguire il ritmo reale del lavoro.
VALENTINA GERVASONI
Il cortometraggio mette in luce le contraddizioni insite in una convivenza che è al tempo stesso rispettosa e utilitaristica e permette di percepire la montagna come un ecosistema complesso in cui identità e interessi divergenti convivono e si confrontano. Da un lato il rapporto con gli animali, presentato come profondamente rispettoso, si intreccia con la realtà dell’allevamento produttivo, invitando a riflettere sulla relazione fra possibili modalità di sfruttamento e cura, coabitazione di spazi naturali e necessità di adattamento reciproco. Dall’altro, i turisti con il loro approccio episodico alla montagna attraversano il paesaggio come corpi estranei, enfatizzando il contrasto con la quotidianità operosa e silenziosa della famiglia in alpeggio. Questo inevitabile confronto diviene una rappresentazione delle diverse modalità di vivere e percepire la montagna: spazio di lavoro, radicamento e appartenenza, luogo di svago e fuga temporanea. In che modo, secondo la vostra esperienza, le diverse comunità si relazionano con l’ambiente naturale in generale e con quello alpino in particolare?
ANGELA RUI
Sembra stia prendendo sempre più forma all’interno dei contesti culturali in cui viviamo la necessità di fuggire dalle proprie vite che paiono non funzionare più. Per tornare invece a quello che pensiamo sia la natura, o meglio all’idea precostituita e idilliaca che abbiamo della natura. Poi accade che una volta arrivati nel luogo immaginato si percepisce un distaccamento tra ciò che abbiamo desiderato e ciò che la vita diventa in quel luogo. E spesso entra in gioco una dimensione che, per esempio, i bambini di città non conoscono: la noia.
GIULIO SQUILLACCIOTTI
Per quanto riguarda la necessità di abbandonare la propria vita in città, ho scoperto chiacchierando con Alessandro Mussetti, il padre della famiglia che ha l’azienda agricola, che spesso vengono contattati da persone che vivono a Milano e che desiderano organizzare una fuga nella natura, sporcandosi le mani con le bestie. Tuttavia una volta arrivati da loro in alpeggio, scappano dopo pochi giorni, rendendosi presto conto che la montagna può essere dura, che può essere un lavoro e non automaticamente uno svago. La montagna non è per tutti, è una questione di convivenza con le proprie necessità.
Anche questo aspetto della noia che sottolinea Angela è un aspetto molto interessante per me. Mentre eravamo su a girare con la famiglia Mussetti, abbiamo parlato di molte cose, ma la questione della noia non è mai emersa e forse perché non c’è semplicemente tempo di annoiarsi in quel contesto. Probabilmente la noia è propria delle società consumistiche che necessitano costantemente di qualcosa da digerire per restare attivi: la fagocitazione di beni, contenuti, di vizio. E in parallelo si ricerca un distacco dalla frenesia quotidiana andando alla ricerca di pratiche di meditazione con la mindfulness o lo yoga, che permettono di fare una sorta di temporanea pulizia nella mente. In alpeggio invece il ritmo del lavoro non concede tregua.
VALENTINA GERVASONI
L’idea di una riconnessione con la natura si traduce in altre parole in una fuga dal quotidiano, una ricerca di altrove, quindi rivela una tendenza a proiettarsi fuori dal proprio contesto. Come ha mostrato anche il film di Giulio, l’insistenza dei visitatori occasionali della montagna ribadisce costantemente questa distanza, questo desiderio di fuga che, paradossalmente, finisce per sottolineare ancora di più la differenza tra città e campagna, urbano e rurale, natura e cultura – invece che creare relazione.
Nell’osservare il fare e il disfare i contorni del pascolo, mi è venuto in mente Storia di linee di Tim Ingold, un testo che propone una riflessione sulle linee come alternativa all’immagine delle bolle, comunemente usata per descrivere persone e sistemi. La linea trova pieno compimento solo nell’annodarsi: un nodo che non dissolve le parti ma le mantiene vive, visibili, come relazioni generative. Il nodo diventa così non solo un dispositivo tecnico, ma anche simbolico: rappresenta l’atto di connettere, di stabilire relazioni che restano attive. Il nodo, le linee, le relazioni diventano così simbolo di un “vivere con”, piuttosto che di una somma indistinta. Il tema delle relazioni e della cura attraversa la ricerca di Giulio come possibile risposta a problematiche politiche e sociali di ampia portata. Non c’è una risposta univoca, siamo davanti a un terreno di tensione e conflitto: cosa significa prendersi cura? Nel caso di MUT, la cura non riguarda soltanto le relazioni tra persone, ma coinvolge anche altri esseri viventi e le componenti biosferiche e atmosferiche. Il film la racconta attraverso l’esperienza di due giovani allevatori e dei loro genitori durante i mesi d’alpeggio, mettendo in luce le contraddizioni insite in una convivenza che è al tempo stesso rispettosa e utilitaristica. Qui la cura non si riduce a una prospettiva intersoggettiva, ma si configura piuttosto nel riconoscere l’interdipendenza tra umano e non umano.
ANGELA RUI
Esatto, emerge il fare relazione sia con l’ambiente che con tutti gli esseri che in qualche modo lo abitano. Penso all’espressione making kin (fare parentele) di Donna Haraway, un’espressione che riflette questa rete di nodi, di relazioni di cui si fa parte. Stabilire una familiarità con altri esseri umani, non umani, ma anche con l’ambiente con cui interagiamo. Questa relazione è particolarmente pedagogica: imparare l’alterità, l’altro da me, arricchisce il proprio mondo relazionale.
Vorrei provare ad aggiungere altre due linee su cui ampliare il discorso, che sono parte del concetto di parentela e sono in modo diverso connesse con la trasformazione. Il primo aspetto riguarda il movimento verso un luogo che ancora non si conosce, uno spostamento che può essere fisico ma anche immateriale. Le idee cambiano continuamente, la nostra idea di natura ad esempio è in costante migrazione. E questo è uno spostamento immateriale. C’è poi un fenomeno chiamato “la discesa del bosco”, che descrive la discesa del bosco verso valle, uno spostamento non solo materiale, ma ecologico e adattivo. L’ingresso del bosco nella città cambierà le sembianze delle città e il rapporto che abbiamo con l’incolto. È anche una forma di resilienza necessaria, secondo molti. Questa idea di movimento, di migrazione, di transumanza è connessa anche al linguaggio. Anche il linguaggio muta in continuazione. Mi sembra questo sia un tema che Giulio osserva da molto tempo…
GIULIO SQUILLACCIOTTI
La migrazione del linguaggio è un aspetto davvero centrale per me: la lingua può diventare anche strumento di costruzione politica e non solo mezzo di comunicazione. In Europa, con l’avvento degli Stati nazione e dei loro apparati educativi monolinguistici, il multilinguismo diventa appannaggio dei più ricchi o viene considerato un’eccentricità. Tuttavia la compresenza di lingue e dialetti rimane un fatto naturale e pacifico in moltissime geografie, come accade in alcuni Paesi in Africa, nel Sud Est asiatico, in Nuova Guinea, ma anche in molte valli montane nel bergamasco.
I luoghi con la maggiore biodiversità sono spesso anche quelli con più alta diversità linguistica. Inoltre, la tendenza alla perdita di diversità linguistica va di pari passo con la perdita di biodiversità: questa crisi parallela dell’ecosistema e del glottosistema viene indotta dal processo di omogeneizzazione delle società umane, che va di pari passo con la globalizzazione economica.
In passato ho realizzato un film, What has left since we left, sulla fine fittizia dell’Europa, dove ho immaginato un incontro tra gli ultimi tre Paesi rimasti nel progetto Europeo. I tre si riuniscono per chiuderlo per sempre, coadiuvati da un interprete britannico che però traducendo in inglese porta il discorso in un’altra direzione, in una sorta di seduta di analisi collettiva. Il film nasce da una delle argomentazioni a cui ricorrono spesso i detrattori del progetto europeo, secondo i quali la babele linguistica condannerebbe l’Unione Europea all’insuccesso.
ANGELA RUI
Torno sulla ricchezza del linguaggio ma da un punto di vista non-umano, perché è un momento davvero interessante per portare in mondi più che umani il lavoro dell’interprete. In passato mi sono concentrata sull’addomesticamento degli oceani a partire dagli acquari domestici o urbani. Nelle case vittoriane l’acquario ha rappresentato un antenato della televisione, la prima forma di immagine in movimento. Di fatto la traduzione domestica dell’oceano mediata da un oggetto che ne conteneva una mise-en-scène artificiale ha formato un’intera cultura su come raccontiamo e rappresentiamo la vita marina. Ho avuto però l’occasione di conoscere il biologo marino David Gruber, che sta lavorando a un progetto a lungo termine in cui segue con un’équipe una famiglia di capodogli, con l’obiettivo di tradurre ciò che dicono, come lo dicono e cosa comunicano. Sono già riusciti a decifrare alcuni termini e la loro composizione, e hanno constatato che tra la specie esistono dei dialetti. Ciò che chiamiamo “verso” è una lingua altamente complessa che varia a seconda dell’ambiente e delle comunità che lo abitano.
GIULIO SQUILLACCIOTTI
Sì è ancora una volta un lavoro di traduzione, c’è un interprete che segue i capodogli e prova a stilare una sorta di Stele di Rosetta. Si tratta sempre di significare un segno, in questo caso sono i suoni di questi animali.
ANGELA RUI
Per restare nel territorio dei segni e riflettendo sui modi con cui costruiamo e percepiamo i nostri mondi, mi viene in mente Archipelago, il film che hai girato insieme a Camilla Insom. Ti va di raccontare di cosa si tratta?
GIULIO SQUILLACCIOTTI
Archipelago è un film documentario girato in Iran, in un gruppo di isole all’imbocco del Golfo Persico nello stretto di Hormuz, dove ora passano le petroliere. In queste isole vivono i discendenti di persone che furono vittime della tratta degli schiavi dal XVIII fino al XIX secolo, quando venivano forzatamente condotte dal Corno d’Africa attraverso la penisola arabica e fino in Persia. Quelle persone tradotte in schiavitù hanno portato con loro e mantenuto una serie di tradizioni e pratiche rituali, quelle che oggi seguono ancora i loro discendenti, abitanti delle isole. Nel film si parla in particolare del rituale Zār, originario del Corno d’Africa, volto a riconciliare lo spirito possessore e l’individuo posseduto attraverso musica e danze estatiche. Si ritiene infatti che ci sia una moltitudine di spiriti di provenienza e lingue diverse che può prendere possesso del corpo delle persone, una possessione non necessariamente negativa e spesso considerata permanente. Le pratiche connesse alla musica sono volte a chiamare questi spiriti e farli esprimere, forse proprio per convivere con essi. Il film parla di questi raduni a cui vengono invitate delle persone non tanto come individui, ma perché hanno presenti in loro determinati spiriti. Questi spiriti si spostano nel tempo e attraversano le geografie, assumendo caratteristiche sincretiche molto diverse: sono spiriti musulmani, perché presentano aspetti legati all’Islam e provenienti dalla penisola arabica, ad esempio connessi all’epica pre-islamica persiana; spesso hanno anche elementi tipici della tradizione cristiana, pur tenendo salde le proprie radici nella tradizione animista e spirituale di Paesi come Somalia, Sudan, Etiopia ed Eritrea. Il film parla di ciò che non si vede, di spiriti che esistono attraverso le voci delle persone che sono possedute da questi spiriti e della capacità di comunicare con loro attraverso la costruzione di un vocabolario condivisibile solo da pochi. Non possiamo sapere se questa credenza sia reale o una mistificazione, non possiamo certificare nulla e neanche mi interessa, ma credo che proprio questo sia l’aspetto più interessante. Noi occidentali ci interroghiamo analiticamente e abbiamo la necessità di spiegare tutto attraverso la scienza, ma quello che abbiamo registrato e compreso attraverso Archipelago è che non è sempre necessario chiedersi se sia vero o no: se sta succedendo davanti ai miei occhi allora esiste.
ANGELA RUI
Tutto ciò che sento, esiste.
VALENTINA GERVASONI
C’è un aspetto di MUT che vorrei ancora portare alla luce. Gli animali, gli allevatori e i trekker, con il loro abbigliamento dai colori sgargianti, entrano ed escono dalle inquadrature rigorosamente fisse, quasi fossero finestre che si aprono improvvisamente su scene di vita in alpeggio. Le azioni sono riprese con una lente documentaristica che pare enfatizzare la ciclicità e il loro essere ogni giorno uguali a sé stesse. Anche il sonoro, che fonde voci umane con i suoni naturali e degli animali, sembra restituire un ulteriore livello narrativo.
GIULIO SQUILLACCIOTTI
Se penso al film e in particolare alla forma documentario, che dovrebbe riprendere fedelmente la realtà e i comportamenti in modo diretto, naturale, bisogna ricordarsi che si tratta di un’aspirazione falsata, perché già solo la presenza di un obiettivo, che riprende un soggetto, influenza il contesto, distruggendo l’illusione di naturalezza. Nel film i bambini sembrano comportarsi con spontaneità, in realtà prima di iniziare le riprese sistemavo il setting e dicevo loro ad esempio il punto esatto in cui fermarsi rispetto alla camera. Ben presto però si è creato uno strano connubio tra le indicazioni registiche e la spontaneità dei ragazzi. Se all’inizio chiedevo loro di aspettare che li raggiungessi con la camera, intervenendo così sulla loro spontaneità, dopo un poco avevano capito il gioco e seguivano i miei ritmi, ma poi riprendevano come se niente fosse con le loro azioni abituali, ad esempio a mettere il filo del recinto e spostare gli animali.
Se consideriamo il nostro contesto culturale di riferimento, siamo abituati a concepire il tempo come una linea: una freccia che procede da un’origine, un anno zero, e divide ciò che è avvenuto da ciò che verrà. È una convenzione che ci aiuta – non solo graficamente – a collocare gli eventi e a dare loro un senso narrativo, ordinato, retrospettivo. Questa idea di tempo lineare informa anche il modo in cui raccontiamo la storia, come un percorso che avanza, un prima e un dopo. Per MUT, invece, abbiamo voluto lavorare in un’altra direzione: quella della ciclicità, della ripetizione, del ritorno. Inizialmente partendo dai ritmi stagionali dell’alpeggio, poi restringendo progressivamente lo sguardo fino a racchiudere tutto in una sola giornata. Una giornata che diventa allegoria di un’intera stagione, o forse di un intero ciclo di vita.
Quando si vive in alpeggio, ci si accorge presto che i giorni scorrono uguali a se stessi: cambiano il tempo atmosferico, le luci, gli umori, ma i gesti restano gli stessi. Il tempo non procede, ruota. E in questa rotazione si svela una forma diversa di racconto: non più la cronologia degli eventi, ma la persistenza dei gesti, delle relazioni, delle presenze. Una temporalità che non separa il prima e il dopo, ma li fa coesistere continuamente.
La temporalità della narrazione viene scandita anche attraverso il suono. Con Nicola Ratti abbiamo deciso di lavorare non solo sul piano della sincronizzazione del suono con le immagini -cosa comune nella traduzione tecnica del sonoro in un documentario-, ma di spostarci anche sul piano della finzione, aggiungendo elementi non sempre presenti nelle scene che vengono mostrate. Nello specifico abbiamo lavorato con il pitch, cioè identificando degli elementi costantemente presenti, come i campanacci delle mucche, e distorcendoli in alcuni punti del film in modo da creare delle cesure cicliche sulle fasi della giornata.
ANGELA RUI
È un aspetto che trovo molto interessante. Ho avuto l’occasione di curare recentemente la quarta edizione Porto Design Biennale che riflette sull’idea del tempo. Ci capita spesso di dire di non avere tempo, ma questa espressione, a livello profondo, testimonia il fatto che il tempo non ci appartiene più. Nella storia pre-industriale, il tempo non veniva rappresentato attraverso una linea, ma attraverso un cerchio. La ciclicità riguardava l’agricoltura e la pastorizia, ma anche il tempo astronomico. Una visione inserita nell’idea di eterno ritorno. Se ci pensiamo bene è simile al modo in cui diamo senso alle nostre relazioni, non solo con i nostri avi, famiglie, antenati, ma anche il modo in cui ci piace tornare nella familiarità di un vissuto. Carlo Rovelli, fisico quantistico, sostiene che il modo in cui abbiamo sempre immaginato il tempo – ovvero diviso in passato, presente e futuro – non esiste. Secondo la fisica quantistica, è solo un tentativo umano (di traduzione, appunto) di poter descrivere quello che accade e provando a collocarlo all’interno dei mondi che noi possiamo memorizzare, a cui possiamo dare una forma a cui tornare. Secondo la fisica quantistica invece questa divisione non esiste, esiste invece il tempo che è sempre presente. E viene percepito attraverso gli eventi, le sensazioni, le emozioni. Il lato più effimero dell’esistenza. Ma probabilmente la tecnologia più potente che abbiamo a disposizione per stare al mondo.