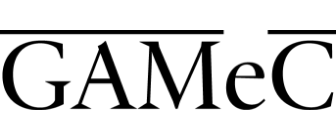GAIA FUGAZZA
Alice, mi piacerebbe condividere alcune riflessioni sul mio lavoro, Mother of Millions. Quando lo descrivo, spiego che il titolo deriva dal nome della pianta, conosciuta anche come “spina dorsale del diavolo”. Tuttavia, il titolo spesso confonde le persone, soprattutto quelle che non hanno visto la scultura dal vivo. Tendono ad associare il termine “madre” a una donna e spesso descrivono l’opera come la rappresentazione di una figura femminile. Ma per me è semplicemente un corpo, di cui non conosco il genere e che non ho mai voluto definire. Ecco perché ho pensato che sarebbe stato interessante parlare con te: grazie al tuo lavoro, forse potresti dirmi qualcosa di più sulla tua pratica.
ALICE KENTRIDGE
Mi interessa molto parlare di quest’opera e della tua idea di essa come “monumento alla cura”, e di come renda più complesso il significato stesso di cura. Sono una psicoterapeuta che lavora all’interno della tradizione psicoanalitica, pur mantenendo un atteggiamento critico nei suoi confronti. Scrivo e insegno anche psicoterapia, e mi interesso in particolare alle questioni di genere e sessualità. Molti dei miei pazienti sono persone queer o trans, quindi mi trovo spesso a riflettere su cosa venga considerato maschile o femminile, materno o paterno. Si tratta di concetti centrali nella psicoanalisi, concetti che sono stati esaminati, criticati e ripensati molte volte. Penso che la tua opera offra un terreno fertile di confronto su questi temi. Puoi parlarmi di come è nata?
GAIA FUGAZZA
Quando ho iniziato a pensare a quello che sarebbe poi diventato Mother of Millions, mi trovavo in una residenza d’artista in Val Taleggio, nelle Alpi Orobie, ospite di un’organizzazione chiamata NAHR – Nature, Art & Habitat Residency. NAHR si occupa di ambiente invitando artisti e architetti a riflettere su questioni ecologiche legate ai paesaggi montani. Mentre ero lì, mi sono resa conto che quello che spesso viene percepito come un paesaggio alpino naturale, porta in realtà le tracce della presenza umana – una presenza antica, che da millenni modella il territorio.
Negli ultimi anni, la popolazione delle Alpi, in particolare in quelle zone, è diminuita. Questo spopolamento, in controtendenza rispetto ad altre parti del mondo, ha avuto quello che molti considerano un impatto negativo sull’ambiente. Gli esseri umani hanno tradizionalmente svolto un ruolo essenziale nel mantenimento dell’equilibrio ecologico delle montagne: ad esempio, portando il bestiame dai fondovalle agli alpeggi. Mantenere aperti questi pascoli a determinate altitudini era importante per la biodiversità, perché quei prati ospitano una grande varietà di fiori, insetti e piccole piante. Ora, con l’abbandono, le foreste stanno riconquistando quei prati d’alta quota. Tuttavia, spesso non si tratta di foreste autoctone, ma di specie che hanno colonizzato l’area più di recente, le cui chiome, che possono essere molto fitte, impediscono la crescita di gran parte della vegetazione sottostante.
Mentre ero lì, mi sono anche resa conto che, con il declino e l’invecchiamento della popolazione autoctona, è arrivata una nuova popolazione, composta principalmente da richiedenti asilo. La loro presenza ha portato nuova vita a queste comunità montane: ci sono di nuovo bambini, e persone diverse che sono stabilite lì, forse non per scelta, ma che comunque ci sono.
Traendo ispirazione da queste due realtà e dalla pianta “madre di milioni” (Kalanchoe daigremontiana), una succulenta originaria del Madagascar, quindi per nulla autoctona delle Alpi, ho creato questa scultura. La pianta mi ha affascinato perché si riproduce asessualmente, generando piccole piantine sulle sue foglie che danno vita ad altre piante cadendo a terra. Le foglie si protendono verso il cielo come braccia aperte. Si riproduce in modo diverso, quasi provocatorio. Ho voluto creare un monumento alla cura e alla forza che nasce dalla cura. Forse anche un monumento a una forma di riproduzione che avviene in modo diverso, che non si interroga su come o perché abbia luogo, ma semplicemente continua.
La scultura è un corpo realizzato in terracotta di Impruneta. La sua forma riunisce elementi di molti corpi diversi. Ha i piedi di un bambino; la posa ricorda un serpente che si solleva o una posizione yoga. I piedi sono paffuti, le caviglie morbide, mentre le braccia e la schiena sono forti e muscolose. Il corpo ha una parte inferiore più morbida, un seno piccolo e l’altro lato del petto è piatto. Il collo è largo, i capelli corti e irregolari, e le braccia sorreggono un gruppo di piccole creature in fase di sviluppo, simili al corpo principale, ma non ancora pienamente formate. È come se la figura fosse “incinta” attraverso le braccia: una madre non dell’utero, ma del gesto e del tatto. Non c’è utero, non ci sono genitali, né un sesso definito.
Ho letto un tuo articolo di qualche anno fa, Making Breasts, Making Meaning: Psychoanalytic Metaphors and the Real, che ho trovato affascinante, in particolare ciò che scrivi sul modo in cui le metafore psicoanalitiche influenzano la percezione del corpo fisico nello spazio.
ALICE KENTRIDGE
In quell’articolo riflettevo sulla metafora psicoanalitica del seno — il “seno buono” e il “seno cattivo” — come modo per descrivere come un bambino sperimenta la cura o la sua assenza. Il seno, come metafora, rappresenta molte forme di cura: essere tenuti in braccio, sentirsi al sicuro, essere nutriti. Ma spesso troviamo difficile rimanere nell’ambito metaforico: si tende a scivolare verso il letterale, come nell’idea che sia buono allattare al seno e cattivo non farlo, o che i bambini abbiano bisogno di madri e di figure femminili che si prendono cura di loro. Queste idee possono facilmente diventare normative: che i corpi debbano avere un certo aspetto, o che il seno vada protetto perché “luogo” della cura.
In origine, la metafora aveva lo scopo di descrivere un senso di cura molto più ampio, qualcosa di relazionale e aperto. Le metafore psicoanalitiche mi attraggono molto: pensare per metafore fa parte del mio modo di lavorare. E questo lo vedo anche nel tuo lavoro: il senso del gesto, delle forme e delle relazioni metaforiche tra gli elementi. Ma mi chiedo anche cosa facciano queste metafore. È interessante, come hai detto, che la tua scultura venga spesso percepita attraverso la lente della “madre” o della “donna”. È come se lo spettatore non potesse fare a meno di imporre un altro seno alla figura, o di immaginare genitali che non ci sono, proiettando sull’opera le proprie idee di maternità o femminilità.
GAIA FUGAZZA
Penso che ci sia una grande differenza tra chi ha solo letto di un’opera e chi l’ha vissuta di persona. Quando si vedono solo delle fotografie, è più facile lasciarsi guidare dal titolo, Mother, e supporre immediatamente: “Madre è una donna”. Ma per me Madre è, forse, una presenza che si prende cura, o forse nemmeno questo. Non so cosa sia Madre. È semplicemente il nome di una pianta, e la pianta stessa non ha genere. L’installazione solleva una serie di domande: a chi è rivolta la cura? A chi è assegnato il compito di prendersi cura?
Lavorare su questa scala era una novità per me. Trovandomi davanti a qualcosa di più grande di me, ho iniziato a percepirne la superficie — la pelle, la carne — quasi come un paesaggio. Diventa innegabile, ha un peso. È molto diverso dalle opere più piccole, che si possono comprendere più facilmente — visivamente o persino fisicamente — e contemplare da una certa distanza.
ALICE KENTRIDGE
L’idea di cosa sia una madre mi fa pensare alla teorica Alexis Pauline Gumbs, che scrive molto sul concetto di mothering (l’agire materno). È interessata a mother come verbo piuttosto che come rappresentazione, ruolo o identità. Per lei, mothering è qualcosa che tutti possiamo fare, o dovremmo fare, o che comunque siamo capaci di fare. Non riguarda necessariamente il desiderio o la possibilità di avere figli.
Penso che questo si colleghi ad alcune delle idee sulla natura e sull’ambiente presenti nel tuo lavoro: il senso di responsabilità di fare da madre al mondo, al pianeta, alle persone e agli esseri con cui siamo in relazione. Non deve essere prerogativa della madre o della maternità. Gumbs si chiede: «Cosa significherebbe considerare la parola madre non come identità di genere ma come azione possibile, come tecnologia di trasformazione?»
Stavo pensando a ciò che hai detto prima riguardo alle persone che portano gli animali su e giù per le Alpi. Anche quello può essere visto come una sorta di “tecnologia di mothering”, una forma di accudimento, di cura attraverso l’azione, piuttosto che un ruolo fisso.
GAIA FUGAZZA
Sì. Ieri stavo leggendo l’articolo che hai scritto con Iggy Robinson, Queer Relationships: Unmapped Intimacies. Scrivete che «le famiglie queer si formano ma non sono fisse». Descrivete come queste relazioni siano sempre in divenire, perché non esiste un modello prestabilito per una famiglia queer: nessun precedente codificato, nessun modello genitoriale o struttura definita come il matrimonio. Continuano a cambiare. E questa consapevolezza di una continua creazione e ricreazione rende il cambiamento stesso più accettabile.
Questo mi ha fatto riflettere su alcune idee di conservazione applicate alla natura. La natura, la cultura, il paesaggio e la lingua sono in continuo mutamento. Quindi, quando parliamo di preservare o proteggere un ambiente, una cultura o una lingua, si tratta sempre di una scelta politica, una decisione di fissare qualcosa che è, per sua natura, dinamico.
Ad esempio, quando diciamo di voler riportare un paesaggio danneggiato al suo “stato naturale”, tale stato è di per sé una costruzione, un momento storico specifico che scegliamo come riferimento. Ciò non implica che il ripristino o la cura della terra siano privi di significato. Al contrario, sono essenziali. Ma insistere sul fatto che un paesaggio debba apparire in un certo modo, o essere abitato solo da determinate persone perché loro erano lì prima, o da determinati animali perché loro erano lì prima, è una posizione politica come qualsiasi altra. Non esiste uno stato di natura perfetto e originario. E quando vengono fatte affermazioni di questo tipo, spesso nascondono connotazioni piuttosto conservatrici, persino fasciste.
ALICE KENTRIDGE
Questo mi fa pensare al mio lavoro di terapeuta e alla fantasia che a volte abbiamo di poter riportare qualcuno a uno stato di benessere puro, come se fosse possibile annullare il danno, tornare al passato, trovare l’origine del problema e cancellarlo. Ma è impossibile. La relazione terapeutica può cambiare le cose, ma ciò che fa è sempre svelare qualcosa di nuovo.
Eppure, quel desiderio — di ritornare a un tempo mitico e puro — è radicato profondamente e vive in noi.
Quando mi mostravi le immagini della tua opera, mi ha colpito il modo in cui descrivevi la pittura del paesaggio sul corpo. Puoi raccontarmi qualcosa di più?
GAIA FUGAZZA
Inizialmente avevo pensato di realizzare la scultura utilizzando un’argilla diversa, un gres giallo sabbia, ma mi sono presto resa conto che non sarebbe stato tecnicamente possibile con il forno che stavo usando. Così ho deciso di lavorare con la terracotta di Impruneta, un’argilla molto semplice, composta da terra impastata. È ricca di impurità e il contenuto di sale aumenta durante la cottura, ma richiama troppo l’immaginario dei vasi da fiori, essendo l’uso più comune di questa argilla. Perciò l’ho modellata lasciandola grezza, con le impronte delle mie dita, in modo da rendere più visibile il contenuto di sali, e sono intervenuta con pigmenti in polvere e incisioni sulla superficie del corpo. Ho raffigurato scene di transumanza, la migrazione stagionale degli animali dal fondovalle ai pascoli più alti, e dei numerosi elementi che partecipano a quel movimento: i fiori dei pascoli, i cani, il cielo, le persone e le mucche. È diventato un ritratto di questa azione, del paesaggio e dei corpi che lo modellano, distribuiti sulla superficie della scultura. Queste tracce impresse nell’argilla evocano un linguaggio arcaico, richiamando alla memoria le incisioni rupestri: i primi gesti con cui le comunità umane hanno inscritto la propria presenza nel mondo.
Quella che era iniziata come un’intuizione tecnica è diventata anche una scelta concettuale. Quando entri nella stalla, non ti trovi solo davanti a un corpo con un paesaggio dipinto sulla schiena: lo sfondo stesso – la stalla, la montagna – è altrettanto importante. Il paesaggio è contemporaneamente attorno e sul corpo, e il corpo diventa lo scenario in cui può accadere qualcos’altro. C’è una sorta di proiezione reciproca tra il paesaggio e il corpo, tra il corpo nel paesaggio e il paesaggio sul corpo. Mi ricorda quanto siamo permeabili: al nostro ambiente, alle altre creature, gli uni agli altri.
GAIA FUGAZZA
Sì, adoro questa idea di reciprocità, di cose che si muovono in avanti e indietro. Quando parli di Mother of Millions nelle Alpi, sembra quasi che siano le Alpi stesse la “madre di milioni”. Ma poi sono le persone a prendersi cura della montagna, a fare da madre all’ambiente. La montagna è natura, ma l’uomo opera come sua tecnologia e al tempo stesso la montagna diventa una sorta di ambiente creato dall’uomo, o almeno un ambiente metaforico.
Questo movimento di andata e ritorno mi affascina sempre. Volevo chiederti del gesto rappresentato nell’opera, quel sollevarsi, perché mi sembra al tempo stesso tecnicamente complesso e profondamente evocativo. La figura non è proprio in piedi, ma nemmeno saldamente seduta a terra; è sospesa in un momento intermedio.
Credo che quella posizione non sarebbe possibile per una persona reale. È una combinazione di diverse pose.
ALICE KENTRIDGE
È interessante, perché quando l’ho vista per la prima volta ho pensato: forse potrei farlo per un secondo, anche se, ovviamente, non potrei. Ma c’è una fantasia lì: il sé che si solleva, con queste braccia potenti, sorreggendo tutto anche solo per un istante.
GAIA FUGAZZA
Forse alcune persone molto allenate potrebbero riuscirci, io stessa quasi ci riesco, ma ciò che volevo rappresentare erano piedi rilassati, radicati a terra con grazia e naturalezza. La scultura è stata costruita partendo dai piedi, poi le ginocchia, che rimangono attaccate al suolo. Da lì si sollevano le cosce. Le ho realizzate separatamente e la sfida tecnica più grande era far sì che le due gambe, provenienti da direzioni opposte, si incontrassero correttamente ai fianchi.
Lo hanno fatto. E da quel momento in poi, l’opera è diventata un’unica forma. Il movimento ascendente inizia dai fianchi e sale. Le braccia, che portano tutte queste piccole creature, sembrano — e sono — molto pesanti. Anche questo fa parte della forza della scultura. Mi ricorda un uccello: quando le sue ali sono abbassate, sono troppo pesanti per muoversi, ma quando sono sollevate, pronte al volo, si percepisce un senso di potenziale, di energia latente.
ALICE KENTRIDGE
E quelle piccole creature lungo le braccia, i “germoglini”?
GAIA FUGAZZA
Le piccole creature sono solo parzialmente formate. Non hanno ancora braccia vere e proprie né tratti completamente sviluppati. Sono cosparse di pigmento giallo, quasi come polline. Sembrano interagire tra loro — parlano, si sdraiano una sull’altra, penzolano — come un gruppo di bambini o gattini. Non sono consapevoli dello sforzo necessario per essere portate, né di quello necessario per crescere. Ognuna ha il proprio compito, il proprio processo di formazione, eppure crescono insieme, occupando tutto lo spazio.
ALICE KENTRIDGE
Nella psicoanalisi, si parla spesso di “materno”non come identità, ma come capacità — qualcosa che si può avere in certi momenti, che si può perdere o che si può offrire agli altri, che tu sia maschio, non binario — indipendentemente dal genere. Parte di questa capacità consiste nel creare un “ambiente favorevole”, uno spazio in cui qualcosa possa accadere o svilupparsi. Essere abbastanza presenti e abbastanza assenti, in equilibrio.
Le braccia e le spalle della tua scultura sembrano offrire proprio quello spazio: un luogo in cui riposare, crescere, essere sostenuti. Le piccole figure incarnano magnificamente questa dinamica. Mi colpisce anche il gesto di sollevarsi. Vi percepisco sia ottimismo che sforzo. Per te quest’opera rappresenta un gesto di speranza — di potenziale — o parla più della tensione, della fatica necessaria a tenere tutto insieme?
GAIA FUGAZZA
Penso che sia entrambe le cose. Spero che la scultura trasmetta un senso di speranza — persino di celebrazione — verso l’accoglienza, la cura e il cambiamento, e un futuro comune che non assomiglia a nulla di ciò che conosciamo.
Si ricollega anche alla tradizione del monumento classico, non necessariamente in senso greco, ma come scultura pubblica. Quando ho ricevuto questa commissione, inizialmente volevo realizzare piccole opere nella natura. Ma poi ho pensato: sono una donna che realizza una scultura in un villaggio dove non esistono opere monumentali. Monumenti come questo di solito celebrano individui — quasi sempre uomini — raffigurati in piedi, soli ed eroici. Io volevo creare un monumento a qualcos’altro. E volevo collocarlo in una stalla, non in una piazza. Anche questa scelta, così come quella del museo di organizzare una biennale nei villaggi di montagna piuttosto che in una grande città, esprime già una visione diversa del futuro.
ALICE KENTRIDGE
Quando hai detto che l’opera riguarda, in qualche modo, l’accettazione del cambiamento, la cura e la trasformazione in qualcosa di inatteso o non cristallizzato in una forma pura, mi sono sentita profondamente coinvolta. Gran parte del mio lavoro riguarda proprio questo, soprattutto con le persone queer e trans. C’è l’idea di un cambiamento e di una trasformazione che avviene in modi incerti, imprevedibili o ancora sconosciuti. Qualcosa sta cambiando, ma non sappiamo ancora cosa diventerà. Non esiste un percorso chiaro che una relazione queer o un corpo trans seguiranno, eppure in questa incertezza c’è qualcosa di solido, persino generativo. Molto spesso il discorso sulla transessualità o sulle vite non normative continua a inquadrarle come se fossero “contro natura”, come un attacco alla natura o a qualcosa di puro o stabile. Ma, come dicevi, abbiamo sempre avuto un rapporto tecnologico, creativo e trasformativo con l’ambiente e con i nostri stessi corpi. Riconoscerlo è molto significativo: apre nuove prospettive, rende le cose più vive.
GAIA FUGAZZA
Nei tuoi scritti parli dell’ansia che alcune persone provano verso i corpi in transizione. È qualcosa che mi ha spesso lasciato perplessa. Perché alcune persone sembrano credere in un individualismo radicale, ma allo stesso tempo si sentono profondamente minacciate dal cambiamento di un’altra persona.
Tu lo descrivi come il desiderio di un ritorno a qualcosa di stabile, ma ciò che trovo stimolante è la possibilità che la transizione apre a tutti noi quando pensiamo ai corpi come entità in continua evoluzione e trasformazione. Nel tuo lavoro, colleghi questo concetto anche alla chirurgia, talvolta legata alla transizione di genere, altre volte al cancro o ad altre ragioni mediche. Mi affascina l’idea di un’alleanza tra queste esperienze: il fatto che tutti noi stiamo cambiando in molti modi e tutti possiamo scegliere — o non scegliere — di intervenire sui nostri corpi in modi diversi.
ALICE KENTRIDGE
Sì, in quel testo parlavo di diversi tipi di trasformazione corporea: dei corpi trans, in particolare della chirurgia al seno, anche delle mastectomie dopo il tumore al seno, e di come queste esperienze vengano percepite in modo così diverso, pur suscitando un’ansia simile. Ci mettono in contatto con qualcosa che ci appare minaccioso: la nostra stessa mortalità, o semplicemente il fatto che i corpi possano essere così diversi, che anche il nostro potrebbe esserlo.
Quando hai detto che non capivi bene quell’ansia, mi sono chiesta se fosse dovuto al fatto che lavori molto con l’argilla. C’è un piacere nel lavorare con qualcosa che può essere modellato e trasformato. Quell’atto di creare corpi, di plasmarli letteralmente, ti mantiene vicina all’eccitazione della trasformazione. Certo, il cambiamento comporta ansia e perdita, ma anche un senso di possibilità.
GAIA FUGAZZA
Sì, esattamente: cosa può emergere di nuovo? Che emozione. Senza negare la sofferenza o la difficoltà, c’è anche un senso di celebrazione: quali fantasie posso avere, quali idee, quali cambiamenti sono possibili? Non ci avevo mai pensato prima, ma è vero che i materiali che uso — argilla, cera, pittura — sono tutti estremamente reattivi. Ti danno un feedback immediato. Pianifico molto poco in anticipo; ho l’impressione che alcuni archetipi di immagini diventino opere quando prendono corpo nei materiali, e che i materiali mi guidino in direzioni diverse. Senza quell’incontro, quel momento imprevisto, non saprei come realizzare le opere.
Alcuni materiali, come la cera d’api o le ossa di calamaro, implicano anche una sorta di cura nel tempo. Devono essere accuditi da chi maneggerà l’opera in seguito. Le ossa di calamaro, ad esempio, sono fragili: se si rompono, qualcuno dovrà mangiare un nuovo calamaro, pulirlo e sostituire le ossa. Anche la cera deve essere mantenuta a una certa temperatura, né troppo alta né troppo bassa, qualcosa di simile alla temperatura del corpo umano. La fisicità del mezzo trasforma l’idea stessa.
ALICE KENTRIDGE
Quello che dici è molto vicino a ciò che cercavo di esplorare nel mio testo Making Breasts, Making Meaning. Come terapeuta, mi chiedo sempre: come possiamo prestare attenzione a ciò che le nostre metafore e le nostre teorie stanno facendo, a come plasmano le idee che portiamo nella stanza? Spesso cerchiamo di far rientrare le esperienze delle persone nella teoria, quando dovremmo invece sentire qualcosa insieme, lasciando che prenda forma.
È un lavoro che non passa attraverso il contatto fisico, ma possiede un “tocco psichico”, una sorta di gioco come quello che descrivi nel plasmare l’argilla. Stiamo modellando qualcosa insieme, provando a capire come possa muoversi e tenersi insieme.
Quando hai menzionato quei materiali fragili che richiedono cura, mi ci sono ritrovata. Tutti nella stanza della terapia sono entrambe queste cose allo stesso tempo: un materiale malleabile e mutevole con cui si può lavorare e un oggetto delicato e insostituibile che deve essere maneggiato con delicatezza. Le tue parole mi hanno fatto pensare alla fisicità di un processo che, in apparenza, è “solo parlare”.
GAIA FUGAZZA
Volevo chiederti proprio questo. Nella tua pratica psicoanalitica, il tuo lavoro si basa tutto sul linguaggio, giusto? Non c’è movimento, né contatto fisico. Ma se lavori con persone che stanno trasformando il loro corpo, cambiandolo fisicamente, dev’essere comunque un’esperienza molto corporea.
Ovviamente, tutti cambiamo. Invecchiamo, facciamo scelte diverse su come modificare il nostro corpo: con l’esercizio fisico, la dieta, la chirurgia estetica o anche solo con un taglio di capelli. Ma alcune persone affrontano queste questioni in modo più consapevole. Non è nemmeno una questione di essere una persona trans: si tratta di cambiare il proprio corpo.
Quindi mi chiedo: quando un paziente viene da te una settimana e poi la successiva, hai la sensazione che sia diverso? Che si muova in modo diverso, che appaia diverso, che sieda in modo diverso?
ALICE KENTRIDGE
È un’ottima domanda. Sì, la mia pratica si basa sulla parola, non c’è creazione artistica o contatto fisico, ma ho sempre resistito a questa cornice, all’idea che la terapia consista solo nel parlare. C’è molto altro che accade nella stanza: il semplice atto di stare con un’altra persona, di stare con un altro corpo.
Anche quando siamo semplicemente seduti insieme, c’è tutto un livello di lavoro non verbale: il modo in cui abitiamo lo spazio, quanto ci sentiamo a nostro agio seduti uno accanto all’altro, come percepiamo l’energia reciproca. Un paziente sta parlando di una cosa, ma su un altro piano io sto ascoltando come si sente nello spazio, come abita il proprio corpo, e come siamo in relazione l’una con l’altro. Nella stanza della terapia si parla spesso del corpo e del cambiamento del corpo: si fantastica, si immagina, ci si preoccupa, si pianificano alcuni passi pratici, si cercano informazioni. Ma a volte una persona entra e indossa qualcosa che non ha mai indossato prima, o semplicemente si sente diversa. Niente è cambiato esteriormente, eppure la sua presenza nella stanza è diversa, siede nella mia mente in modo diverso.
GAIA FUGAZZA
Mi puoi dire qualcosa di più sul concetto di mothering?
ALICE KENTRIDGE
Nella psicoanalisi? Sì. È una tradizione complessa. Da un lato c’è l’idea quasi stereotipata che la psicoanalisi attribuisca ogni responsabilità alla madre — una battuta, ma in parte anche vera. Questa disciplina tende spesso a tornare alle origini dell’esperienza individuale, mettendo in evidenza l’importanza cruciale delle prime relazioni di accudimento. Questo ha portato a pensare le madri come cause o soluzioni, ma in entrambi i casi come oggetti piuttosto che come soggetti.
Poi è arrivata la critica femminista, che ha insistito sul fatto che le madri sono persone con la propria psiche e la propria storia. Questo ha aperto a una comprensione più ricca della dinamica tra madre e figlio, non più centrata solo sull’esperienza del bambino.
C’è anche, come suggerivi, una tendenza a rimuovere la connotazione necessariamente di genere del mothering, a considerare il mothering come qualcosa che si fa.
GAIA FUGAZZA
Sì, di genere ma anche biologica. Ho trascorso gran parte dell’infanzia con i miei nonni; quindi, il loro mothering è stato sicuramente rilevante per la mia educazione, proprio come accade per altre figure di cura.
ALICE KENTRIDGE
Esatto. Gran parte della critica si concentra sul fatto che la psicoanalisi abbia interpretato il mothering in chiave di genere, finendo per rafforzare il modello della famiglia nucleare e per ignorare altre forme di relazione di cura e accudimento. Alcune teorie possono essere piuttosto dure nei confronti delle madri.
Quando ti formi come psicoterapeuta, rifletti profondamente su cosa significhi mothering, perché, in un certo senso, questa è la relazione che instauri con il paziente. E, ovviamente, anche gli uomini studiano per diventare terapeuti. In questo senso, Freud stesso potrebbe essere visto come la “madre di milioni per eccellenza”.
È una professione interessante, con una storia conservatrice riguardo al maschile e al femminile, al materno e al paterno, ma che al tempo stesso si è a lungo praticata in una dimensione non di genere, non biologica, ma simbolica. Permette al concetto di madre di diventare metaforico e fluido, aperto alla reinterpretazione.
C’è stata anche molta riflessione sull’ambivalenza materna, sul fatto che la madre non sia soltanto forza di nutrimento e vita, ma anche soggetto pieno di invidia, complessità, sessualità.
GAIA FUGAZZA
La pianta che ho usato è comunemente nota come “madre di milioni”o “spina dorsale del diavolo”. La avevo nel mio studio, cresciuta da poche piantine che avevo trovato per caso. Si è diffusa ovunque. Ho iniziato a capire quel duplice significato: da un lato il senso di fertilità, persino di eccesso; dall’altro l’ansia che accompagna il potere incontrollabile della riproduzione. È qualcosa che si può ammirare, ma anche temere.
ALICE KENTRIDGE
Sì, la tensione tra i due nomi è affascinante. Quando parlavi dei richiedenti asilo, pensavo a come un certo tipo di madre sia molto valorizzato nella società, mentre altre non lo siano affatto, percepite come eccessive, come “troppo” o in qualche modo sospette.
GAIA FUGAZZA
Non sono sicura che riguardi solo le madri. In Italia, più in generale, c’è stata preoccupazione per la bassa crescita demografica, specialmente in montagna, dove le scuole hanno chiuso perché non ci sono nuovi bambini. Allo stesso tempo, l’immigrazione è considerata un problema. Quindi viene da chiedersi: cosa si vuole davvero? La crescita demografica o un certo tipo di crescita demografica? Queste sono sfide reali. L’integrazione e una partecipazione sociale significativa richiedono sforzo, ma credo sia possibile costruire qualcosa di positivo.
ALICE KENTRIDGE
Pensando al tuo lavoro, mi è venuta in mente un’altra teorica: la psicoanalista Lisa Baraitser, che ha scritto molto sulla soggettività materna, ovvero la realtà vissuta dell’essere madre. Parla anche del tempo, in particolare nel suo libro Enduring Time, che esplora concetti spesso associati alla maternità. I capitoli si intitolano: Restare, Mantenere, Ripetere, Ritardare, Resistere, Ricordare, Rimanere e Terminare. Trattano tutti di cosa significhi restare con qualcosa, sopportare ciò che è difficile o apparentemente insopportabile. C’è un senso di forza, ma anche di sforzo laborioso, ripetitivo, a volte disperato, che mi fa pensare alla tua scultura.
Baraitser parla di una “pulsione materna di morte”. Nel modello freudiano, il materno è associato alla vita e alla riproduzione — le forze che sostengono la società — mentre la pulsione di morte è la spinta verso la non esistenza, la dissoluzione, la frammentazione o la distruzione. Baraitser propone una lettura materna di quella pulsione di morte: la possibilità che queste forze coesistano. A volte ciò che facciamo, dice, è semplicemente accompagnare un processo di declino. Dare la vita significa anche, in un certo senso, accompagnare un figlio verso la morte, pur sperando di non doverla mai vedere. L’idea di stare con qualcosa che non si può aggiustare. Forse è questa la mia lettura meno ottimistica della tua scultura. Ci sono cose che non possiamo aggiustare, ma che possiamo comunque conoscere e con cui possiamo stare.
In Enduring Time, Baraitser racconta di una donna che visita regolarmente un uomo nel braccio della morte. Non può cambiare la sua situazione o la durata insopportabile della sua vita, eppure continua a tornare. C’è una certa spinta a ritornare e stare con lui in quella realtà. Baraitser parla anche della psicoanalisi come di un tempo molto lento e ripetitivo, in cui forse qualcosa cambia, ma non si riesce davvero a vederlo né sentirlo, e la sensazione è che possa protrarsi molto a lungo.
GAIA FUGAZZA
Sì, penso alle relazioni in un modo simile. Una domanda che mi pongo spesso è: quali relazioni contano di più nella vita? Nella tradizione conservatrice, la famiglia nucleare — le relazioni tra madre, padre, figlio, marito, moglie — ha la priorità, deve essere protetta dalle intrusioni e sostenuta, perché garantisce la continuità genetica e la promessa di un futuro. Guardare oltre, dare valore ad altri legami, è spesso visto come trasgressivo. Eppure, molte relazioni possono essere altrettanto importanti. Il ruolo di madre può essere assunto da persone diverse; un amico può essere più importante di un partner.
Non credo che la famiglia nucleare debba essere difesa a tutti i costi. Lo dico come madre di due figli biologici, ma riconosco che il discorso politico è sempre più ossessionato da quell’ideale, come se volesse ricordare alle persone di preoccuparsi solo di quel nucleo.
ALICE KENTRIDGE
Sì, quel modello chiuso della famiglia nucleare contrasta con la tua Mother of Millions, che invece apre le porte.
GAIA FUGAZZA
Proprio così. In Italia, ad esempio, il governo ha recentemente deciso di eliminare l’educazione sessuale dalle scuole. Ci sono stati anche casi preoccupanti riguardanti la revoca di alcuni diritti delle madri lesbiche. Quando si sente parlare di “famiglia naturale”, sorgono delle domande: cosa c’è di naturale nelle relazioni, nei corpi, nel genere? Anche la parola “naturale” può essere pericolosa. Può essere usata per giustificare l’esclusione o la violenza contro coloro che non rientrano nella sua definizione ristretta.
ALICE KENTRIDGE
Sono contenta che tu abbia sollevato la questione dell’attuale momento politico. Si avverte un clima pesante, con un’ansia crescente riguardo ai rifugiati e alle identità queer e trans. Tuttavia, il tuo lavoro allude anche a una scala temporale molto più ampia. Quando parli delle Alpi, evochi un luogo con una profonda storia umana, che in qualche modo allevia quel peso. Le braccia forti della scultura sembrano risolute, come a dire: è un momento difficile, ma lo affronteremo insieme. C’è un senso di resistenza condivisa, di sostegno reciproco. È commovente. Mi piacerebbe vedere la figura dal vivo.
GAIA FUGAZZA
Dovresti farlo. Fermati davanti ad essa per un momento. L’opera è installata in una stalla, del tipo utilizzato per conservare il fieno. Queste strutture sono l’architettura storica delle valli alpine, originariamente adibite a ospitare gli animali, soprattutto mucche. In genere hanno due piani: quello superiore, più ampio, per il fieno, e quello inferiore, simile a una grotta, per gli animali durante l’inverno. Tradizionalmente, il pavimento tra i due piani è costituito da assi sottili simili al bambù, per permettere al respiro degli animali di asciugare il fieno sopra di loro.
Per gli italiani, spesso cresciuti nell’ambito del simbolismo cattolico, la stalla evoca la Natività, la mangiatoia riscaldata dal respiro della mucca e dell’asino. Trovare lì non Maria e Gesù, ma una creatura nuda e ambigua conferisce allo spazio una strana sacralità. La stalla inizia ad assomigliare a un tempio. Mentre la realizzavo, pensavo anche ai Buddha monumentali, figure sedute a gambe incrociate all’interno di piccole cornici architettoniche. Sculture imponenti collocate in spazi contenuti. Il mio lavoro porta una risonanza simile: evoca riferimenti religiosi, ma senza appartenervi.
ALICE KENTRIDGE
Adoro questa conclusione. Una Maria selvaggia e aliena. Una scena di riproduzione asessuata nella stalla.