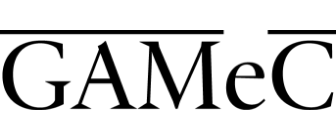Cara Montagna è una corrispondenza.
È una conversazione che cerca di restituire reciprocità alla montagna a cui, per due anni, abbiamo teso sguardi e pensieri: tra parole e paesaggi, tra chi scrive e ciò che la abita. È scrivere una lettera sapendo che, in questo caso, la risposta, se arriverà, sarà fatta dell’acciottolare delle pietraie, del crepitio dei passi sul sentiero, del gorgoglio nascosto di una sorgente.
Se il secondo episodio di questa serie di podcast approfondisce la tensione relazionale che emerge tra chi cammina in montagna e il suo ambiente, ora lo sguardo si sposta sull’intreccio materiale, affettivo e politico che connette diverse comunità. Una prospettiva ecologica, politica, post-umana che considera l’essere umano come perennemente interconnesso alle agentività animali e degli ambienti.
La nostra corrispondenza è dunque anche il corrispondere, il corrispondersi, è leggere il vorticoso paesaggio presente attraverso il rapporto reciproco fra elementi diversi, attraverso le alleanze che corpi umani, animali, ambientali costituiscono.
Cara Montagna sarà presto online. In attesa del suo lancio, pubblichiamo la trascrizione della conversazione tra Ilaria Gadenz e Cecilia Guida, una delle voci del terzo appuntamento.
Cara Montagna è un podcast curato da Ilaria Gadenz, ideato con Valentina Gervasoni.
ILARIA GADENZ
Vorrei partire dal tuo testo Comunità al Centro. Pratiche partecipative e spazi generativi nell’arte contemporanea. Seguendo l’etimologia della parola, scrivi che ciò che la comunità condivide non è qualcosa in più, ma qualcosa in meno, un debito. Potresti approfondire questo concetto, anche alla luce della reciprocità obbligatoria della sua radice munus, e dell’idea di paradosso del dono, così come ne scrive Derrida?
CECILIA GUIDA
Mi riferisco a un’idea di comunità che viene dall’etimologia latina, communitas, così come la analizza il filosofo Roberto Esposito. In questa prospettiva, il munus (radice della parola) non è un dono gratuito e disinteressato ma un dono particolare: un dono-obbligo, un gesto di apertura all’altro che crea una relazione, e che porta con sé un debito da restituire.
Il debito di cui parlo non è qualcosa di negativo ma è ciò che lega gli individui tra loro, un impegno reciproco che li espone l’uno all’altro. È un “mancare” qualcosa, un vuoto da colmare attraverso la costruzione di un legame, l’attivazione di uno scambio continuo che non si chiude mai.
Questo sposta la comunità dal piano identitario o proprietario a quello relazionale e processuale.
Il “debito” però – se lo guardiamo alla luce di Derrida – si complica. Derrida, infatti, dice che il vero dono è impossibile perché nel momento in cui si dona, si crea un obbligo, un debito appunto, e questo rende il dono qualcosa di economico e di calcolabile.
Per Derrida, un vero dono dovrebbe essere totalmente gratuito, senza ritorno e senza neanche il riconoscimento di aver donato. Ma questo, in pratica, è impossibile ed è qui il paradosso: nella sua capacità di risultare contemporaneamente qualcosa che è ma anche qualcosa che non è, essere e non essere insieme. Potremmo dire che la comunità è questo paradosso vivente: un luogo in cui il dono puro è impossibile perché il donare appartiene a tutti noi, ma proprio il continuo scambio, la struttura relazionale tiene insieme le persone.
ILARIA GADENZ
Continuando sulla scia di Derrida con l’idea che il dono, appena sia intenzionale e ve ne sia riconoscimento, sia contaminato ed entri in un’economia, ti chiedo se si può pensare a forme comunitarie che esistano fuori dal calcolo e dalle logiche dell’economia e in che modo l’arte (partecipativa) ha lavorato su questo confine?
CECILIA GUIDA
Sì, credo che si possa pensare a forme comunitarie che si situano fuori dalle logiche del calcolo e dell’economia estrattiva, purché si riconosca che questo non significa essere “fuori” dall’economia in senso assoluto – le pratiche sociali, pur stando nel margine, sono nel sistema, sono parte di questo, non si può stare davvero fuori, – ma si può agire diversamente dentro l’economia.
È esattamente su questo confine che ha lavorato il collettivo indonesiano ruangrupa con Documenta 15 (Kassel, 2022), proponendo l’idea di lumbung – il granaio collettivo in indonesiano – come principio operativo, affettivo e politico. Il lumbung non era una semplice metafora ma una pratica concreta di redistribuzione delle eccedenze, di co-decisione e conseguentemente di cura. In questo senso, la comunità non era vista come uno strumento per aumentare il capitale simbolico ma come un sistema di relazioni che genera valore in modo non lineare, non competitivo, non misurabile né capitalizzabile.
Gli artisti partecipanti alla Documenta sono stati coinvolti attraverso reti di affinità, collaborazione e fiducia – l’approccio di ruangrupa era: “Make Friends, Not Art” –, secondo un modello curatoriale che ha sfidato i sistemi tradizionali di selezione – la loro selezione non è stata gerarchica ma rizomatica ed è avvenuta attraverso una rete di “lumbung members”, co-curatori a tutti gli effetti, che hanno invitato a loro volta artisti o gruppi. Una selezione, questa, che ha spostato il focus dalle opere monumentali per collezionisti o mercati alla costruzione di relazioni vere, di alleanze durature. E così nella Documenta 15 “Make Friends, Not Art” significava che l’arte diventa una scusa – non il fine – per intrecciare comunità, costruire legami, sostenere pratiche condivise. In questo modo, ruangrupa ha incluso in una delle manifestazioni artistiche più importanti di questa parte del mondo pratiche del sud globale che spesso restano fuori dai circuiti canonici perché non “performano” nel senso economico o spettacolare del termine.
Quindi, per rispondere precisamente alla tua domanda, Documenta 15 ha lavorato sul limite tra economia dell’arte e forme di mutualismo radicale, non per negare il contesto economico ma per disattivarlo parzialmente, decentrare la funzione autoriale e distribuire il potere curatoriale in modo realmente orizzontale – nella ruruHaus che era la sede operativa e sociale del team curatoriale, su una parete, c’era un enorme diagramma che mostrava tutte le fasi di costruzione della manifestazione – dall’incarico del collettivo come direttore artistico all’opening e oltre – e il modello di finanziamento distribuito ai “lumbung members” (attorno a 25.000 dollari ciascuno), con un fondo comune per i progetti condivisi. Questo diagramma era molto interessante perché per la prima volta nella storia della Documenta il pubblico conosceva il budget dell’intera manifestazione, come, quando e dove i fondi erano stati impiegati.
Documenta 15 è stato un esperimento che ha generato forti tensioni istituzionali e politiche ma che, a mio avviso, ha riaperto la possibilità di pensare la comunità come spazio non funzionale, non valutabile secondo logiche estrattive, eppure pienamente attivo sul piano culturale, sociale e politico.
ILARIA GADENZ
In Comunità al Centro scrivi di quei progetti partecipativi che creano spazi comuni di altro genere e qui usi genere nel senso di generativi, emancipatori, abbracciando l’idea di Derrida e Ronell secondo cui la partecipazione non è appartenenza. Potresti spiegarmi questo punto?
CECILIA GUIDA
Quando scrivo di “spazi comuni di altro genere”, mi riferisco a progetti partecipativi che non si limitano a riprodurre modelli istituzionali o relazionali preesistenti, ma che generano spazi fondati su nuove forme di relazione, nuove modalità di stare insieme, spesso ibride, aperte, informali.
Uso “genere” non tanto nel senso classificatorio, ma nel senso generativo, appunto, ispirandomi all’idea di Derrida e Ronell, delineata in un articolo pubblicato nella rivista Critical Inquiry nel 1980, per cui la partecipazione non si fonda sull’appartenenza a un’identità, a una comunità fissa, a un ruolo prestabilito – ma sul prendere parte, sul mettersi in gioco. È una distinzione importante: non si tratta di essere parte “di” qualcosa, ma di contribuire a farla esistere nel momento stesso della partecipazione.
In questo senso, i progetti partecipativi a cui mi riferisco generano comunità temporanee che non si definiscono per esclusione o per confine, ma per apertura e pratica condivisa.
Un esempio è Victoria Square Project, ideato dall’artista statunitense Rick Lowe in risposta all’invito a partecipare a Documenta 14, ospitata ad Atene nel 2017. Il progetto prende il nome dalla piazza omonima che nel 2015 divenne campeggio per rifugiati e migranti arrivati nella capitale greca, e quindi simbolo urbano di temi legati all’ospitalità, alla convivenza di culture diverse e alle relative tensioni sociali. Victoria Square Project oggi è uno spazio che esiste e funziona ancora, aperto a tutti gli abitanti della piazza, alle organizzazioni a sostegno degli immigrati e rifugiati, alle associazioni culturali per conoscersi e confrontarsi.
ILARIA GADENZ
Ci sono molte domande che emergono dal tuo libro, ne rilancio due: come dovrebbe essere reimpostata la relazione tra artista e comunità? e che responsabilità ha l’artista di fronte alla comunità che coinvolge?
CECILIA GUIDA
Quando si parla di “community-based art” non si fa riferimento a un format preconfezionato, a un modello che si ripete ma piuttosto a una categoria teorica e una pratica “critica” dove i livelli e la natura della partecipazione differiscono a seconda degli intrecci degli aspetti materiali con quelli immateriali (per esempio, storie e memorie, sia personali sia collettive), intrecci che avvengono nel contesto in cui l’artista opera. La pratica sociale è insistentemente locale nella sua portata, le relazioni sono consolidate di persona.
Certamente l’artista nella relazione con la comunità non è più solo autore ma i suoi ruoli si moltiplicano: la sua attitudine relazionale, direi anche la sua empatia, le/gli permette di rispondere (a proposito di responsabilità intesa come abilità a rispondere) a un contesto in cui è stata/o invitata/o a operare sentendo/intuendo/riconoscendo i desideri e le criticità di una comunità – l’ascolto è importante –, e quindi diventa anche un facilitatore-mediatore impegnato a sfidare le narrazioni dominanti e a progettare con la comunità situazioni che la comunità stessa può far proprie e continuare nel tempo.
L’autorialità è decentralizzata e l’artista diventa un tessitore di intrecci. Questa è la sua responsabilità – certamente mi viene incontro Maria Lai con l’happening collettivo del 1981 Legarsi alla montagna quando, venuta a conoscenza di una leggenda tramandata oralmente nel paese, Maria Lai invita le persone a “legare insieme” le case di Ulassai e a questa prima performance relazionale della storia partecipa l’intera comunità. L’artista come un tessitore di intrecci che costruisce mondi secondo una modalità dialogica, plurale, concreta.
Inoltre la responsabilità dell’artista di fronte alla comunità è processuale ed è durevole perché non termina con la presentazione dell’opera ma comprende anche la cura degli effetti sociali prodotti dall’opera.
Tanti sono i lavori a cui si può fare riferimento, tra questi la nota, così nota che non si può non citare proprio perché è la “madre” delle manifestazioni di arte negli spazi pubblici, “Culture in Action: New Public Art in Chicago”, curata da Mary Jane Jacob, avvenuta nel 1993 con un lavoro preparatorio iniziato due anni prima. I dieci artisti invitati entrarono in contatto con specifiche comunità della città, considerate come non interessate all’arte (donne, operai, adolescenti, malati), confrontandosi a lungo con loro su ciò di cui sentivano il bisogno o il desiderio e sul potenziale dell’arte di pensare e affrontare i problemi con uno sguardo diverso.
Tra gli interventi processuali realizzati, l’artista e teorica Suzanne Lacy – autrice dell’espressione “new genre public art”, l’arte pubblica di nuovo genere, ritroviamo il “genere”, in questo caso in risposta all’arte minimalista collocata negli spazi pubblici come fossero musei a cielo aperto – formò un comitato temporaneo di donne, dal nome “A Coalition of Chicago Women”, che nell’arco di due anni si riunì in via formale e informale arrivando alla decisione di celebrare cento donne che si erano distinte per il contributo dato alla società (in una città in cui non c’erano monumenti dedicati alle donne), attraverso cento massi di pietra con targhe in bronzo che riportavano i nomi delle prescelte e vennero disseminati per la città. Iñigo Manglano-Ovalle invece collaborò con la rete di organizzazioni educative per la scuola superiore operanti nel suo quartiere abitato prevalentemente da latini per realizzare Street-Level Video, un laboratorio video permanente concepito per consentire a gruppi di adolescenti di creare video che rappresentassero la loro vita e i loro interessi in modo più realistico e approfondito dei contenuti retorici e dei clichés veicolati dai media mainstream.
Un progetto community-based più recente, che ho seguito, è quello di Serena Crocco, dal titolo Via del Ricordo, avviato durante la residenza che ho curato a Casa degli Artisti a Milano tra il 2022 e lo scorso anno. Serena ha scelto di lavorare nel quartiere di Crescenzago nella periferia nord-orientale della città, concentrando la sua attenzione su uno spazio extra-ordinario: l’ex cimitero in via del Ricordo, in disuso e abbandonato da sessant’anni, con un progetto mirato a ricostruirne la memoria e a una progressiva e organica riapertura a favore del quartiere.
Attraverso momenti conviviali (c’è stato anche un pranzo della domenica davanti all’ingresso dell’ex-cimitero), laboratori, occasioni di scambio e raccolta di ricordi, articoli e fotografie l’artista ha coinvolto degli anziani del quartiere (che sono la memoria storica del sito) e dei bambini di una scuola elementare (che non hanno memoria ma potere immaginativo) in un riposizionamento dello sguardo collettivo su questo spazio dimenticato della città e in una profonda riflessione collettiva – ancora in corso – sul rapporto tra i luoghi della vita e quelli della morte.
ILARIA GADENZ
Come cambia il lavoro di comunità o come cambia il lavoro delle/degli artiste/i che si relazionano con l’idea di comunità di fronte all’ormai consolidata idea che non si possa parlare soltanto di comunità umana ma si debba necessariamente allargare il campo anche a tutto ciò che è non umano?
CECILIA GUIDA
Ti rispondo attraverso il laboratorio, perché il laboratorio è un momento centrale dei progetti relazionali e partecipativi in quanto rappresenta una modalità fluida di relazione tra artista e comunità.
Il laboratorio mette al centro il processo piuttosto che il prodotto e crea le condizioni per un apprendimento reciproco. Non è solo uno strumento operativo, ma un ambiente di possibilità dove l’arte partecipativa può esercitare la sua funzione trasformativa.
Di recente, insieme alle curatrici Giorgina Bertolino, Francesca Comisso e Alessandra Pioselli, ho lavorato alla prima monografia degli artisti Caretto/Spagna che ci hanno accompagnato nella curatela del volume che si intitola Bright Ecologies.
Nel mio testo rifletto in modo particolare sulla loro produzione laboratoriale, che è vasta e spesso dà origine alle opere, oltre a essere considerata opera essa stessa – per Caretto/Spagna infatti i workshop sono opere collettive che coinvolgono le persone e si sviluppano con loro.
Parlando di pratiche partecipative e comunità non umane, in Italia non si può non tener presente Caretto/Spagna che, nella loro ricerca e pratica artistica, sfidano l’illusione della nostra separazione, come esseri umani, dalla natura e invitano a esplorare, a muoversi nel mondo – l’abitare è una delle loro linee di ricerca – e a sperimentare modi diversi di percepire gli esseri viventi, umani e non umani, le cose animate e inanimate che lo abitano. Nei loro workshop avviene un processo conoscitivo per il quale “prima” le cose vengono percepite in un modo e “dopo” in un altro.
ILARIA GADENZ
Il lavoro di Caretto e Spagna sembra accogliere entrambi questi poli. Nell’introduzione al loro catalogo scrivono: “if the being exists only in a relationship then everything is ecological and every artwork is always collective”. Come definiresti le relazioni che si instaurano nei loro progetti?
CECILIA GUIDA
Caretto/Spagna sono filosoficamente vicini all’ontologia agerarchica di matrice deleuziana che afferma le differenze senza alcuna gerarchia e totalizzazione: per loro la vita è un sistema di relazioni, un flusso di energia che trasforma incessantemente la materia.
Quindi nei loro progetti la relazione è la forza generativa che plasma l’opera e trasforma chi partecipa.
In altre parole, come hai appena detto e lo scrivono nell’introduzione al volume Bright Ecologies “se l’essere esiste solo in relazione, allora ogni opera è inevitabilmente ecologica e collettiva”: nei loro lavori l’autorialità si distribuisce tra i partecipanti, le relazioni sono situate in contesti e tempi specifici, l’opera non è un prodotto ma un evento aperto a nuove configurazioni, a trasformazioni continue.
ILARIA GADENZ
Cosa si intende per artista come “agente morfogenetico”?
CECILIA GUIDA
Questa è una definizione di Caretto/Spagna che descrivono sé stessi non tanto come autori nel senso tradizionale ma come agenti all’interno di un sistema di relazioni materiali, viventi, ambientali.
Da artisti “prendono parte a” una rete ecologica e trasformativa che mette in dialogo elementi umani e non umani, processi biologici, dinamiche percettive, componenti geologiche etc.
Caretto/Spagna hanno anticipato di due decenni approcci e questioni ritenute oggi imprescindibili e fondamentali per una visione inclusiva della percezione e di interazione con il mondo, più vicina alla filosofia post-umanista che al dibattito critico sull’arte partecipativa e impegnata socialmente, che resta comunque iscritto nel paradigma umanistico novecentesco.
ILARIA GADENZ
Nella prefazione all’aggiornata versione di Artificial Hells di Claire Bishop, che tu hai tradotto, c’è il tentativo spiegare le ragioni della sparizione del concetto di partecipazione nel discorso critico degli ultimi dodici/tredici anni. Si parla di partecipazione e di come sia stata sostituita da termini che arrivano da altre epistemologie, da altre urgenze: cura, guarigione, rituale… La parola comunità che fine ha fatto? C’è una sovrapposizione totale tra partecipazione e comunità o si possono fare dei distinguo?
CECILIA GUIDA
Nell’introduzione alla nuova edizione aggiornata di Inferni Artificiali, pubblicata lo scorso anno dall’editore Luca Sossella, Claire Bishop menziona il fatto che negli ultimi dodici/tredici anni la parola partecipazione ha perso centralità nel discorso critico, ed è stata in parte sostituita da termini come cura, guarigione, riparazione, rituale. Sono parole che rispondono a urgenze diverse e in questo scenario la parola comunità non è scomparsa ma è stata sottoposta a uno spostamento semantico. Oggi si parla meno di comunità come soggetto unitario e più spesso in termini di molteplicità situate, alleanze temporanee, ecologie relazionali. La comunità non è più “il pubblico” da coinvolgere, come negli anni ’90 e 2000, ma una condizione fluida dentro cui si articolano pratiche artistiche partecipative, gesti di cura e forme di resistenza.
Quindi direi che la parola non è scomparsa ma piuttosto Claire Bishop ne fa riferimento in un modo più complesso, più cauto, forse più responsabile.
Rispetto alla sovrapposizione tra partecipazione e comunità, ti direi che non c’è sovrapposizione e che sarebbe meglio fare dei distinguo tra le due. Certamente è importante il significato che si dà alla parola partecipazione: come dicevo prima, con partecipare non intendo essere parte di qualcosa (posso partecipare o collaborare a qualcosa/un evento ma non sentirmi parte della comunità) ma piuttosto prendere parte alla creazione di qualcosa, di una comunità, è un processo in divenire per cui la partecipazione va messa in pratica perché sia generativa di comunità aperte e porose.
ILARIA GADENZ
Quali sono i principali rischi che Claire Bishop riscontra nella pratica artistica che si relaziona con le comunità?
CECILIA GUIDA
Per Bishop uno dei principali rischi nelle pratiche artistiche relazionali e partecipative che coinvolgono le comunità è l’eccessiva enfasi sull’etica a discapito dell’estetica. Cioè, il valore di un’opera viene spesso misurato in termini di buone intenzioni, di inclusività dimenticando però di valutare anche la forza simbolica, la forza critica e formale dell’intervento artistico – l’arte partecipativa non è solo un’attività sociale ma è anche una produzione simbolica, inserita nel mondo e allo stesso tempo separata da questo.
Un altro rischio è quello della strumentalizzazione delle comunità, è quello dell’estrattivismo: quando la partecipazione è solo un pretesto per legittimare un progetto o per produrre consenso attorno all’artista o all’istituzione promotrice. In questi casi, il coinvolgimento delle persone non è realmente trasformativo.
Bishop mette in guardia anche dall’estetizzazione del sociale, ovvero quando i conflitti reali vengono resi visibili solo per essere contemplati, senza generare un cambiamento o un vero spostamento di prospettiva. È il rischio di “rappresentare” la marginalità senza metterne in discussione le condizioni strutturali.
Infine, c’è un rischio politico più ampio: la partecipazione come forma soft di governance, in cui l’artista si trova a svolgere un ruolo da operatore/mediatore sociale assorbendo funzioni pubbliche lasciate scoperte dalle istituzioni.
In questo modo, l’arte rischia di diventare un “cerotto” simbolico a problemi sistemici. In Inferni Artificiali nel capitolo sei Bishop parla proprio di questo, con un intento provocatorio, attraverso l’analisi di quelle innovazioni artistiche che fiorirono nel Regno Unito negli anni ’70, sotto il governo conservatore di Margareth Thatcher (1979-1992), dal nome di “Community Arts Movement” (Movimento delle arti di comunità).
Quindi per Bishop nella relazione con le comunità va mantenuta consapevolezza critica, un’attenzione verso il potere perturbante e la tensione formale dell’opera evitando che la partecipazione diventi un fine in sé o un’etichetta rassicurante – e i lavori, i progetti, le performance che Bishop descrive nel libro sono stati scelti tenendo presenti proprio questi aspetti.
ILARIA GADENZ
Sto raccogliendo alcune definizioni di comunità. Potresti dirmi la tua?
CECILIA GUIDA
Ti rispondo ricorrendo alla letteratura. C’è un racconto di Raymond Carver che si intitola Cattedrale, che sempre consiglio alle studentesse e agli studenti all’inizio del corso all’Accademia di Brera dove insegno, perché esplora proprio la dimensione della condivisione che per me è centrale quando si parla di comunità.
In Cattedrale il protagonista – un uomo chiuso in se stesso, incapace di una qualsiasi forma di empatia – si trova a ospitare un amico cieco della moglie, all’inizio è a disagio ma quando i due si mettono a disegnare insieme una cattedrale succede qualcosa: lo fanno insieme, il protagonista guida la mano del cieco a occhi chiusi. Con questo gesto, elementare se vuoi, l’uomo vede per la prima volta attraverso la relazione, che genera in lui una trasformazione – avviene un’epifania.
Questo racconto, secondo me, descrive bene l’apertura all’altro, il passaggio dall’io a un noi costruito attraverso un gesto, attraverso un’esperienza condivisa.
Per me la comunità esiste, o meglio avviene – avviene mi sembra più pertinente perché libera la comunità dal vincolo del tempo duraturo e mette in relazione la sua creazione con l’avvenimento –, la comunità avviene in un luogo, simbolico, fisico e/o digitale, in cui si fa esperienza di vita insieme.