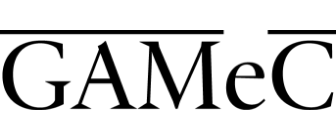In queste settimane, in seguito all’opening dei progetti del terzo appuntamento di Pensare come una montagna, ho avuto l’occasione di partecipare a tre delle quattro performance in programma fino a maggio nell’ambito della mostra Fossi io teco; e perderci nel verde curata da Greta Martina, vincitrice della XII edizione del Premio Bonaldi.
L’esperienza vissuta durante la partecipazione a questi eventi è stata intensa e mi ha portato a pensare e ripensare alla nostra idea di “Natura”.
Durante Superpaesaggio gli artisti Attila Faravelli, Enrico Malatesta e Nicola Ratti hanno guidato il pubblico nel Parco delle Rimembranze della Rocca, attraverso suoni prodotti creativamente con materiali trovati sul posto, che facevano risuonare in una medesima vibrazione corpi e luoghi, calando i presenti in uno stato contemplativo e allo stesso tempo profondamente attivo.
Nella performance di Valentina Viviani The Missing Forest sono stati i movimenti degli studenti del Politecnico delle Arti e il respiro immerso nei suoni della città a guidare i partecipanti da Città Alta al cortile della GAMeC, attraverso Via della Noca, fino alla mostra allestita in Spazio Zero.
Il silenzio, la profondità del respiro, i movimenti lenti che improvvisamente si congelavano in gesti significanti, fortemente comunicativi, sono stati la salda struttura di una performance che voleva essere anche un invito a guardare la città e “il suo verde” assente e presente, passato e attuale.
Il fatto che gli artisti, per le loro performance, abbiano scelto spazi urbani in cui storia e architettura si mescolano alla natura, senza “fuggire” verso il limitare dell’area urbana alla ricerca di spazi esclusivamente verdi, o quasi, o anche semplicemente senza prediligere i parchi urbani, mi ha dato modo di interrogarmi su questa scelta che inizialmente avevo trovato curiosa. E come spesso accade, quando qualcosa suscita curiosità, ecco che si affacciano le domande. Perché dovremmo pensare la città-cultura come qualcosa di separato dal verde-natura? Perché pensare alla natura solo nella dimensione circoscritta del parco urbano o del bosco in montagna?
Il 10 aprile abbiamo ospitato in museo Adriano Favole, antropologo autore di La via selvatica (Editori Laterza, Bari-Roma, 2024), che, in conversazione con Greta Martina, ci ha parlato del concetto di incolto, da lui definito come “uno spazio ad alta intensità di vita” (Adriano Favole, La via selvatica, p. 7).
A differenza di quello che accade nelle società occidentali, il concetto di “natura” concepito tradizionalmente in contrapposizione al concetto di “cultura”e dunque come un dominio separato e altro rispetto all’umano, è intraducibile nelle lingue delle culture oceane studiate da Favole, che invece possiedono il concetto di incolto, da intendersi in relazione non oppositiva con l’umano. L’incolto, per le popolazioni della Nuova Caledonia, è per esempio la foresta dove le persone fanno ritorno dopo la morte, o, di nuovo, la foresta dove i Kanak collocano le loro sculture antropomorfe quando decidono di spostarsi in un altro luogo da abitare.
La differenza sostanziale sta nella relazione, nel concepirsi come creature in connessione con il non-umano; nel pensare alla propria vita come interdipendente da una moltitudine di vite non-umane che ci permettono di respirare, di far crescere ciò che mangiamo, di fertilizzare la terra che coltiviamo, e via dicendo. Philippe Descola, celebre antropologo che più di tutti ha studiato la dicotomia Natura-Cultura, ha maturato il concetto di “ecologia delle relazioni” in seguito ai suoi numerosi anni di ricerca sul campo in Amazzonia fra gli indiani Jivaro-Achuar. Qui ha potuto osservare le relazioni degli amerindi con gli esseri non umani della foresta e dimostrare che l’opposizione occidentale tra natura e cultura in questo gruppo umano non esiste. Sicuramente è più complesso ragionare in termini di relazioni piuttosto che di opposizioni: il concetto di natura opposto a quello di cultura ha un che di tranquillizzante.
Noi del resto non ci curiamo dell’incolto se non per ingabbiarlo nei nostri progetti di addomesticamento e dominio, ma “l’incolto si cura di noi. Noi siamo l’incolto”, scrive ancora Favole (p.11). E ancora, “l’incolto non è il caos ma il grembo della madre Terra in cui la vita prende forma e si organizza” (p. 25).
A questo punto è lecito chiedersi se cercare la connessione con il verde, con l’incolto, il non umano, significhi perseguire l’idea romantica della fuga dal mondo per immergersi nella natura in solitaria. Fuggire quindi nella natura e finire per rimarcare nuovamente la distanza fra Cultura e Natura?
Adriano Favole, Valentina Viviani e gli artisti di Superpaesaggio, Attila Favarelli, Enrico Malatesta e Nicola Ratti, sembrano suggerire una via diversa, la via selvatica direbbe il primo esortando a riconoscere l’importanza del lato selvatico della cultura (p.118). Perché sebbene gli esseri umani siano creature simboliche, “la cultura umana ha un lato selvatico imprescindibile” (p. 123).
Come ci dimostrano le scelte di questi artisti, la natura, o, se vogliamo, l’incolto, il selvatico, non è necessariamente un altrove, ma è ciò che si manifesta sotto i nostri occhi, sul balcone di casa, lungo le strade, nei nostri giardini…ed è con questa natura intesa come forza generatrice, ha suggerito Favole durante l’incontro, che dobbiamo dialogare, entrare in relazione. Connetterci con la natura e percepirci come parte integrante di essa e non al di fuori, si traduce allora con il tentativo di “fare connessione” con il “verde” fuori e dentro la porta di casa.
Sara Fumagalli